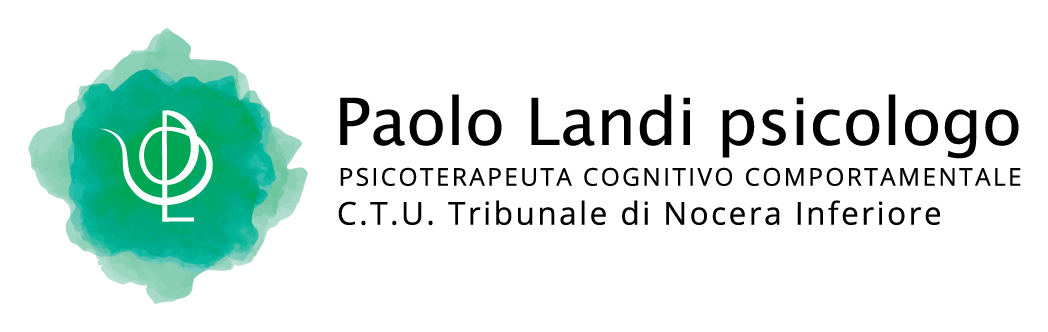Di seguito vengono presentati una raccolta di articoli scientifici in ambito psicologico. Tutti gli articoli sono disponibili per la visualizzazione e presentano la partecipazione del Dott. Paolo Landi, esperto psicologo e psicoterapeuta con anni di esperienza e conoscenze approfondite nel campo.
Siamo certi che questa raccolta sarà di grande interesse per tutti coloro che cercano informazioni precise e affidabili su tematiche psicologiche.

L'angolo dell'anima - Le paure e le fragilità degli adulti
“La pandemia e l’avvento di Internet hanno raccolto e mostrato tutte le contraddizioni, le povertà educative e le fragilità degli adulti”
Negli ultimi anni gli adulti sembrano mossi e impauriti sempre di più dalla necessità di fare qualcosa, di sentirsi autorevoli, di dormire sonni tranquilli. La pandemia e l’avvento di Internet hanno raccolto e mostrato tutte le contraddizioni, le povertà educative e le fragilità degli adulti, i quali cercano di nascondersi dietro “gli effetti del lockdown” e delle cattive abitudini trasmesse ai più piccoli dai social network. Questi due eventi sociali senza dubbio hanno avuto effetti sulla salute psicofisica di tutta la popolazione; tuttavia, non possono essere usati come paraocchi per non vedere che la sofferenza psicosociale di bambini, adolescenti e adulti esisteva ben prima, così come non dovrebbero nascondere le grandi delusioni, dipendenti anche dal mondo adulto, che gli adolescenti si trovano a dover elaborare quando sono chiamati a costruire un proprio progetto di vita realizzabile.
Il superamento del modello familiare basato sull’autorità e poi di quello centrato sulla relazione e sull’affettività, come spiega lo psicoterapeuta Matteo Lancini, ha lasciato spazio ad un adulto e ad una famiglia “postnarcisista”, ovvero una famiglia in cui i comportamenti, la mente, l’affettività dei figli è pensata solo in funzione di come funziona o di ciò che vorrebbe l’adulto. Il fulcro di questo tipo di famiglia è proprio la fragilità degli adulti che vorrebbero trovare nei figli una conferma di sé e che, anche cercando di soddisfare le esigenze e le richieste dei più piccoli, non riescono a sentire e tollerare i fallimenti, i blocchi e la sofferenza che riguardano la crescita e la costruzione di un’identità nascente.Nella società postnarcisistica, l’adulto tende a sentirsi impotente e a relazionarsi all’altro come se volesse sempre individuare una causa della sofferenza e proporre la sua completa eliminazione in base a come lui ha affrontato quello stesso problema. Quest’impostazione relazionale più che ascolto della propria sofferenza ed esperienza per comprendere quella altrui, finisce per oscurare una reale identificazione con l’altro che non è solo empatia, sintonizzazione, ma riconoscere l’altro dov’è da un punto di vista emotivo, evolutivo e sociale. In altri termini, davvero un adulto, un insegnante crede di poter comprendere i figli e gli alunni continuando a ripetere che ai suoi tempi si stava meglio senza gli smartphone? L’adulto che ancora crede questo è un adulto che ha paura di pensare e far sentire che al centro ci sono le nuove generazioni e che queste devono essere riconosciute come capaci di usare le risorse che gli vengono offerte e che servono per costruire un futuro quasi impossibile da immaginare.
Tale fragilità si esprime, ad esempio, anche nel totale scollamento e nel conflitto tra scuola e famiglia che è un indizio non tanto di un generica degenerazione dell’istituzione scolastica o familiare, ma di una “dimenticanza” del vero significato della comunità educante, ossia una comunità sociale (familiare, scolastica, sportiva, lavorativa…) in cui il più debole è un’opportunità per arricchire tutto il gruppo e non il bambino o la bambina che non permette di “completare il programma”.
Un’altra paura degli adulti, quella di non essere riconosciuti nell’autorevolezza del proprio ruolo, li porta a rispondere ai comportamenti scorretti dei bambini e degli adolescenti con provvedimenti, privazioni, punizioni senza trasmettere il senso di quel gesto: l’adulto vorrebbe che ogni sua decisione fosse autorevole e in grado di imporre regole, a prescindere dal significato e dal vissuto dell’altro. L’unica conseguenza di tale imposizione è un allontanamento momentaneo del problema e un temporaneo addomesticamento dei figli o degli alunni. La paura di una perdita di autorevolezza si collega alla fragilità più grande che, nonostante i tentativi di nasconderla, pervade il funzionamento degli adulti: la nascita di un figlio, la relazione sentimentale con un’altra persona sono alimentate da un voler ricevere più che da un’offerta di condivisione. Il figlio, la persona che si ama sono oggetti che devono pagare un risarcimento e soddisfare le proprie sofferenze. A tale fragilità l’adulto dovrebbe rispondere con un riconoscimento e un’offerta dell’eredità affettiva che può lasciare alle nuove generazioni.
Bibliografia
Lancini M. (2023). Sii te stesso a modo mio, Raffaello Cortina Editore, Milano.

L'angolo dell'anima - Le paure dei genitori
“La paura di non essere un buon padre o una buona madre alimenta continuamente la domanda: “Che cosa ci rende bravi genitori?”, un interrogativo a cui si potrebbe rispondere prendendo in considerazione vari fattori”
Ogni essere vivente conosce la paura, un’emozione complessa che intreccia componenti comportamentali e psicologiche.
Per comprendere al meglio come quest’emozione si declina nei vissuti dei genitori può essere utile partire dalla definizione che il sociologo Bauman ci fornisce nel suo libro Paura liquida (p. 4): “«Paura» è il nome che diamo alla nostra incertezza: alla nostra ignoranza della minaccia, o di ciò che c’è da fare – che possiamo o non possiamo fare – per arrestarne il cammino o, se questo non è in nostro potere, almeno per affrontarla”.
Tale definizione va oltre la concezione della paura come risposta ad un pericolo, sottolineando che la paura può essere anche incertezza dovuta ad “stimolo” non facilmenteidentificabile. È proprio l’incertezza della propria identità genitoriale a costituire la paura più grande dei genitori che, di conseguenza, cercano di sopperire a quest’incertezza nelle mille preoccupazioni, a volte fondate e a volte no, per lo sviluppo dei bambini e delle bambine.
La paura di non essere un buon padre o una buona madre alimenta continuamente la domanda: “Che cosa ci rende bravi genitori?”, un interrogativo a cui si potrebbe rispondere prendendo in considerazione vari fattori, come ad esempio le proprie esperienze infantili con i propri genitori, i valori morali da trasmettere o la coerenza nell’educazione.
L’insieme di questi e altri fattori va a formare ciò che comunemente chiamiamo la “presenza genitoriale”, ovvero una capacità di essercicon i propri figli che deriva dal aver dato un senso alle proprie esperienze di attaccamento e di vita, dal sapere raccontare, prima di tutto a sé stessi, la propria storia personale.
A prescindere dalla qualità (traumatica, negativa o idilliaca che sia) della storia, in questo modo il genitore riesce a mettere alla base del proprio contatto con il figlio una consapevolezza aperta anche alle difficoltà e ricettiva sia delle incomprensioni, sia dell’appagamento emotivo che il bambino trova nel genitore.
Come spiegato anche negli articoli precedenti, un’altra paura tipica dei genitori, legata ancora all’incertezza della propria identità genitoriale, è la paura che il figlio non realizzi il progetto e le aspettative degli adulti. Tra le conseguenze di questa paura può esserci la costruzione di un’alleanza con i propri figli attraverso la continua opposizione alle loro scelte. In questi casi, la non condivisione e la paura per i progetti del figlio non vanno scambiati per cattiveria perché spesso, in realtà, dietro l’opposizione dei genitori si nascondono timori e iperprotettività che rendono la relazione con i propri figli una vera e propria corsa ad ostacoli.
Le indicazioni costanti su cosa fare o non fare, su cosa è giusto, pericoloso o meno potrebbero essere dettate da un’eccessiva paura per la salute del figlio. Nei bambini più piccoli, queste limitazioni genitoriali si possono esprimere attraverso sintomi psicosomatici come mal di testa o mal di pancia non derivanti da una reale disfunzione organica, ma da un’emozione che il bambino non riesce ancora ad esprimere se non attraverso il proprio corpo.
Esserci con i propri figli vuol dire anche riuscire a comprendere, immaginare e accettare che una propria paura, timore o preoccupazione può avere un simile effetto sulla mente e sul corpo del figlio. Se invece pensiamo al rapporto con gli adolescenti, dobbiamo considerare che non si tratta di una deliberata scelta di limitare o ostacolare lo sviluppo dei propri figli, ma di fare i conti con il fatto che la nascita e la crescita di un altro essere umano, anche se deriva dall’amore e dalla generatività della coppia, espone ad un divergenza di opinioni, di scelte personali e di valori che, nonostante le paure dei genitori, può portare ad uno ascolto reciproco in grado di riconoscere le peculiarità dei figli e dei genitori.
Volendo riprendere una metafora dello psicoterapeuta Alberto Pellai, le paure e le ansie dei genitori dovrebbero essere trattate come degli scrigni contenenti emozioni che richiedono di essere esplorate anche se sono fonte di una forte sofferenza o di una “messa in dubbio” del proprio agire genitoriale.
Bibliografia
Carli R., Paniccia R. M. (2020). Paura. Rivista di Psicologia Clinica, 1, 2020.
Del Corno F. (2023). Ripartiamo dai genitori. Capacità e competenze per sostenere gli adolescenti nel percorso di crescita, Franco Angeli, Milano.
Pellai A. (2021). Quando l’ansia dei genitori turba la crescita serena dei figli. Disponibile al link: https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/articoli/educazione/ansia-dei-genitori-turba-crescita-dei-figli/
Siegel D. J., Bryson T. P. (2020). Esserci. Come la presenza dei genitori influisce sullo sviluppo dei bambini. Raffaello Cortina Editore, Milano.

Le paure adolescenziali
La tempesta emotiva, tipicamente associata all’adolescenza, coinvolge anche la paura. Nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza le paure infantili iniziano ad essere giudicate come qualcosa di cui vergognarsi e di cui è necessario liberarsi, anche se si può sentire ancora un forte bisogno di protezione e di supporto. Il superamento delle paure “da bambini” porta l’adolescente a confrontarsi con paure più legate al contesto sociale, al gruppo di pari e alla scoperta di un nuovo “corpo”. La paura del cambiamento diventa il centro attorno a cui ruotano i vissuti adolescenziali: la percezione di un cambiamento in atto fa paura, soprattutto se accompagnata dalla sensazione di non saperlo comprendere e gestire. Tale sensazione non sempre riesce ad essere attenuata dalle rassicurazioni genitoriali o amicali perché l’inevitabilità del cambiamento fisico ed emotivo fa vivere all’adolescente una nuova e sorprendente solitudine, difficile da condividere con gli altri. Inoltre, il cambiamento e la solitudine possono portare anche ad una paura delle responsabilità che, da alcuni, può essere accettata come se fossero già degli adulti, mentre per altri le responsabilità possono divenire oggetti da evitare in quanto rappresentano il mondo ipocrita degli adulti. Un rifiuto delle responsabilità può essere espresso anche attraverso una sfida della paura: le azioni pericolose sono prove in cui l’adolescente stimola, stuzzica e istiga la paura per dimostrarsi che non è più solo un’emozione che lo immobilizza, ma anche un vissuto corporeo (brividi, pallore…) e affettivo conoscibile e controllabile. Tuttavia, sfidare la paura stessa può esprimere anche qualcosa di più profondo come la paura del passaggio da uno stato all’altro di sé stessi, ovvero il timore di perdere tutte le proprie esperienze infantili, senza riuscire a raggiungere una nuova immagine di sé che sia, al tempo stesso, del tutto nuova e in continuità con ciò che si è stati prima. Questo passaggio può essere la fonte anche di paure esistenziali che portano a interrogativi sul proprio stare al mondo, sul come vivere e sul perché della morte.
Queste tipiche paure adolescenziali vanno confrontate con l’attuale società in cui viviamo, dove l’estremizzazione di sé stessi, l’idealizzazione dei bambini e degli adolescenti hanno, da un lato, coperto tutte le fragilità degli adulti e, dall’altro, cercato di contenere l’esuberanza adolescenziale che ha da sempre disturbato la quiete degli adulti. Le paure degli adolescenti di oggi sono molte influenzate dalla poca fiducia nel futuro, negli altri e nella società, una sfiducia dovuta alla precarietà del lavoro, al difficile accesso all’autonomia e alla scarsa rappresentanza politica dei giovani. Questi cambiamenti dell’assetto familiare e sociale hanno avuto come effetto, la diffusione della paura del fallimento e dell’errore alimentata non dalla punizione, ma dalla delusione delle aspettative idealizzate dei genitori. Nella mente degli adolescenti la paura di deludere le aspettative, o la fragilità narcisistica, è diventata un vissuto emotivo che crea il timore di non essere popolari, di non essere apprezzati o notati nei vari contesti di vita. Per esempio, una cattiva condotta scolastica, anche quando l’adolescente mostra un certo disinteresse, può essere fonte di sofferenza in quanto è un dolore inflitto ai genitori: la prestazione non performante dei figli genera una sofferenza reciproca. In tale dinamica, le paure di genitori e figli si mescolano fino al punto di far dimenticare all’adolescente la propria spinta personale a realizzarsi nella vita, in favore di un progetto di vita voluto soprattutto dalle aspettative genitoriali. Un’altra conseguenza di questa dinamica è la paura di tradire l’immagine di totale felicità e benessere costruita dalle richieste sociali e familiari. Gli inviti ad “essere felici”, a “fare quello ti piace”, se non lasciano spazio alla possibilità del conflitto e del fallimento, possono generare paure che l’adolescente potrebbe esprimere attraverso il comportamento, il corpo o l’isolamento. Per questo, la domanda da cui il mondo sociale e il mondo degli adulti dovrebbe partire è: quali strumenti possiamo offrire agli adolescenti per fargli comprendere le proprie paure?
Bibliografia
Cirillo L., Lancini M. (2018). Le paure degli adolescenti, Psicologia contemporanea, n. 266, disponibile al link: https://www.psicologiacontemporanea.it/blog/le-paure-degli-adolescenti/
Gattinara C. E. (2018). Dieci lezioni sulle emozioni. Cosa provano gli adolescenti, Giunti Editore, Firenze.
Lancini M. (2023). Sii te stesso a modo mio, Raffaello Cortina Editore, Milano.

La paura nei bambini
Quando i bambini mostrano un forte senso di insicurezza, smarrimento o ansia di fronte a situazioni che valutano come pericolose o dannose, ci stanno comunicando che hanno paura. La paura, essendo una delle emozioni primarie, è innata, presente in tutte le culture e viene espressa attraverso espressioni facciali molto simili e riconoscibili. I comportamenti che si attivano automaticamente di fronte ad una situazione paurosa sono l’evitamento, la fuga o il pianto e l’immobilizzazione. Fin da bambini, la nascita di una paura per uno specifico evento, animale o persona è dovuta all’associazione, più o meno razionale, tra quell’evento e una forte sensazione di minaccia e pericolo per sé o per i propri familiari.
Da un punto di vista evoluzionistico, tale associazione ha un importante scopo adattivo: il bambino mette in atto i comportamenti che gli permettono di scampare da quel presunto pericolo e in questa maniera riesce a sopravvivere. Tuttavia, la funzione evoluzionistica della paura non spiega del tutto la complessità di quest’emozione e del mondo affettivo del bambino. Se la paura ha solo una funzione così specifica, perché ci stupiamo dell’irrazionalità e delle intensità delle paure infantili? Questa domanda va collegata al fatto che le emozioni hanno una componente biologica ed evoluzionistica che viene però modificata da un’elaborazione psicologica e cognitiva: il senso delle varie paure e le modalità con cui si affrontano variano in base alla storia del singolo bambino e, più in generale, in relazione al contesto storico e culturale.
Volendo tracciare una linea di sviluppo delle paure dei bambini, potremmo dire che, fino ai 6 anni, la paura della separazione dai genitori è quella principale, ma a questa si aggiungono paure più specifiche (temporali, mostri, uomo nero, lupo cattivo…). Questo graduale passaggio dall’angoscia di separazione alla specificità delle paure è dovuto alla maturazione psicofisica del bambino; in particolare, l’acquisizione della capacità di individuare se il timore è suscitato da un pericolo esterno o interno consente una prima elaborazione del senso della paura. I disegni, le favole, i sogni e gli incubi possono essere considerati come gli strumenti creativi che il bambino ha a disposizione per gestire e dare una forma ad una paura.
Il ruolo dei genitori è molto importante nel facilitare o complicare questo compito evolutivo. Le ricerche sugli stili genitoriali hanno evidenziato che, ad esempio, un atteggiamento troppo critico può essere correlato ad un’eccessiva paura di sbagliare e ad una bassa autostima. Nello stesso modo, un’esagerata protezione o la tendenza ad aspettarsi dal bambino “risultati perfetti” aumentano la possibilità che il bambino sviluppi paure più strutturate. Per aiutare ad affrontare le paure, il genitore può lasciarsi andare nel gioco con il bambino favorendo l’espressione verbale delle preoccupazioni e dei timori. Un altro strumento molto efficace che ogni bambino conosce già bene è quello del disegno: il genitore può invitare a disegnare insieme le cose che più lo spaventano per cercare di trovare un contenitore trasformativo di un’emozione che il piccolo ancora non riesce ad affrontare da solo. Per il genitore non è necessario lanciarsi in interpretazioni dei disegni o dei comportamenti indotti dalla paura, ma è sufficiente riuscire a sintonizzarsi emotivamente con il bambino attraverso il disegno comune, la lettura di una fiaba o l’invenzione di una nuova storia.
Un ultimo suggerimento attraverso un esempio pratico: la paura dei mostri può essere facilmente trasformata in un gioco condiviso in cui è necessario scappare e proteggersi dai presunti mostri pericolosi. Se però questa paura persiste, può essere utile ricordare al bambino che nessuno può entrare in casa e che, in ogni caso, c’è un adulto che lo protegge. In più si può chiedere al bimbo: “Cosa potresti fare se ti dovessi trovare davanti a questi mostri?”. In questo modo, il bambino, attraverso il supporto dell’adulto, potrà mimare, rappresentare e mettere in atto l’azione (tirare calci, usare un’arma magica…) che farebbe per proteggersi e affrontare le proprie paure.
Bibliografia
Argentieri, S. (2009). Paura, paure, Enciclopedia Treccani,
link: https://www.treccani.it/enciclopedia/paure-paura_(XXI-Secolo)/
Di Paolo, S. (2016). Le paure nei bambini: quali sono le più frequenti e come gestirle, State of Mind, link: https://www.stateofmind.it/2016/05/paure-nei-bambini/
Conti, D. (2015). Il linguaggio emotivo dei bambini, Sperling & Kupfer, Milano.

L'angolo dell'anima - La violenza di genere: alcuni aspetti centrali
“La violenza di genere non è nella biologia o nei cromosomi, ma nell’educazione e nell’ambiente relazionale che devono essere i luoghi da cui partire per un cambiamento”
La violenza di genere o, più esplicitamente, la violenza maschile contro le donne è definita dall’Onu come un insieme di atti violenti (minacce, coercizione, privazione della libertà…) alimentati dalla differenza o discriminazione tra uomo e donnacapaci di provocare una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne.
L’altra parola associata in modo automatico a tale definizione è quella di femminicidio che mette in chiaro il fatto che l’omicidio, le violenze, le persecuzioni avvengono in quanto chi subisce appartiene al genere femminile: l’essere donna, soprattutto quando non incarna più la rappresentazione di “donna tradizionale”, è il motivo principale che muove i vari atti di violenza.
Chi banalmente vuole giustificarsi dicendo che esiste anche una violenza contro gli uomini messa in atto dalle donne non mette in conto che questo tipo di violenza, del tutto marginale o inesistente nelle statistiche, non avviene in quanto la vittima è uomo, anche perché fare un’affermazione simile equivarrebbe a dire che la vittima è stata uccisa in quanto appartenente al genere che da sempre ha prevaricato e discriminato l’altro sesso.
Tralasciando questa giustificazione maschilista – tuttavia realizzabile in un lontano e fantastico futuro iperfemminista – soffermiamoci su alcuni aspetti centrali della violenza di genere.
Il primo riguarda il rapporto tra stile di attaccamento e violenza di genere: come riportato dall’Osservatorio nazionale sui diritti, gli studi sull’attaccamento sottolineano che quando entrambi i membri della coppia hanno uno stile di attaccamento insicuro (ansia, angoscia di abbandono, convinzione di non essere amabili…) le possibilità di regolazione ed espressione delle emozioni falliscono maggiormente, causando un rischio più elevato di violenza. Inoltre, se lo stile individuale di attaccamento di chi abusa è evitante le modalità disfunzionali che si attivano sono centrate sul fallimento dei meccanismi di controllo della rabbia e sulla svalutazione del legame affettivo, due strategie psicologiche fallimentari che possono arrivare fin al punto di non far percepire la crudeltà e le sofferenze causate al partner.
Il secondo aspetto si riferisce al ciclo della violenza ripetuto dalla coppia fino alla rottura, che in alcuni può essere drammatica. Le tre fasi di tale ciclo sono: accumulo di tensione emotiva di chi abusa (nervosismo, intolleranza, indifferenza…), liberazione esplosiva della tensione accumulata (aggressioni verbali e psicologiche…) e luna di miele (apparente dolcezza di chi abusa, scuse, cure…). La marcata ripetitività di questi comportamenti insieme alla scelta della donna maltrattata di interrompere una relazione così dannosa possono essere considerati due segnali critici che dovrebbero attivare la presa in carico e la protezione della vittima.
Il terzo aspetto ci porta al cuore della violenza di genere e del modo in cui viene raccontata, ovvero all’illusione di poter definire una precisa personalità “patologica” della vittima e del carnefice per relegare la questione della distruttività umana e della sofferenza (psicologica e sociale) in uno spazio chiuso e separato dal nostro mondo quotidiano. Se gran parte della psicologia cede a questa semplificazione, la conseguenza è che si mettono sempre in secondo piano gli elementi più perturbanti della violenza di genere. Tra questi possiamo evidenziarne due: la separazione della parte violenta di sé nel carnefice e la collusione psicologica della vittima, dinamica che ha poco a che fare con la colpevolizzazione della donna. In entrambi i casi, evitando di mettere sullo stesso piano vittima e carnefice, c’è un forte nodo di sofferenza che merita di essere ascoltato e sciolto.
Questi tre aspetti accennati confluiscono in un ultimo punto fondamentale, i processi educativi costituiscono lo strumento principale per riflettere e comprendere su come si struttura e su come viene espressa l’aggressività nei rapporti umani. Un’aggressività che, dal punto di vista educativo, non dovrebbe essere ricondotta ad una caratteristica costituzionale del maschio o della femmina, ma alla costruzione psicosociale dell’uomo e della donna.
In conclusione e in maniera più esplicita, la violenza di genere non è nella biologia o nei cromosomi, ma nell’educazione e nell’ambiente relazionale che devono essere i luoghi da cui partire per un cambiamento.
Bibliografia
Argentieri S. (2023), Contro i femminicidi. Zone d’ombra e ambiguità, rivista giudicedonna.it, disponibile al link: http://www.giudicedonna.it/index.htm
Bergamo F. (2020), Stili di attaccamento e violenza nella relazione di coppia: un’ipotesi di correlazione, Vox, osservatorio italiano sui diritti, disponibile al link: http://www.voxdiritti.it/stili-di-attaccamento-e-violenza-nella-relazione-di-coppia-unipotesi-di-correlazione/
Bonsangue M. (2022), La violenza psicologica nella coppia, Dario Flaccovio Editore, Palermo.

L'angolo dell'anima - La rottura della simbiosi: influenze psicologiche e culturali
“Soprattutto nelle relazioni amorose, la rottura della simbiosi sfocia spesso nella violenza, nei femminicidi e nelle continue mortificazioni della libertà delle donne”
Le varie forme di simbiosi relazionale, descritte negli articoli precedenti, possono avere un esito drammatico quando si trovano a dover affrontare la separazione voluta da uno dei membri della coppia. Soprattutto nelle relazioni amorose, la rottura della simbiosi sfocia spesso nella violenza, nei femminicidi e nelle continue mortificazioni della libertà delle donne.
L’attualità del fenomeno ci indurrebbe a ricercare cause specifiche nella sociologia, nella psicologia, nella storia o in altre scienze, quasi come per scansarci da ciò che ci riguarda personalmente nelle nostre relazioni affettive, da ciò che c’è di non detto e di implicito nella nostra vita relazionale, sessuale e affettiva e, detto in altre parole, per non riconoscere le nostre responsabilità nella riproduzione di un modello culturale dannoso fondato sull’idea che i rapporti familiari, sessuali e sociali sono regolati dalla proprietà maschile del corpo femminile.
Una breve premessa per chiarire che non è solo la forma simbiotica della relazione amorosa a sfociare in maniera più o meno lineare nella violenza, ma ogni relazione ha in sé qualcosa di culturale e psicologico che se non viene pensato, vissuto e simbolizzato dai membri della coppia può avere gli stessi effetti negativi. Questo “qualcosa” è in stretto contatto con ciò che la relazione simbiotica mette continuamente da parte: la possibilità della perdita e della separazione, l’esperienza dolorosa del lutto.
Volendo immaginare la dinamica relazionale attivata dalla fine di un rapporto possiamo intravedere due possibilità: la prima è l’apertura al dolore della perdita, il riconoscimento di un “fallimento” relazionale non dovuto alle caratteristiche soggettive degli ex-amanti, ma alla scelta e alla libertà dell’altro che, anche se ci mette di fronte alla solitudine e alla nostalgia, è necessario accettare per non portare con sé solo gli aspetti negativi della rottura; la seconda possibilità, quella più legata alla relazione simbiotica, esclude il riconoscimento della perdita e cerca di negarla attraverso l’ossessività, lo stalking e la violenza, frutto stesso della dipendenza assoluta, della simbiosi e di un profondo vuoto interno.
È proprio quest’ultimo che imprigiona chi sente il bisogno di uccidere l’altro in una gabbia narcisistica e depressiva, costruita su un pensiero ben sintetizzato da Massimo Recalcati: “non sopporto di non essere più tutto per te, dunque ti uccido perché, in realtà, non posso riconoscere di non essere niente senza di te”.
In una visione cognitivista, l’avvicinarsi alla rottura della relazione spinge la coppia simbiotica a vivere un conflitto tra lo scopo di mantenimento del rapporto amoroso e la rabbia o protesta per ottenere qualcosa di migliore; questi due termini non riescono ad essere sintetizzati (fatti comunicare tra loro) portando così ad una situazione relazionale in cui si alternano vari pensieri e sentimenti:ad esempio, la consapevolezza del male che si prova a stare in quel rapporto, la tendenza a voler affrontare ed evitare la separazione e una valutazione su di sé che porta a sentirsi incapaci di terminare quel rapporto. Anche per queste ragioni l’accettazione della perdita e del lutto diviene difficoltosa fino al punto che la rabbia e il bisogno di controllo si pervertono in azioni estreme e violente.
Da questo punto di vista è possibile sfatare anche una razionalizzazione semplicistica che tende a ridurre gli episodi di violenza ad uno schema vittima-carnefice: la rottura di una relazione – simbiotica o meno – fa vivere una forte rabbia che se viene nascosta nella sottomissione o nella ricerca ossessiva dell’altro può trasformarsi in un’escalation di violenza molto pericolosa.
Le dinamiche psicologiche del funzionamento simbiotico non possono essere usate per coprire le influenze culturali, come accennato in precedenza. Infatti, a fare da supporto alle azioni violente sono tutte quelle idee che – senza farci intimidire dall’abuso che si fa del termine – dovremmo chiamare patriarcali.
Il nucleo ideologico di un sistema patriarcale si struttura sull’illusione di una donna per natura incapace o inferiore sul piano morale, cognitivo e sociale e che, per questo, non può che essere un oggetto passivo dell’uomo. Per concludere, si capisce bene come quest’idea patriarcale insieme ad un funzionamento simbiotico può determinare i vari fatti di cronaca nera giornalieri, episodi che, sia nel modo in cui vengono raccontanti mediaticamente sia nel modo in cui si sono creati al livello relazionale, sono accomunati dal valor far scomparire l’espressione della soggettività femminile.
Bibliografia
Pugliese E., Saliani A. M., Mancini F. (2019), Un modello cognitivo delle dipendenze affettive patologiche in “PSICOBIETTIVO” 1/2019, pp 43-58, DOI: 10.3280/PSOB2019-001005
Recalcati M. (2023), Il peso del fallimento e la ferocia di Narciso, la Repubblica, 24 Novembre 2023.

L'angolo dell'anima - Le relazioni simbiotiche nell’amicizia
L’inclinazione ad instaurare relazioni simbiotiche può manifestarsi e concretizzarsi anche nei rapporti d’amicizia. In questi casi la relazione amicale si basa sulla costruzione di una sorta d’identità comune in cui la forte credenza di supportarsi reciprocamente copre problematiche relative alla dipendenza e alla capacità di stare da soli.
Nel concreto, questo tipo di amicizia si alimenta di hobby, progetti, svaghi comuni in cui è difficile comprendere chi ha davvero messo in comune qualcosa e chi ha scelto con decisione quell’attività: entrambi credono erroneamente che sia l’altro a volerlo e deciderlo, in una dinamica cognitiva ed affettiva fondata sulla confusione identitaria.
Non volendo ridurre la nascita di questo tipo di relazioni al semplice incastro di personalità patologiche (ad esempio, tra narcisisti e dipendenti), possiamo riflettere su cosa differenzia un’amicizia sana da una simbiotica e sulle cause evolutive.
Nella relazione simbiotica l’amico, idealizzato e perfetto, diviene l’unica persona in grado “nutrire”, di essere la parte mancante del proprio sé e che per questo deve essere sempre salvaguardato dal rischio della perdita; inoltre, entrambi tendono a percepirsi come bisognosi e non capaci di sostenersi o stare bene da soli. Invece, un’amicizia sana si alimenta dell’irriducibilità della differenza me-altro ed è in grado di affrontare le tensioni del riconoscimento reciproco attraverso la negoziazione e la mutualità.
Quando questo non avviene l’amicizia diventa una simbiosi, in cui ogni rottura e delusione attiva cortocircuiti cognitivi del tipo: “se l’altro non incarna più le mie idealizzazioni e la parte mancante di me, allora è un mio nemico che, per me, non esiste più”; detto in altri termini, l’amicizia assume i caratteri di un gioco relazionale basato sul polo dominio/sottomissione e su una logica “amico o nemico”.
Da un punto di vista evolutivo, come segnalato da Liotti e Farina (2011) nel loro testo Sviluppi traumatici, un segno delle conseguenze di dinamiche familiari disfunzionali può essere una disposizione comportamentale coatta improntata alla generosità assoluta e all’assenza di compensi materiali o morali, un comportamento che contribuisce a mantenere salda l’amicizia simbiotica. Questo stile comportamentale può svilupparsi in persone che si rifugiano in relazioni in cui sentono di avere di avere un ruolo (simbiotico o di vittima) in quanto, da bambini, nella relazione genitoriale ha prevalso una sensazione di inutilità e di “poco valore”.
In più, le figure genitoriali possono essere state controllanti, inattendibili, ipercoinvolte ed intrusive fino al punto di trasmettere l’idea che l’indipendenza e la rottura del legame simbiotico infantile sono pericolosi e da evitare. Nell’amicizia simbiotica, questi vissuti vengono ripetuti: nessuno dei due membri del rapporto amicale riesce a differenziarsi dall’altro perché l’indipendenza è categorizzata, sia da un punto di vista cognitivo che affettivo, come un tradimento che porterà alla solitudine.
In tal modo, la persona continua ad investire cognitivamente diverse credenze erronee: essere simbiotici e dipendenti è l’unico modo per continuare ad avere quel legame, crescere e diventare indipendenti equivale al perdere l’amore e il bene dell’altro.
La brusca rottura di questi equilibri può portare alla richiesta di un supporto psicologico: da un vertice cognitivo-comportamentale, è fondamentale cercare di rafforzare il riconoscimento dei propri desideri, aumentare il senso di efficacia affinché la persona sia in grado di gestire la sensazione di vuoto, la paura di perdere qualcosa e la percezione della propria impotenza.
In conclusione, si può dire che un’amicizia in cui a prevalere è il rapporto simbiotico con l’altro esclude la possibilità di creare una reale indipendenza fondata sul saper dipendere dalle altre persone e sul permettergli di dipendere da noi, in modo flessibile e autentico, senza che nessuno perda totalmente la propria identità.
Bibliografia
Lingiardi V., Gazzillo F. (2014), La personalità e i suoi disturbi, Raffaello Cortina, Milano.
Liotti G., Farina B. (2011), Sviluppi traumatici, Raffaello Cortina, Milano.
https://www.terzocentro.it/disturbi-personalita/disturbo-dipendente-di-personalita/

L'angolo dell'anima - La simbiosi nelle relazioni sentimentali
Vivere in una relazione basata su un attaccamento simbiotico vuol dire fare i conti con legami amorosi apparentemente vitali, ma che in realtà si nutrono della dipendenza dall’altro, dello spazio di chi ci sta accanto fino al punto che tutta la vitalità di un amore passionale arriva a scomparire per lasciare soltanto una grande sofferenza.
Nell’amore simbiotico, i confini tra sé e l’altro non sono stabiliti: prevale l’invasione di un legame che pretende di essere assoluto o la rigidità provocata dall’angoscia dell’abbandono, mentre è proprio la mobilità dei confini relazionali a poter alimentare un rapporto amoroso profondo.
Da un punto di vista cognitivo, parlare di relazioni amorose simbiotiche vuol dire anche parlare delle dinamiche della dipendenza affettiva. Entrambe, infatti, ruotano attorno al timore della separazione e alla tendenza a restare nella relazione per ridurre l’angoscia e lo stress emotivo dell’abbandono, un vissuto da tenere lontano anche più della sofferenza generata dalla relazione stessa e spesso avvertita da chi si trova intrappolato in un amore simbiotico.
Si potrebbe immaginare il funzionamento mentale di una coppia simbiotica come alimentato da dilemmi cognitivi e affettivi riassumibili attraverso i seguenti interrogativi: che cosa vuole davvero l’altro? Posso o non posso avere uno spazio privato? Cosa mi spinge a restare attaccato ad una relazione così? Perchè scelgo sempre il partner sbagliato?
La risoluzione cognitiva di questi dilemmi, lungi dal mettere in campo realmente la capacità decisionale della persona, porta a preferire il bene minore ma immediato (ad esempio, la riduzione del dolore della separazione) e a mettere da parte un bene più grande ma non immediato (ritornare a stare bene da soli, costruire una nuova relazione).
Questi meccanismi cognitivi sono accompagnati da strategie e comportamenti disfunzionali volti a mantenere l’equilibrio simbiotico.
Ad esempio, nella coppia ognuno dei partner tende a recitare un ruolo che è il riflesso di ciò che l’altro vorrebbe, inoltre sembrano emergere solo le qualità desiderate dell’altro e può accadere che l’uno si prenda fortemente cura dell’altro, incarnando così il ruolo del supereroe o del bravo aiutante disposto a perdonare sempre. Tale messa in scena comportamentale è necessaria per soddisfare il bisogno di contare per il partner e per assicurarsi la sua vicinanza.
Tra i motivi che spingono a mantenere questo tipo di relazione possono esserci: una forte intolleranza all’incertezza che si concretizza nella ricerca compulsiva di risposte di vicinanza dopo un litigio o durante una pausa da quella relazione, l’illusione che il partner può cambiare e il desiderio di essere risarciti per la sofferenza di altre esperienze. Inoltre, la coppia simbiotica tende ad evitare il dolore per la solitudine, ridotta a condizione provocata dalla distanza dal partner. Il restare in una relazione simbiotica, anche da un vertice cognitivista, può essere ricondotto al desiderio di riscatto rispetto ai traumi vissuti nell’infanzia.
Dall’ascolto di chi ha vissuto relazioni simbiotiche, spesso sfociate nella violenza, emerge il ritratto di un bambino che non poteva lasciare l’amore del genitore, anche se maltrattante: un bambino costretto a salvare il genitore sofferente e che ha avuto difficoltà a metabolizzare l’uscita dalla fase simbiotica vissuta durante l’infanzia.
Le dinamiche della coppia simbiotica possono diventare pericolose quando uno dei due sceglie di voler interrompere il rapporto: di fronte ad un rifiuto, le richieste di non abbandono potrebbero diventare più invasive e portare a risposte aggressive o a veri e propri atti di violenza che, purtroppo e spesso, raggiungono lo scopo di mantenere patologicamente quel rapporto.
In conclusione, quest’ ultimo aspetto e una delle caratteristiche comportamentali descritte sopra, la riduzione della solitudine a “distanza dal partner”, ci dicono qualcosa in più sul funzionamento della coppia simbiotica: entrambi i partner tendono ad appiattire la propria soggettività sul mantenimento di uno spazio simbiotico e fusionale, opposto ad uno spazio relazionale in grado di tollerare le separazioni, le rotture e la solitudine.
Bibliografia
Pigozzi, L. (2023), Amori tossici: alle radici delle dipendenze in coppia e in famiglia, Rizzoli, Milano.
Pugliese E., Saliani A. M., Mancini F. (2019), Un modello cognitivo delle dipendenze affettive patologiche in “PSICOBIETTIVO” 1/2019, pp 43-58, DOI: 10.3280/PSOB2019-001005

La simbiosi nella relazione genitore-bambino
In biologia, la parola simbiosi indica un rapporto di stretta dipendenza tra due organismi di specie diversa che dalla loro interdipendenza traggono un reciproco vantaggio. Gli studi sullo sviluppo psicologico del bambino, a partire da Mahler, hanno ripreso tale espressione per indicare una particolare fase dello sviluppo caratterizzata da una dipendenza totale ed esclusiva dalla madre (fase simbiotica durante i primi trenta mesi). In senso più generale, un rapporto simbiotico è caratterizzato da una forte dipendenza reciproca fra due persone (genitore/figlio, amici, fidanzati…) che credono erroneamente di completarsi a vicenda e, di conseguenza, alimentano le parti più immature della propria personalità e la paura di andare in pezzi senza la presenza dell’altro.
Se questa modalità può essere molto dannosa in relazioni adulte, nel rapporto genitore-neonato è, per un limitato periodo di tempo, necessaria. Il confronto tra la definizione biologica e quella psicologica del termine simbiosi ci permette di capire il perché e, inoltre, di sottolineare alcuni aspetti spesso tralasciati: in che senso il genitore e il bambino sono “due organismi di specie diverse”? Qual è il “vantaggio” che il genitore può trarre dalla dipendenza del bambino/a?
L’appartenenza di genitore e bambino a due specie diverse di certo non allude al fatto che uno dei due non sia un essere umano, ma piuttosto al fatto che il neonato si trova in una condizione di totale assenza di possibilità di sopravvivere senza l’aiuto e la cura di un adulto. In più, questa diversità potrebbe anche indicare non solo la completa asimmetria tra il funzionamento psicologico dell’adulto (complesso e sviluppato) e quello del neonato (presente solo in forme psicocorporee), ma anche il contesto familiare, emotivo e culturale in cui il bambino nasce. In altri termini, il neonato si trova “catapultato” in un romanzo familiare costituito da tutte le aspettative e i vissuti emotivi dei genitori e dell’intera famiglia. Quest’ultimo aspetto ci collega al secondo interrogativo: il “vantaggio” che il genitore può trarre dalla simbiosi infantile potrebbe stare nell’investire idealmente il neonato e aspettarsi da lui la realizzazione di tutte le aspettative familiari, ovvero ridurre il bambino a oggetto che può appagare i propri vissuti di mancanza. La rinuncia a questo vantaggio e il riconoscimento graduale del neonato come persona altra da sé è ciò che favorisce lo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali ed emotive utili a tollerare la differenza e la separazione dall’altro (genitori, amici, fidanzati…).
Ma qual è il processo cognitivo che può facilitare questa rinuncia? Ciò che agevola lo sviluppo e l’indipendenza di un bambino, anche al di là dello specifico periodo della fase simbiotica, è la capacità di mentalizzazione dei genitori: riconoscere i propri stati emotivi per cercare di comprendere e prevedere il proprio comportamento e quello altrui. Tale capacità permette di iniziare ad immaginare il neonato come dotato di una mente, di un’affettività e di una relazionalità che si sta lentamente costruendo appoggiandosi proprio sull’aiuto dell’adulto. Non ridurre quest’appoggio ad una simbiosi perenne con il neonato vuol dire offrirgli una fiducia di base su cui crearsi una rappresentazione, cognitiva ed affettiva, di un sé che anche se separato e diverso dall’altro non va in pezzi e può continuare a sopravvivere.
Tuttavia, la relazione genitore/bambino non è l’unica causa di una difficile rinuncia della simbiosi infantile; infatti, è anche l’insieme dei legami familiari in cui si sviluppa il rapporto genitore-figlio ad ostacolare lo sviluppo dell’autonomia del bambino.
In questo caso, il genitore può essere supportato nella mentalizzazione rimandandogli alcuni elementi essenziali: il bambino possiede una mente separata dalla madre e dal contesto familiare, la funzione genitoriale si fonda non solo su una sintonizzazione dei bisogni del neonato, ma anche sulla capacità di mantenere attiva la parte adulta di sé.
Bibliografia
Norsa, D. (2020), Legami di dipendenza e problematiche separative, Rivista Interazioni, 52, 2
Galimberti, U. (2020), Dizionario di psicologia, Feltrinelli, Milano.
Locatelli S. (2020), Dalla rappresentazione cognitivo-affettiva durante la gravidanza alla relazione madre-bambino: mentalizzazione, funzione riflessiva e mind-mindedness, State of Mind, link: https://www.stateofmind.it/2020/02/mentalizzazione-madre-bambino/
Mahler, M. et al. (1975), La nascita psicologica del bambino: simbiosi e individuazione, Bollati Boringhieri, Torino.

L’angolo dell'anima - Avvicinarsi alla sofferenza depressiva
Prendersi cura di un familiare con una forte sofferenza depressiva vuol dire interrogarsi continuamente su quale ruolo si può avere nel suo percorso di guarigione e su quali possono essere le cause. Come avvicinarsi a questo tipo di sofferenza psicologica che può immobilizzare completamente l’altro?
In generale, riconoscere i primi segni di una crisi può essere utile ad intervenire prima ed evitare che la crisi sia molto forte: la depressione può iniziare in seguito ad un evento specifico o senza una causa precisa, per questo non sempre è semplice individuare il cambiamento dell’umore di chi ci sta accanto.
La relazione, la fiducia e una speranza attiva dovrebbero essere i tre elementi sui quali basare l’aiuto che scegliamo di offrire all’altro: si tratta infatti di un supporto familiare che non può avvenire senza una vera consapevolezza di ciò che il familiare vuole e può mettere in gioco.
Il raggiungimento e l’alimentazione di tale consapevolezza può richiedere un supporto psicologico/psicoterapeutico del familiare stesso non tanto per “capire come posso curare l’altro”, ma per riflettere sulle emozioni e i pensieri soggettivi attivati dall’entrare in contatto con stati depressivi acuti che a volte si vorrebbero eliminare magicamente.
Ad esempio, un vissuto diffuso tra i familiari può essere la sensazione di essere invasi dalla sofferenza dell’altro e di non riuscire a sentire di poter stare bene perché si pensa, erroneamente, che “non è giusto stare bene se l’altro è depresso”. Al contrario, recuperare o mantenere una vitalità personale può essere utile a comprendere quali sono le proprie risorse e a non incentrare il rapporto con l’altro esclusivamente sugli aspetti depressivi.
Nello specifico, un errore in cui si cade spesso è pensare che le parole d’incoraggiamento sono sempre utili a prescindere dalla soggettività della persona; infatti, a volte ciò che una persona depressa vorrebbe trasmetterci è proprio “non dirmi anche tu che c’è una luce un fondo al tunnel” oppure “tutti quelli intorno a me sono felici, ma io non riesco ad esserlo”. Per questo, sarebbe opportuno evitare di dire frasi del tipo: reagisci è solo questione di volontà, guarda chi sta peggio di te, esci con gli amici che così ti svaghi un po’, hai tutto ciò che occorre per essere felice, così fai star male anche i tuoi cari, pensa alla tua famiglia che ti vuole bene.
Le frasi che invece un familiare potrebbe utilizzare si basano sul rispetto per la sofferenza dell’altro e sull’interesse per lui, per esempio: ti sto accanto, non sei solo; non è colpa tua, non dipende da te: è unasofferenza che si cura; che cosa posso fare per te?Quali sono i tuoi pensieri?
I gesti e le azioni del familiare devono partire dal rispetto per le abitudini: alcuni hanno bisogno dei propri spazi, altri non amano il contatto fisico e altri ancora entrambe le cose, ma a volte una presenza fisica silenziosa può dare all’altro la sensazione che qualcuno c’è.
È molto importante incoraggiare con delicatezza ad avere uno stile di vita sano, in aggiunta alla terapia perché il movimento e l’alimentazione sana possono indurre lentamente la persona depressa a smettere di trascurarsi (un deciso segnale di miglioramento).
Se la persona nomina il suicidio non bisogna sottovalutare la questione e riconoscere che l’altro si sta fidando di voi. Potrebbe aiutare approfondire direttamente il problema chiedendo: hai pensieri suicidi? Perché pensi alla morte? Davvero ogni tanto vorresti farlo? Affrontare l’argomento può ridurre di molto il rischio di metterlo in pratica. Inoltre, bisogna considerare che il rischio di suicidio si può acuire proprio quando la persona inizia a stare meglio e per questo incoraggiare la persona a parlarne con il suo psicoterapeuta.
A questo proposito, consigliare di parlare con un/a specialista dovrebbe partire dal chiarire all’altro che la depressione è una forma di sofferenza che può farti vedere tutto nero e che però può essere curata. Resta importante non forzare troppo l’altro e rispettare i suoi tempi in quanto, spesso, è proprio una sofferenza troppo acuta che gli impedisce di chiedere aiuto.
BIBILIOGRAFIA
Di Salvo, S. (2012). I familiari di chi soffre di depressione. Ebook dell’Associazione per la Ricerca sulla Depressione.
Giberti F., Rossi R. (2009). Manuale di psichiatria. Piccin, Padova.
https://www.vice.com/it/article/j54g33/come-aiutare-una-persona-depressa

L’angolo dell'anima - Le relazioni nel digitale
Il rapporto 2022 dell’Istituto Superiore di Sanità sulle dipendenze da internet definisce la Social Media Addiction come una “dipendenza comportamentale che si caratterizza per un bisogno incontrollabile diaccedere ad informazioni o veicolare dei propri contenuti verso terzi, in una maniera talmente tantocompulsiva da compromettere gli altri ambiti di vita quotidiana”.
Questa definizione può essere fatta rientrare nel termine più ampio “dipendenza da internet” (Internet Addiction Disorder), la quale indica vari comportamenti problematici nei confronti di specifici contenuti online: shopping online, pornografia, gioco d’azzardo, ecc.
Tuttavia, né nella comunità scientifica internazionale, né nel DSM V (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) esiste un consenso unanime sull’esistenza di una vera e propria dipendenza da social.
Per questa ragione, al di là della classificazione diagnostiche, può essere utile soffermarsi sulla costruzione delle relazioni nel digitale partendo da tre interrogativi approfonditi di seguito.
Come possono sorgere i comportamenti problematici verso i social?
Il passaggio da un uso adeguato dei social network a quello disfunzionale si verifica quando le relazioni digitali sono viste dall’individuo come uno strumento fondamentale per alleviare altri tipi di disagio (ansia, depressione, solitudine…). Secondo una prospettiva socio-cognitiva, comportamenti dipendenti e compulsivi verso i social provengono dalla combinazione di vari elementi: aspettative di risultati positivi dalle proprie attività digitali, una falsa autoefficacia restituita dalla rappresentazione digitale di sé e una scarsa autoregolamentazione dei contenuti online da parte sia degli utenti, sia delle varie piattaforme.
Quali fattori entrano in gioco nelle relazioni che la persona crea con i contenuti, i dispositivi digitali e le altre persone conosciute online?
Le relazioni nel e con il digitale sembrano essere caratterizzate da un distacco dall’ambiente reale a favore diun ritiro nel virtuale in cui il contatto con l’altro è filtrato da una barriera tecnologia, da un paravento virtuale che, in apparenza, protegge da ciò che ognuno giudica pericoloso nelle relazioni con gli altri.
In tal modo, si crea un finto controllo dell’altro (persona o contenuto digitale) che, in realtà, è solo una sorta di appropriabilità istantanea: ognuno di noi e ogni cosa diviene una risorsa da consumare per poi passare molto velocemente a qualcos’altro.
Nel digitale, il rapporto con l’altro può differenziarsi anche in base al tipo di comunicazione che scegliamo: l’utilizzo delle chat (senza veri segnali visivi) può influenzare il confine tra sé e gli altri facendo provare una “fusione” tra la propria mente e quella della altra persona online, questo rende l’altro digitale qualcosa di più simile ad un “personaggio” della propria mente su cui proiettare vari sentimenti e vissuti personali.
La capacità di distinguere il proprio funzionamento mentale ed emotivo da quello dell’altro è fondamentale e le relazioni nel digitale, ormai da anni, ci interrogano sull’evoluzione (o involuzione?) di questa abilità interpersonale.
Un altro fattore che alimenta le relazioni digitali riguarda il loro utilizzo come un antidoto alla solitudine e alla mancanza, ovvero come un cordone ombelicale che ci fa sentire dotati di qualsiasi cosa, di un’onnipotenza digitale concretizzata nell’illimitatezza delle informazioni e delle possibilità offerte da internet.
C’è un’incomprensione generazionale sul ruolo che internet può avere?
L’incomprensione e le continue rotture generazionali possono aver alimentato la tendenza ad associare comportamenti nuovi o eccessivi alla gravità delle dipendenze da sostanze oscurando anche la differenza terminologica (non esplicita in italiano) tra addiction e dependence, ovvero tra la ricerca compulsiva degli stimoli gratificanti nonostante le conseguenze dannose (addiction) e uno stato fisico caratterizzato da astinenza e tolleranza (dependence).
Per gli adulti vedere bambini o adolescenti che giocano ai videogiochi o guardano video di YouTube corrispondead una perdita di tempo che può sfociare nel patologico, ma per le generazioni più giovani significa poter giocare in un parco giochi virtuale.
Il tempo eccessivo trascorso al computer o al cellulare può essere il segno di sofferenza più strutturata e non il problema principale. Il dialogo tra le generazioni potrebbe ripartire dal riconoscimento della funzione socializzante di internet e dall’interesse collettivo verso i cambiamenti sociali e psicologici che essa ha prodotto e produrrà ancora.
BIBLIOGRAFIA
Marzi A., Saltamerenda G. (2014). Dipendenza da Internet (IAD). Disponibile al link: https://shorturl.at/AGJN8
Minutillo A., Berretta P. et al. (a cura di, 2022). Rapporto Istituto Superiore di Sanità 22/5 – Dipendenze da Internet.Disponibile al link: https://shorturl.at/exG59
https://www.ilpost.it/2023/05/08/dipendenza-internet-italia/

L’angolo dell'anima - La dimostrazione dell’ovvio
La continua esposizione e riproduzione sui social network di post, commenti, notizie che ci sembrano ovvie, banali e scontate ci fa interrogare sul modo in cui sta cambiando la condivisione delle conoscenze scientifiche e la percezione dellaverità. Oltre ad essere legato all’ormai famoso fenomeno della filter bubble (le comunità digitali di ognuno di noi che tendono a riproporre contenuti affini ai nostri interessi e non sempre basate sui fatti), la proliferazione dell’ovvio racchiude in sé diversi aspetti legati al nostro modo di conoscere sé stessi e gli altri.
Innanzitutto, rifiutare in blocco la banalità e declassarla a mera stupidaggine non sempre è utile a comprendere quali sono gli aspetti realistici di quella notizia ovvia e, se volessimo scavare più in profondità, a capire quali sono i processi psicologici e sociali che portano alla proliferazione dell’ovvietà. Tale diffusione, proprio perché costituita dal dato per scontato (da ciò che non si avverte), è infatti il punto di partenza per la costruzione di una supposta normalità socialmente accettata che, in realtà, spesso nasconde contraddizioni e discriminazioni.
In questo senso, l’opacità e la rassicurazione insita nell’ovvio influenza, più di quello che si crede, la nostra visione del mondo, le nostre decisioni e il nostro relazionarci all’altro. Un esempio può essere tratto dagli interrogativi del sociologo Zerubavel nel suo libro Dato per scontato. La costruzione sociale dell’ovvietà: perché si utilizza spesso l’espressione “dichiaratamente gay” e non l’equivalente “apertamente etero”? Le locuzioni come “donna in carriera” o “infermiere maschio” su quali assunti sociali si basano? Questi interrogativi sono un invito a riflettere su tutti quei fatti, espressioni, pensieri presi per buoni senza renderci conto che riproducono pregiudizi o visioni parziali della realtà.
In più, da una prospettiva psicologica, la saturazione delle nostre comunità digitali provocata dalla condivisione di notizie banali e scontante (talvolta infondate) può essere ricondotta ad una distorsione cognitiva, conosciuta come “effetto Dunning-Kruger”, dal nome dei due psicologici che l’hanno scoperta e approfondita in diversi esperimenti.
L’effetto Dunning-Kruger consiste nella tendenza delle persone poco esperte a credere di avere una competenza maggiore rispetto a quella reale e, quindi, a pensare di potersela cavare nonostante la propria ignoranza e competenza. In altri termini, l’incompetenza stessa impedisce di vedere in sé le proprie lacune conoscitive, sovrastimando il proprio bagaglio culturale.
Questa tendenza è l’origine cognitiva del moltiplicarsi delle ovvietà digitali: le persone con poche competenze condividono, commentano, giudicano i più disparati argomenti senza accorgersi di stare esprimendo banalità, pregiudizi e pseudo-conoscenze, molto spesso errate. Un altro aspetto complementare è costituito dal bias della retrospezione, ovvero la tendenza ad esagerare, dopo che si è verificato un evento o conosciuto qualcosa, la propria abilità nell’averlo previsto o la propria conoscenza pregressa. Noto anche come “fenomeno io-lo-so-da- sempre”, questo bias è particolarmente attivo nei nostri comportamenti digitali e può essere dannoso perché fa sembrare le conseguenze degli eventi semplicemente predicibili e, di conseguenza, porta a commettere errori di comprensione, d’interpretazione e comportamentali.
In tal senso, leggendo superficialmente post o notizie che ci sembrano scontate potremmo giudicarle ovvie e pensare che siano informazioni che già avevamo, quando in realtà questa illusione di conoscenza dipende tanto dall’effetto Dunning-Kruger (“conosco più cose di quelle che conosco davvero”), quanto dall’effetto della retrospezione (“già lo conoscevo”).
Dagli aspetti messi in evidenza, si può vedere come la dimostrazione dell’ovvio, intesa come ricondivisione e riproduzione di contenti banali e dati per scontati, è tutt’altro che ovvia: dal vertice sociologico le ovvietà nascondono significati accettati acriticamente e spesso discriminanti, portano a farci percepire che esiste una normalità definibile generalmente; dal vertice psicologico, tutto ciò che ci sembra ovvio non sempre è tale, ma può essere il risultato di trappole cognitive ed emotive che ci spingono a sopravvalutare la nostra conoscenza.
Riferimenti bibliografici
Myers D. G. (2013). Psicologia sociale, McGraw Hill, Milano
Kruger J., Dunning D. (1999), Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments, in Journal of Personality and Social Psychology, vol. 77, n. 6, 1999, pp. 1121-1134
Zerubavel E. (2019), Dato per scontato. La costruzione sociale dell’ovvietà, Meltemi editore, Sesto San Giovanni.

L’angolo dell'anima - Psicosi: sintomatologia e terapia
La psicosi è una forma acuta di sofferenza psichica che può essere paragonata ad un lungo sognare ad occhi aperti senza che la persona se ne renda conto.
A differenza di quanto si pensa comunemente, la psicosi non è un disturbo mentale incurabile e, nella maggior parte dei casi, la persona che soffre di psicosi non è violenta. Questa forma di sofferenza può comparire in una persona su cento, più frequentemente nella prima età adulta.
La psicosi può portare il soggetto a non riuscire più a pensare con chiarezza, convincersi che la propria mente sia sotto il controllo di qualcosa o di qualcuno, non riuscire più a fare le cose che si facevano prima, non riuscire a stare con gli altri o non averne più voglia, non riuscire ad alimentarsi e a dormire come al solito.
I sintomi più comuni sono:i deliri, le allucinazioni, i disturbi nel modo di organizzare i pensieri e di raccontarli, i disturbi delle emozioni, la tendenza a isolarsi dagli altri. Nello specifico, il delirio è un’idea di cui una persona si convince, a cui crede anche completamente e che per gli altri è assurda, non corrisponde alla realtà; mentre le allucinazioni si manifestano attraverso suoni, visioni, odori, sapori, sensazioni avvertiti dalla persona, ma non da tutti gli altri. Tali manifestazioni cliniche possono portare chi ha la psicosi ad isolarsi del tutto dalla vita sociale, a parlare e scrivere in modo strano o incomprensibile e ad avere difficoltà nell’esprimere le emozioni che prova.
A proposito delle cause, non è dimostrato che una situazione familiare o altri singoli fattori (traumi, ereditarietà…) possono direttamente far nascere una sofferenza psicotica; infatti, gli studiosi concordano maggiormente sull’idea che sarebbero fattori diversi a produrre il disturbo psicotico. In altri termini, non è necessaria l’individuazione di una causa della psicosi, ma riflettere sulla complessità dello stato psicotico e della sua genesi che, in alcuni casi, può iniziare fin dall’infanzia. Ad esempio, lo strutturarsi del nucleo psicotico può manifestarsi nei bambini attraverso la tendenza ad isolarsi in un mondo distaccato dalla realtà, alternativo ad esso e, soprattutto, basato principalmente sulla sensorialità e su un’illusoria autosufficienza o onnipotenza.
Per contenere e ridurre i danni alla persona provocati da sintomi psicotici, è importante conoscere i primi segni inziali di crisi come cambiamenti del modo di fare, di pensare e di comportarsi; inoltre, i segni iniziali sono in genere sempre gli stessi in una data persona, ma possono essere molto diversi da persona a persona. Di frequente, una crisi psicotica può essere preceduta da:disturbi del sonno, irritabilità, tensione, non riuscire a stare fermi, parlare di meno/di più ed avere difficoltà a concentrarsi. In questi casi, può essere utile parlarne con il proprio medico, prendere dei farmaci su consiglio del medico, discutere la situazione con persone di cui ci fidiamo, identificare le situazioni di tensione e trovare un modo per superarle. Inoltre, i sintomi della psicosi sono in parte legati anche a uno squilibrio di alcune sostanze chimiche, per questo è fondamentale l’utilizzo di farmaci antipsicotici che aiutano a riequilibrare la quantità di queste sostanze.
Tuttavia, se da un lato il corretto utilizzo di farmaci è indispensabile per contenere le manifestazioni psicotiche più invalidanti e per fare in modo che la persona possa accedere alla psicoterapia, dall’altro è appunto solo la combinazione con un supporto psicoterapeutico che riesce a fare la differenza nel trattamento della psicosi. Inoltre, è molto efficace la psico-educazione, ovvero fornire al paziente e alla famiglia informazioni precise sui sintomi e il decorsodel disturbo in modo tale da aiutarli a gestire la sofferenza.
Da un punto di vista cognitivo-comportamentale, il trattamento si concentra sull’acquisizione di strategia efficaci per la gestione dei sintomi, come ad esempio il riconoscimento, il distanziamento critico e il padroneggiamento dei deliri. In questo modo la persona,formulando ipotesi alternative rispetto alle convinzioni deliranti, attribuisce un senso alla malattia, diviene più consapevole della propria sofferenza ed è, di conseguenza, più motivato a aderire maggiormente alla terapia farmacologica.
Riferimenti Bibliografici
Fallon I., et al. (2019). Intervento psicoeducativo integrato in psichiatria, Erikcson, Trento.
Giberti F., Rossi R. (2009). Manuale di psichiatria. Piccin, Padova.
https://www.terzocentro.it/disturbi-psicotici/disturbo-delirante/

L’angolo dell'anima - Le due facce della solitudine
Il senso di solitudine è una costante della condizione umana che accompagna ognuno di noi nel proprio percorso di crescita.
Il sentirsi soli oscilla continuamente tra due poli: ad un estremo, la solitudine viene esperita come sentimento doloroso associato a isolamento e abbandono, mentre all’altro polo è vissuta come uno spazio privato di introspezione ed espressione della propria soggettività e creatività personale.
La connessione e lo scambio tra questi due poli è la dinamica psicologica che consente alla persona di non rinchiudersi né in un isolamento depressivo, né in un ritiro narcisistico; infatti, il prevalere della solitudine dolorosa edella tendenza all’isolarsi o ritirarsi dalla socialitàsono fattori che possono favorire l’emergere di una psicopatologia da isolamento.
Alcune delle manifestazioni sintomatologichericorrenti in chi soffre per l’isolamento possono essere: incapacità di avere rapporti profondi con gli altri (non avere amici, ma solo conoscenze superficiali) sentirsi soli anche tra molte persone, avere pensieri negativi, dubitare di sé stessi e delle proprie capacità, trovare molto faticosi i contatti con le altre persone.
Dal punto di vista delle neuroscienze, le ricerche sulle aree cerebrali coinvolte nella regolazione emozionale hanno mostrato che esiste una correlazione tra predisposizione genetica e tendenza all’isolamento sociale, tuttavia non è ancora chiaro se è l’isolamento a influire sul funzionamento biologico (innalzamento dell’“ormone dello stress”) o viceversa.
D’altra parte, gli studi e le osservazioni di Melanie Klein (1959) e di Donald Winnicott (1958) sullo sviluppo psicologico e relazionale del bambino conferiscono un certo valore al modo in cui la solitudine viene vissuta a partire dalla prima relazione con la madre fino all’età adulta. La strutturazione psichica del senso di solitudine può essere fatta risalire all’intimo contatto tra madre (o altra figura accudente) e bambino, nel quale la profonda comprensione dei due avviene senza l’uso di parole.
La perdita di questa comprensione totale e preverbale è ciò che fa nascere nostalgia per tale stato infantile, ovveroun senso di solitudine per aver perso una relazioned’intesa e di coinvolgimento esclusivo.
In altre parole, questa esperienza di un rapporto di intima unione con l’altro che si prende cura del bambino lascia una profonda nostalgia dentro ogni essere umano.Affinché ciò non sfoci in esiti psicopatologici (isolamento totale, chiusura in sé stessi), è necessaria un’interiorizzazione degli aspetti buoni delle figure genitoriali per tollerare al meglio l’inevitabile comprensione parzialeche l’adulto incontra nel percorso di conoscenza di sé e nelle relazioni con gli altri.
Da questo punto di vista, seguendo anche le riflessioni teorico-cliniche di Winnicott, la “capacità” di essere solo è una conquista importante per lo sviluppo psichico ed emozionale del bambino. È una capacità fondata sull’accettazione di un paradosso: essere capaci di stare da soli in presenza dell’altro, cioè tollerare l’esistenza di uno spazio privato in sé e nell’altro che non può essere totalmente conosciuto e comunicato.Se la persona sente di poter “essere solo con l’altro”, allora vuol dire che si è costruita un’identità separata dalle figure che lo hanno accudito durante l’infanzia.
È importante distinguere le due facce della solitudine (solitudine creativa e isolamento) e riconoscere che nei momenti più difficili della vita un profondo senso di isolamento può portare non solo ad un evidente ritiro dal mondo sociale, ma anche ad una non comunicazione con sé stessi.
In conclusione, alcuni suggerimenti che consentono, a seconda della persona, di uscire gradualmente dal proprio stato di isolamento e di entrare di nuovo in contatto con gli altri e con sé stessi possono essere: rivolgersi ad uno psicoterapeuta per comprendere il significato del proprio senso di solitudine, cogliere occasioni per socializzare, invitare amici o parenti a casa o uscire per andare a trovarli, restare in contatto con gli altri e farsi coinvolgere da associazioni locali.
Riferimenti Bibliografici
Klein M. (1959), Sul senso di solitudine, in “Il nostro mondo adulto” Martinelli, Firenze 1974.
Winnicott D.W. (1958), The Capacity to be Alone, Int. J. Psycho-Anal., 39, in “Sviluppo affettivo e ambiente” Armando Editore, Roma, 1970.
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/s/solitudine-e-salute
https://www.lettera43.it/solitudine-scienza-patologia-depressione-cura-biologia

L’angolo dell'anima - Psicopatologia e invecchiamento
La sofferenza psichica tipica dell’età senile riguarda spesso il disadattamento, le ansie, le paure, la depressione, il declino cognitivo, caratteristiche che possono assumere diverse connotazioni psicopatologiche anche in relazione all’eventuale comparsa di una delle varie forme della demenza.
Il declino somatico e cognitivo, nella terza età, è solo una delle perdite che l’anziano è chiamato ad affrontare ed elaborare.
Il pensionamento, la morte di amici e parenti, il trasloco dei figli sono gli eventi che segnano l’ultimo ciclo della vita e che richiedono un certo equilibrio psicofisico ed un aiuto specifico per non essere ridotti a semplici esperienze negative, a mancanze che non possono più avere un significato soggettivo.
È, tuttavia, difficile tracciare un confine netto tra disturbi fisici e psichici a causa proprio delle progressive e fisiologiche modifiche dell’organismo. In più, ogni anziano reagisce diversamente alle alterazioni organiche, psichiche e sociali che è costretto a vivere. Per questo motivo, la diagnosi psicopatologica risulta molto complessa e tutti coloro che si occupano della salute degli anziani dovrebbero focalizzarsi più sul malato e non esclusivamente sulla malattia.
Oltre le differenze individuali, le difficoltà psicologiche ed emotive più tipiche si manifestano come un senso di malessere, percezioni di avere troppi sogni irrealizzati, delusioni, difficoltà relazionali, inquietudini, minore autonomia e autostima, assedio dei bisogni e fenomeni regressivi.
Ad esempio, la diminuzione delle capacità di controllo del proprio corpo e sull’ambiente può portare ad una forte demotivazione, sentimenti invasivi di insicurezza e ritiro sociale. Inoltre, in vecchiaia possono ricomparire angosce infantili e conflitti adolescenziali irrisolti che possono mettere in crisi il sentimento di sicurezza, determinato da salute, autonomia, vita familiare e associativa.
La condizione senile è connotata da dimenticanze, smarrimenti, confusioni vissute come rottura dell’equilibrio psicofisico e incapacità di trovare nuovi modelli organizzativi, in grado di riparare e ricostruire ciò che è stato perduto. La sensazione più dura che l’anziano deve affrontare è quella inerente all’impossibilità di arrestare un decadimento che, in effetti, può essere solo rallentato.
Le ansie e le paure prevalenti sono dovute alla prospettiva della solitudine e dell’isolamento, all’eventuale comparsa di malattie invalidanti, alla mancanza di riferimenti stabili, all’incertezza e al senso di vuoto.
Un’angoscia più profonda sembra essere causata dai cambiamenti esteriori del proprio corpo: il tempo trascorso non riesce ad essere adeguatamente accettato e rappresenta un motivo di disadattamento, di smarrimento o depressione. L’anziano può ricorrere a vari espedienti per occultare il cambiamento e arginare la sua sofferenza che però, in questa maniera, può aumentare.
Ad ogni modo, ciò non impedisce di offrire la possibilità di alleviare una condizione di fragilità e sofferenza con un aumento della qualità di vita. Infatti, tali involuzioni possono essere contrastate attraverso interventi riabilitativi e psicoterapeutici affinché l’anziano diventi consapevole dei cambiamenti che sta vivendo, capace di fronteggiare gli ostacoli ambientali in maniera nuova e, quindi, vivere un maggiore coinvolgimento sociale.
Nonostante le forti resistenze, dovute spesso a falsi miti, l’aiuto psicoterapeutico ad orientamento cognitivo-comportamentale può essere utile in quanto utilizza tecniche adattabili e di facile gestione per la persona anziana, influenzata dai vai cambiamenti provocati dalla terza età.
Per esempio, la rappresentazione grafica degli esercizi e dei compiti da svolgere favorisce la comprensione e l’elaborazione dei contenuti, oltre che ridurre l’ansia associata al dover affrontare qualcosa di nuovo.
L’obiettivo del supporto psicologico è quella di far riscoprire all’anziano, attraverso varie tecniche, le proprie capacità creative in modo che possa elaborare progetti che gli permettano di trasferire tale ricchezza creativa al quotidiano.
Riferimenti bibliografici
Belloni Sonzogni, A.;Cristini, C. (2021).Psicopatologia e invecchiamento nell’opera di Marcello Cesa-Bianchi / in Ricerche di psicologia : 1, Milano : Franco Angeli, 2021.

L’angolo dell'anima - La dipendenza da cibo: sintomi e origini socio-cognitiva
La dipendenza da cibo si caratterizza per il consumo compulsivo di alimenti desiderabili (cibi grassi, zuccherati…) capaci di attivare il sistema di ricompensa, nonostante gli effetti negativi. Come ogni addiction, il rapporto di dipendenza tra persona e cibo si manifesta con una forte perdita del controllo di sé stessi, un senso di vergogna, un senso di colpa/fallimento e una forte difficoltà a mantenere l’impegno e la promessa a non ricadere in quel comportamento.
A differenza dei disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia, bingeeating), la dipendenza di cibo non induce a comportamenti compensatori come vomito, uso di lassativi, attività fisica eccessiva ed è ristretta ad un particolare tipo di alimenti.
Un’altra differenza è quella con la “fame nervosa”, caratterizzata da un’attivazione indipendente dal bisogno di cibo e da un consumo di cibo veloce ed esagerato. Tuttavia, le differenziazioni tra disturbi dell’alimentazione e dipendenza da cibo sono ancora oggetto di studio e di ricerche: non esiste consenso definitivo sul concetto di dipendenza da cibo, né sulla possibilità di far coincidere questa condizione con la dipendenza da abuso di sostanze.
Ad esempio, tra le cause di dipendenza di cibo si riscontrano fattori generici, tra cui variazioni dell’umore, gravidanza, periodi di stress,ansia che non permettono di definire con esattezza due condizioni cliniche completamente separate.
Al di là delle categorizzazioni diagnostiche, è interessante considerare l’origine socio-cognitiva della dipendenza da cibo, direttamente legata all’evoluzione della specie e al cambiamento dei bisogni primari dei significati che l’uomo attribuisce al cibo.
Al giorno d’oggi, nei paesi più ricchi, ognuno può scegliere la propria dieta: la possibilità di mangiare e di avere accesso ogni giorno ad un’infinità di alimenti diversi crea ansia e rende difficile il controllo e la regolazione.
Questa possibilità di scelta mette alla prova il nostro sistema cognitivo che deve elaborare numerosi fattori legati all’alimentazione tra cui, soprattutto, il valore nutritivo del cibo e la gradevolezza del gusto, due elementi che nell’alimentazione moderna sono sempre più spesso dissociati. Tale dissociazione crea possibili difficoltà nella stima dell’apporto calorico andando a rendere meno lineare il processo cognitivo secondo cui la gradevolezza del gusto è generalmente connessa al valore che il cibo assume nel nostro cervello: più alta è la gradevolezza, più alta è la ricompensa che ne traiamo ingerendolo. Infatti, l’alimentazione quotidiana richiede un raffinato bilanciamento tra meccanismi biochimici e cognitivi che ci inducono sia alla ricerca e all’assunzione del cibo, sia all’inibizione dell’impulso ad assumere più nutrienti di quelli necessari.
Questo cambiamento nella tendenza alla ricerca del cibo e alla preferenza per i cibi a più alto contenuto calorico (molto prezioso in termini evoluzionistici) è all’origine della trasformazione del cibo da bene primario per la sopravvivenza a oggetto di dipendenza per il suo valore di ricompensa.
In altri termini, il consumo di cibo può disregolare i meccanismi cognitivi e cerebrali legati alla ricompensa e alla motivazione, stimolandoli in maniera eccessiva e sostituendosi alle ricompense naturali.
In questo quadro, il cibo occupa una funzione molto speciale: è necessario alla sopravvivenza (a differenza delle sostanze d’abuso) e ha un valore di ricompensa, diventando così un oggetto di dipendenza e d’abuso ancora più difficile da riconoscere e gestire.
In conclusione, la breve ricostruzione del modo in cui il consumo di cibo è diventato una dipendenza permette di sottolineare una grande particolarità: il soggetto dipendente dal cibo è costantemente costretto a relazionarsi con l’oggetto fonte di sofferenza e disagio, rendendo più complicato l’evitamento e la differenziazione tra gli aspetti positivi e quelli negativi del suo modo di alimentarsi.
Questa specificità pone nuovi importanti interrogativi sulla cura e sul trattamento di questo particolare tipo di sofferenza.
Riferimenti bibliografici
Mengotti P., Foroni F. (2015). Il cibo tra desiderio e inibizione: processi cognitivi e correlati neurali, in Neuroetica e dipendenza.
Meule, A., Gearhardt, A. N. (2014). Food addiction in the light of DSM-5. Nutrients. 2014 Sep 16;6(9):3653-71. doi: 10.3390/nu6093653.
https://apc.it/disturbi/adulto/anoressia-e-bulimia/disturbi-alimentazione/

L’angolo dell'anima - Depressione: caratteristiche e terapia cognitivo-comportamentale
La depressione è una forma di sofferenza psichica che si manifesta, in generale, con uno stato d’animo di profondo dolore o tristezza e una mancanza di energia e di voglia di fare le cose. Può colpire una persona ogni venti, durare a lungo e, in una persona su due, si ripete più volte.
Si tratta di una malattia che crea molte difficoltà nella vita sociale, personale e lavorativa di chi ne soffre, per questo motivo non è utile incolpare o dire a chi soffre di impegnarsi, di metterci tutto sé stesso per stare bene.
I sintomi principali della depressione maggiore sono umore depresso e perdita di interesse nel fare le cose; insieme a questi possono comparire disturbi dell’appetito e cambiamenti di peso, disturbi del sonno, stanchezza, difficoltà di concentrazione e di memoria, disturbi della velocità dei movimenti e dei pensieri, senso di colpa e idee di morte. Inoltre, sono frequenti anche sintomi d’ansia, come palpitazioni, nodo alla gola e tremori. Tra le componenti psicologiche che contraddistinguono la depressione sono ricorrenti la ruminazione mentale (continuo e ripetitivo interrogarsi), il ritiro (riduzione o evitamento dei contatti sociali), autovalutazione negativa (tendenza a denigrarsi e a valutarsi come inutile), negativismo (fare previsioni negative sul mondo e sul futuro).
Da un punto di vista epidemiologico, in più della metà dei casi, la depressione si manifesta per la prima volta tra i 20 e i 30 anni e, in 28 persone su 100, prima dei 18 anni. I dati sulla guarigione affermano che a distanza di un anno, se curata, questa forma di sofferenza psichica in 50 pazienti su 100, guarisce completamente e in altri 20 pazienti su 100, si attenua molto.
I fattori di rischio riguardano situazioni ambientali, psicologiche e biologiche che aumentano la probabilità di una persona di ammalarsi. In questi casi, in chi è sensibile alla depressione,se lo stress supera le capacità di tolleralo,possono cominciare i sintomi e si può avere uno squilibrio di alcuni neurotrasmettitori. Tuttavia, per curare la depressione è necessario non solo equilibrare alcuni neurotrasmettitori con i farmaci, ma anche rendere più forte la persona di fronte allostress con interventi psicologici e psicoterapeutici.
La terapia cognitivo-comportamentale è uno degli approcci che maggiormente si utilizza nella cura della sofferenza depressiva e si differenzia dagli altri modelli in quanto lavora sui modi in cui la persona interpreta, reagisce e valuta le esperienze della sua vita e sé stesso. Questa terapia si basa sull’individuazione e modificazione dei pensieri e delle convinzioni negative della persona, grazie all’aiuto del terapeuta. La regolazione dell’umore e la sintomatologia dipendono, infatti, anche dalle modalità di pensiero e dal comportamento quotidiano della persona. Per questo motivo, lavorare su questi due aspetti, invitando il paziente a mettere in atto piccoli cambiamenti, può determinare una stabilizzazione dell’umore e una diminuzione dell’isolamento sociale, caratteristici di questo disturbo.
In questo modo, terapeuta e paziente iniziano a lavorare sul cambiamento cognitivo tramite il cambiamento comportamentale. La progressiva attivazione del comportamento consente alla persona di sentire sollievo e sensazioni positive che saranno il punto di partenza per un fondamentale cambiamento cognitivo, ovvero riconoscere la scarsa fondatezza dei pensieri negativi su stesso, sulle sue capacità, sulla possibilità di provare piacere. Le tecniche di bravura e piacere sono, infatti, un’altra applicazione che può essere utile nel lavoro con il paziente depresso, il quale tende a rinchiudersi in circoli cognitivi del tipo “non merito di divertirmi perché non ho realizzato niente”.
Per contrastare questa convinzione negativa il terapeuta può invitare il paziente a intraprendere un’attività gratificante per un certo periodo di tempo durante il giorno e a scrivere i suoi cambiamenti di umore e i pensieri ricorrenti depressivi legati a quell’attività. La prova cognitiva, l’addestramento all’assertività, l’assunzione di ruoli, la programmazione delle attività sono le altre principali tecniche grazie alle quali il paziente, insieme al terapeuta, può trovare una via d’uscita dalla sua grande sofferenza.
BIBLIOGRAFIA
Beck A. T., Rush J. H., Shaw F. B., Emery G. (1987). Terapia cognitiva della depressione. Bollati Boringhieri, Torino, 2002.
Giberti F., Rossi R. (2009). Manuale di psichiatria. Piccin, Padova.

L’angolo dell'anima - Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) nell’età evolutiva
Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) si caratterizza per la presenza di ossessioni e compulsioni che creano un forte disagio nelle diverse aree di vita del soggetto.
Le ossessioni sono pensieri o immagini che ritornano nella mente della persona in maniera ricorrente e persistente e che vengono giudicati come incontrollabili, ingiustificati e irrazionali. Spesso sono associate ad ansia, paura e disagio. Le ossessioni più comuni tra bambini e adolescenti sono composte da pensieri sulla contaminazione, immagini violente e preoccupazioni sul proprio corpo.
Altri tipi di ossessione possono riguardare la religione, numeri speciali, parole o colori. Durante l’età evolutiva c’è una forte tendenza a reprimere, resistere o ignorare le ossessioni, mentre in età adulta le strategie per controllarle diventano più complesse. Ad esempio, pensieri ossessivi possono essere del tipo: “Potrei infettarmi se tocco la maniglia del bagno”, “Se non controllo che tutte le luci siano spente, succederà qualcosa di negativo”, ecc.
Le compulsioni sono comportamenti ripetitivi o attività mentali utilizzati per diminuire l’ansia, l’angoscia dalle ossessioni. Non sono intrinsecamente dirette a uno scopo o ad una gratificazione e, così come le ossessioni, possono avere una funzione adattiva. Tuttavia, quando le compulsioni sono eccessive e rigide, vengono considerate patologiche.
Quelle più diffuse in età evolutiva includono il lavarsi, pulire, controllare, toccare o altri rituali mentali (contare, ripetere parole o frasi…). È importante notare che anche quando le compulsioni sembrano essere impiegate per neutralizzare le ossessioni, non sempre sono legate in maniera razionale (ad es., ordinare dei giocattoli per controllare un’ossessione per i germi).
Studi diversi hanno individuato il DOC anche in bambini di 2 anni di età,con un’età media di insorgenza tra gli 8 e gli 11 anni. I maschi hanno un’età di insorgenza (prima della pubertà) più precoce rispetto alle femmine. Tuttavia, in generale, entro la fine dell’adolescenza, i tassi di prevalenza tra maschi e femmine sono simili.
Lo sviluppo del DOC e dei suoi meccanismi cognitivi non sono ancora stati compresi del tutto. È stato ipotizzato che i bambini e gli adolescenti possono svilupparlo quando si preoccupano eccessivamente per individui o situazioni quotidiane. I cognitivisti pensano che si attivi una sorta di fusione tra pensiero e azione, ovvero una diminuzione della capacità di distinguere la realtà e i comportamenti dai pensieri.
Questo bias cognitivo provoca un forte senso di responsabilità e porta alla creazione delle ossessioni e di comportamenti compulsivi. Per esempio, un bambino può essere ossessionato dal pensiero che accadrà qualcosa di brutto al genitore se non mette in atto una determinata azione e, per questo, prova un forte senso di responsabilità nei suoi confronti.
Questo stile di elaborazione cognitiva dà origine a sentimenti di impotenza che aumentano la ruminazione e le auto-accuse. Inoltre, il tentativo di sopprimere le ossessioni apporta un leggero sollievo, ma in realtà la soppressione dell’ossessione serve solo a perpetuare e a mantenere la sintomatologia DOC.
Un altro fattore importante nello sviluppo del DOC durante l’età evolutiva riguarda l’ambiente familiare. Un’ipotesi è che gli ambienti familiari caratterizzati da elevati livelli di stress e ansia aumentano il rischio di disturbo ossessivo compulsivo perché sembra aumentare la probabilità che i bambini e gli adolescenti percepiscano il mondo come intrinsecamente pericoloso e come luogo in cui la prudenza deve costantemente essere esercitata.
Inoltre, l’iperprotezione dei genitori e le critiche per i fallimenti per non aver preso adeguate precauzioni contro il pericolo sono influenti.
Numerosi altri fattori relativi all’ambiente familiare possono influire sul DOC: ad es., la mancanza di calore emotivo e di controllo sugli eventi esterni, le interazioni genitore-figlio caratterizzate da un coping evitante e da interpretazioni comportamentali fondate sulla minaccia.In più, sono importanti anche gli atteggiamenti e gli stili di pensiero che si sviluppano durante gli anni dell’adolescenza.
Uno degli interventi che si può utilizzare, sia con adulti che con bambini/adolescenti, è l’Esposizione con Prevenzione della Risposta (ERP), una tecnica cognitivo-comportamentale che può aiutare a ridurre la sintomatologia.
L’ERP consiste in un’esposizione graduale e prolungata a stimoli o situazioni temute e in una astinenza dal comportamento compulsivo. Sebbene l’inibizione della risposta inizialmente aumenti l’ansia, in assenza della compulsione, l’estinzione della paura è rafforzata. In generale, viene introdotta una gerarchia graduata di stimoli paurosi, che consente al bambino o all’adolescente di aumentare la propria abilità nella gestione delle ossessioni.
Un altro intervento comportamentale è il training sulla gestione dell’ansia (AMT) che prevede l’insegnamento di diverse tecniche di respirazione e di rilassamento. Durante questo tipo di interventi comportamentali i bambini e gli adolescenti sono aiutati a cambiare le loro convinzioni imprecise su stimoli temuti e, allo stesso tempo, ricevono suggerimenti comportamentali diretti per ridurre comportamenti compulsivi. L’obiettivo specifico è quello di insegnare a bambini e adolescenti a identificare, accettare e correggere le loro convinzioni disfunzionali su ciò che li ossessiona. Infatti, gli studi dimostrano buoni risultati e un mantenimento dei benefici del trattamento.
Nell’ambiente familiare, il DOC può avere un profondo impatto negativo sulla vita degli altri membri della famiglia perché i sintomi del disturbo ossessivo-compulsivo sono onnicomprensivi e le compulsioni possono coinvolgere tutti. Infatti, il termine “family accommodation” è spesso usato per riferirsi a risposte familiari che sono direttamente (ad es., partecipazione o assistenza nei rituali) o indirettamente (ad es., modifica dello stile di vita della famiglia in base ai sintomi) parte della sintomatologia.
Per questo motivo, le famiglie dovrebbero essere coinvolte interventi psicosociali quando possibile, anche perché l’intervento sulla famiglia da solo può essere sufficiente per ridurre dei comportamenti compulsivi.
In conclusione, si può dire che il DOC è comune durante l’infanzia e l’adolescenza e che molte teorie hanno cercato di delineare le varie dimensioni implicate nella genesi e nella cura di questo tipo di sofferenza.
La maggior parte dei clinici concorda sul fatto che è importante agire attivamente sul coinvolgimento della famiglia, oltre che sull’influenza dei fattori biopsicosociali.
Riferimenti bibliografici e sitografici
Buonanno, C., Perdighe, C., & Mancini, F. (2009). La psicoterapia del disturbo ossessivo compulsivo in età evolutiva. Giornale Italiano di Neuropsichiatria Infantile, 23(3), 290-308.
Mancini, F., & Buonanno, C. (2010). Il disturbo ossessivo-compulsivo in età evolutiva: un protocollo di esposizione e prevenzione della risposta (EPR) adattato a bambini ed adolescenti. Il disturbo ossessivo-compulsivo in età evolutiva, 1000-1009.
Krebs G, Heyman I. (2015). Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. Arch Dis Child. 2015 May;100(5):495-9. doi: 10.1136/archdischild-2014-306934.

L’angolo dell'anima - Genere e Adolescenza
Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha cominciato a usare differenti termini per distinguere i diversi aspetti che compongono il concetto di identità sessuale.
Per identità sessuale si intende l’identità complessiva della persona, l’insieme dei piani, delle dimensioni e degli aspetti (corporei, mentali, relazionali) con cui la persona si identifica, viene identificata e si fa identificare dagli altri. Si tratta di una realtà a più dimensioni, che non smette di specificarsi e definirsi, dalla nascita all’età adulta e oltre. Questo costrutto multidimensionale è composto da: il sesso biologico, l’identità di genere, il ruolo di genere e l’orientamento sessuale.
Il sesso biologico indica la conformazione sul piano biologico del corpo per come è definita dai cromosomi sessuali, dagli ormoni, dai genitali esterni e interni. Indica l’anatomia di una persona e l’appartenenza, sul piano biologico, al sesso maschile, femminile o a altre varianti dello sviluppo sessuale.
Il termine genere racchiude la percezione che ognuno ha di sé in quanto maschio o femmina (identità di genere), ma anche il sistema socialmente costruito intorno a quelle stesse identità (ruolo di genere). In altri termini, l’identità di genere indica, per esempio, se una persona si autopercepisce interiormente come maschio o femmina, o secondo altre declinazioni di genere possibili, mentre il ruolo di genere evidenzia sia l’insieme di aspettative sociali che definiscono come gli uomini e le donne debbano essere (caratteristiche esteriori) in un dato contesto storico e culturale, sia il modo in cui ciascuno ha interiorizzato tali ruoli socialmente definiti e come, di conseguenza, esprime la propria appartenenza ad un genere. Di solito, l’identità di genere si stabilisce all’incirca entro il terzo anno di vita.
L’orientamento sessuale riguarda l’attrazione emotiva, affettiva ed erotica, la predisposizione dell’individuo a sentirsi fisicamente ed emozionalmente attratto da caratteristiche dell’uno, l’altro o entrambi i sessi/generi (o in modo indipendente da tali caratteristiche). Racchiude tre categorie: eterosessualità (attrazione verso il sesso opposto), bisessualità (verso entrambi i sessi), omosessualità (verso il proprio sesso).
Inoltre, l’identità di orientamento sessuale riguarda la definizione di sé a partire dall’idea che l’individuo ha del proprio orientamento sessuale, dal giudizio che ne dà e dalla sua disponibilità a riconoscerlo e svelarlo a sé e agli altri. Il concetto di fluidità sessuale si riferisce a questa dimensione dell’identità sessuale e indica la capacità di cambiamento nella vita dell’individuo della sua definizione del proprio orientamento sessuale, del suo modo di vivere le sue relazioni sessuali ed affettive.
La scoperta del proprio modo di essere e della propria identità sessuale richiede un percorso di maturazione affettiva e del pensiero frutto di una continua interazione con l’ambiente sociale e culturale, che può agire in senso facilitante o inibente. Quest’esplorazione è particolarmente attiva durante l’adolescenza, periodo in cui i cambiamenti fisici, emotivi e relazionali impongono molti quesiti sulla sessualità e sul proprio equilibrio interiore. In tale percorso possono influire una serie di fattori: a) la considerazione che l’adolescente ha di sé stesso/a (autostima e autoefficacia); b) le aspettative dei genitori, degli adulti significativi, del gruppo dei pari; c) le norme e le pratiche culturali e morali inerenti ai “ruoli di genere”,alla sessualità, ai canoni estetici e di prestazione, all’esplorazione identitaria, alla masturbazione, alla precocità dei rapporti.
Spesso gli adolescenti soffrono in merito alla loro identità sessuale e a volte sviluppano veri e propri comportamenti “a rischio” e/o disturbi psicopatologici. Si può parlare di una prima forma di disagio legata all’oppressione e allo stigma, indizi di una difficoltà della società e della comunità a essere inclusive e plurali. Una seconda forma di disagio, centrata sul singolo, può essere legata al “come” ciascuno vive l’orientamento sessuale, l’identità di genere, le dimensioni del desiderio, della dipendenza e dell’autonomia dentro le relazioni.
Inoltre, può accadere che l’identità sessuale venga “usata” dagli adolescenti come mezzo per sostenere la propria fragile autostima. In tal caso la crescita della persona, in direzione etero-, bi- o omo-sessuale è influenzata anche dal fatto che l’oggetto d’amore è rigidamente connesso con il livello di autostima personale: l’adolescente può pensare che “se non trovo qualcuno, non valgo”, ma anche “se non mi definisco, non valgo”, o “se non sono eterosessuale, non valgo, perché non sono un vero uomo (o una vera donna)”. In sintesi, l’esplorazione dell’identità sessuale in adolescenza dovrebbe avvenire in modo da favorire la consapevolezza e la differenziazione dei livelli, ovvero riuscire a non confondere il livello dell’orientamento sessuale con quello dell’identità di genere e a sviluppare ciascuno di questi livelli, oltre a integrare ed esprimere aspetti del “maschile” e del “femminile”, senza che ciò equivalga a una confusione sulla propria identità.
Una forma più strutturata di disagio è quella che si indica con il termine disforia di genere, ovvero una condizione di sofferenza che può accompagnare l’incongruenza tra il genere esperito o espresso da un individuo e il genere assegnato (American Psychiatric Association, 2013); essa può verificarsi con diversi gradi di intensità, dove la forma più estrema è di solito accompagnata da un forte desiderio di riassegnazione di genere. È importante evidenziare che nell’ultima edizione del DSM-5 l’etichetta diagnostica è passata da «disturbo dell’identità di genere» a «disforia di genere». Tale cambiamento elimina l’elemento potenzialmente stigmatizzante del termine «disturbo». Inoltre, in questa edizione, la categoria diagnostica «disforia di genere» ha trovato una sua più definita collocazione con criteri diagnostici più descrittivi rispetto a quelli delle edizioni precedenti.
Queste varie forme di disagio dipendono anche dal modo in cui tutti noi veniamo inconsapevolmente socializzati al genere nella famiglia, a scuola e sui media.
Nella famiglia i genitori tendono ad avere aspettative diverse riguardo ai figli maschi o alle figlie femmine, che agiscono sul modo in cui il comportamento viene interpretato, sugli stili relazionali che i genitori intrattengono con i figli e sull’interiorizzazione delle aspettative genitoriali rispetto alle predisposizioni/attitudini dei figli. Ad esempio, un’emotività contraria alle aspettative di genere (aggressività in una bambina, pianto e paura in un bambino) può essere percepita come fastidiosa e sbagliata, quindi verrà scoraggiata anziché assecondata; oppure, ancora per esempio, se un bambino si aspetta di essere dotato per la matematica, potrà affrontarla con maggiore ottimismo e motivazione, confermando le aspettative di partenza di una sua predisposizione.
La scuola rappresenta un contesto in cui le differenze tra maschi e femmine vengono strutturate e amplificate. Le ricerche hanno evidenziato tre fattori che tendono a influire sul genere. Questi fattori sono: le risposte degli insegnanti e del personale scolastico ai comportamenti del bambino/a; i supporti educativi e i materiali didattici; le relazioni con i compagni. In quest’ultimo caso, il genere è un regolatore importante del rapporto con i pari, che incoraggia vicendevolmente a fare “cose da maschio” o “da femmina”, a prendere in giro l’altro quando questo non succede, a raccogliere preziosi esemplari di supereroi simbolo di maschilità o di fatine simbolo di femminilità.
Nei media è diffusa una rappresentazione estremamente tipizzata per genere che ha un effetto diretto sulla definizione delle regole di popolarità tra pari e che amplifica i meccanismi della socializzazione di genere messi in atto dai compagni. Inoltre, se in passato la spinta mediatica verso i modelli di genere era soprattutto normativa e costrittiva, al contrario oggi la liberazione dei costumi ha determinato una spinta verso modelli di genere fondati sulla desiderabilità sociale, su promesse di felicità e successo che spingono bambini e adolescenti a aderire acriticamente agli stereotipi proposti.
In sintesi, famiglia, scuola e mass media possono essere considerati parti di un complesso e interdipendente sistema di socializzazione del genere in cui la definizione dell’identità sessuale si intreccia continuamente con fattori individuali e sociali che si influenzano vicendevolmente. In altre parole, l’apparente diffusione e liberalizzazione delle tematiche legate al genere non può essere considerata tout court un fattore che influenza, positivamente o negativamente, il processo di affermazione della propria sessualità in quanto il bambino o l’adolescente sono portatori di una propria soggettività capace di elaborare in maniera personale gli stimoli e le influenze sociali. La paura e gli allarmi verso il predominio di un’ipotetica “teoria gender” sembrano essere una risposta difensiva della società che, quando non scade in fondamentalismi ideologici, evidenzia un interrogativo centrale per la costituzione dell’essere umano: quale significato attribuire alla differenza dei sessi? Cosa accade se si va oltre il binarismo sessuale?
Tornando sul piano individuale, in età infantile e adolescenziale l’affermazione della propria identità sessuale diviene più complicato perché esiste una forte difficoltà ad ammettere che la variabilità di genere e di orientamento rappresentano una condizione propria di molti bambini e bambine a partire dalla più tenera età, di cui dovremmo prenderci cura con rispetto. Infatti, anche quando bambini e adolescenti vivono situazioni di disforia di genere, è fondamentale tenere presente che questa non si traduce direttamente nel fatto che da grandi saranno transessuali o in una condizione di forte malessere. Inoltre, un’atipicità di genere, espressa durante l’infanzia o adolescenza, è perfettamente compatibile con uno sviluppo dell’identità di genere cisgender e di un orientamento eterosessuale, nonostante sia emersa con maggiore frequenza un’associazione tra atipicità di genere infantile e omosessualità. Per questo motivo, in generale, un atteggiamento sano da parte degli adulti è caratterizzato da: rispetto delle preferenze e dei sentimenti dei bambini; garanzia di un amore incondizionato nei loro confronti; aiuto a capire le aspettative di genere della società senza che queste implichino un difetto del bambino; supporto nell’affrontare le conseguenze sociali di un’atipicità di genere.
La cura professionale per gli adolescenti con disforia di genere è attualmente oggetto di discussione scientifica, ma è possibile distinguere almeno due orientamenti.
Il primo permette di intervenire precocemente per assecondare incondizionatamente la non conformità di genere risultata in disforia. Questo vuol dire consentire l’arresto dello sviluppo puberale, così da non incrementare la condizione di disforia e offrire trattamenti precoci di inibizione dello sviluppo ormonale (non terapie ormonali vere e proprie), che concedono alla persona di prendersi del tempo per capire e se scegliere la riassegnazione chirurgica del sesso. La soppressione della pubertà è intesa come un ulteriore concessione di tempo per elaborare la disforia attraverso protocolli terapeutici che includono il supporto psicoterapeutico all’individuo e alla famiglia e un più complessivo lavoro sul contesto di vita della persona (a partire dalla scuola). In questo modo, la “risoluzione” della disforia potrebbe portare ad una “riattivazione” del percorso puberale in senso congruente o meno rispetto al sesso biologico e al genere assegnato alla nascita.
Il secondo considera che l’arresto della pubertà fa rimanere la persona in uno stato “più indifferenziato” rispetto al gruppo di pari. Per tale motivo, si lascia che l’individuo venga socializzato secondo i ruoli e l’espressione di genere congruente con il genere assegnato alla nascita in modo tale da evitare che i bambini con disforia di genere vadano incontro stigmatizzazioni gravi o a scelte affrettare sulla propria identità sessuale. Questo non esclude l’importanza di una maggiore apertura della società verso la non conformità di genere, così come non impone l’uniformazione dell’identità sessuale del bambino alle idee sul genere più accettate socialmente.
In generale, il supporto psicologico e psicoterapeutico agli adolescenti gender variant risulta necessario per consentirgli di intraprendere una soggettivazione del proprio percorso di crescita e della propria personalità che potrebbe essere ostacolata dalle forti stigmatizzazioni e incomprensioni vissute fin dall’infanzia.
In un’ottica non correttiva, l’intervento psicologico mira a sostenere questi adolescenti qualunque decisione essi vogliano prendere, aiutandoli a fare chiarezza nella propria confusione e ad aiutare i loro genitori affinché accettino la possibilità di avere un figlio diverso dalle proprie aspettative. È interessante sottolineare che l’identità di genere di un adolescente non è da considerare prioritaria rispetto ad altre questioni legate alla crescita e allo sviluppo in quanto si sta lavorando, prima di tutto, con adolescente che sta cercando di trovare il proprio posto nel mondo. Questo non significa divenire spettatori passivi di quanto accade e di quanto queste persone sono costrette a subire quotidianamente, ma cercare di riuscire a comprendere le difficoltà sociali e l’esperienza soggettiva di ogni bambino o adolescente gender variant.
È fondamentale intraprendere un percorso a stadi in modo da lasciare aperte le diverse possibilità di definizione dell’identità di genere e attendere il tempo sufficiente per gli adolescenti ed i loro genitori di assimilare i cambiamenti in atto. Soltanto dopo una completa valutazione degli aspetti psicologici, familiari e sociali e dopo il riscontro di una persistenza della varianza di genere è possibile iniziare a pensare un percorso di transizione.
Riferimenti bibliografici
Amodeo A. M., Scandurra C., Valerio P. (a cura di) (2014). Appunti sul genere. Riflessioni sulle linee-guida di intervento psicologico e dintorni. Edizioni Ordine Psicologi della Campania.
Ferrari F., Ragaglia E. M., Rigliano P. (a cura di) (2017). Il “Genere”. Una guida orientativa. Ebook Società Italiana di Psicoterapia per lo studio delle Identità Sessuali.
Miscioscia M., Rigo P., Spandri M., Cerantola D., Simonelli A. (2020). La disforia di genere in età evolutiva: questioni diagnostiche e aspetti relazionali. Una rassegna narrativa della letteratura, in “Giornale italiano di psicologia, Rivista trimestrale” 1/2020, pp. 231-262, doi: 10.1421/96609

L'angolo dell'anima - Gli errori cognitivi: i Bias
A ciascuno di noi piace essere d’accordo con le persone che sono d’accordo con noi e ciascuno di noi tende ad evitare individui o gruppi che ci fanno sentire a disagio. Si tratta di una modalità di comportamento preferenziale che porta al bias di conferma, ovvero l’atto di riferimento alle sole prospettive che alimentano i nostri punti di vista preesistenti.
Bias di gruppo
Molto simile al bias di conferma è il bias di gruppo, che ci induce a sopravvalutare le capacità ed il valore del nostro gruppo, a considerare i successi del nostro gruppo come risultato delle qualità dello stesso, mentre si tende ad attribuire i successi di un gruppo estraneo a fattori esterni non insiti nelle qualità delle persone che lo compongono.
Bias di Ancoraggio
Con questo bias, nel prendere una decisione tendiamo a confrontare solo un insieme limitato di elementi: l’errore è quello di ancorarsi, cioè fissarsi su un valore che viene poi usato, arbitrariamente, in modo comparativo, cioè come termine di paragone per le valutazioni in atto, invece che basarsi sul valore assoluto.
Fallacia di Gabler
Un altro bias cognitivo frequente è la cosiddetta fallacia di Gabler, ovvero la tendenza a dare rilevanza a ciò che è accaduto in passato, così che i giudizi attuali siano del tutto influenzati da tali eventi passati. In virtù di questo bias cognitivo chi ha ricevuto un giudizio positivo nel passato tenderà a ricevere un giudizio positivo anche nel presente, anche a dispetto delle reali prestazioni attuali, che potrebbero essere negative o in calo rispetto a quelle passate.
Nell’errore per somiglianza, apprezziamo nell’altro aspetti simili a quelli che riconosciamo in noi stessi; mentre nell’errore per contrasto, al contrario, apprezziamo i tratti di personalità diametralmente opposti ai nostri: il risultato può portare a sovrastimare negli altri quei tratti che riconosciamo opposti ai nostri. Per esempio se siamo timidi o introversi saremo indotti da questo bias cognitivo a giudicare gli altri più sicuri ed estroversi di quanto siano in realtà.
Bias di proiezione
Simile è il bias di proiezione, per il quale pensiamo che la maggior parte delle persone la pensi come noi. Questo errore cognitivo si correla al bias del falso consenso per il quale riteniamo che le persone non solo la pensino come noi, ma anche che siano d’accordo con noi.
Bias della negatività
Comporta un’eccessiva attenzione rivolta verso elementi negativi, che vengono anche considerati come i più importanti. A causa di questa distorsione cognitiva, si tende a dare maggior peso agli errori, sottovalutando i successi e le competenze acquisite ed attribuendo così una valutazione negativa alla prestazione.
Bias dello status quo
E’ una distorsione valutativa dovuta alla resistenza al cambiamento: il cambiamento spaventa e si tenta di mantenere le cose così come stanno. La parte più dannosa di questo pregiudizio è l’ingiustificata supposizione che una scelta diversa potrà far peggiorare le cose.
Bias del pavone
In relazione a questo bais, siamo indotti a condividere maggiormente i nostri successi, rispetto ai nostri fallimenti. L’uso che la maggior parte delle persone fa dei social è una fotografia esaustiva di questo tipo di bias. Sui social, infatti, le persone tendono a mostrare per lo più un’immagine positiva di sé, tanto da far sembrare la vita di tutti ideale.
Illusione della frequenza
In questo caso, il cervello tende a selezionare informazioni che ci riguardano – per esempio a farci notare donne con i capelli corti se per esempio ci siamo appena tagliate i capelli corti o auto rosse se abbiamo appena acquistato una macchina rossa – il nostro errore di valutazione è quello di credere che ci sia realmente un incremento nella frequenza di donne con i capelli corti o di macchine rosse, cioè tendiamo a sovrastimare la frequenza di informazioni che ci riguardano.
Bias dell’ottimismo
Questo bias ci porta a ritenere l’essere umano più ottimista che realista, nonostante ci piaccia pensare di essere creature razionali capaci di fare giuste previsioni sulla base di valutazioni obiettive.
Questa tendenza a percepire il futuro roseo, anche paragonandolo al passato e al presente, è nota come bias dell’ottimismo e ci riguarda tutti, indipendente dall’età, dal sesso, dalla condizione economica e sociale.
Questo atteggiamento mentale sopravvive generalmente anche in tempi di crisi, di momenti difficili, perché la nostra mente se la cava immaginando un difficile futuro per la collettività ma non per se stessi.

Violenza di genere, salvate sei mamme
Sei donne vittime di violenza, con i propri figli, hanno chiesto aiuto e sostegno alla “Luna diamante”.
Questo il primo bilancio dell’attività che sta svolgendo sul territorio cittadino la Casa della Donna, nell’ambito del programma contro la violenza di genere promosso dal Piano di Zona “S2” in collaborazione con la cooperativa sociale “La Città della Luna” e il dottor Paolo Landi, psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale.
«Il tratto comune tra queste donne? Nessuna ha portato con se oggetti frutto di esistenze significative, dai documenti scaduti fino ad un semplice rossetto – raccontano gli operatori impegnati quotidianamente ad aiutare le vittime di violenza a lasciarsi alle spalle un vissuto doloroso -.
Segnali che la loro di identità era ormai stata sommersa da abusi e violenza in genere». Dalla data di apertura di questa struttura a indirizzo segreto, il primo aprile scorso (cui è seguita la presentazione ufficialmente ad agosto), sono sei le donne ed altrettanti i bambini ospitati. Si tratta di due persone italiane e quattro straniere.
Tre complessivamente le esperienze concluse, con il raggiungimento dell’autonomia da parte delle donne. Il profilo culturale è medio-basso.
Violenza psicologica e fisica sono i maggiori bisogni emersi.
Per tutte l’impegno è la ricerca di un lavoro e la conquista di un’indipendenza economica.
La cooperativa “La Città della Luna”, intanto, ha attivato una seconda Casa Rifugio a Lacedonia, in provincia di Avellino denominata “Luna smeraldo”.
Il Piano di Zona S2, intanto, è impegnato sul fronte della violenza di genere con altri due progetti: “Io e tu”, per sostenere economicamente i figli delle vittime di femminicidio, e “Svolte” per superare la violenza con orientamento, lavoro, tirocini, esperienze formative.
Il Piano di Zona Ambito S2, infine, ha all’attivo due Centri antiviolenza con sede a Minori, gestito dal Centro Italiano femminile ed a Cava de’ Tirreni affidato all’Associazione “Frida – Contro la violenza di genere”, presieduta da Ilaria Sorrentino.
In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne dello scorso 25 novembre – in onore del lavoro svolto dalle associazioni e in memoria di Nunzia Maiorana, cittadina cavese uccisa dal marito – l’assessore alle politiche sociali Annetta Altobello ha disposto delle scarpe rosse in ceramica in aula consiliare

Separazione: il benessere dei figli minori come priorità da salvaguardare
Mettere al centro i bisogni dei minori nel momento in cui, a causa della separazione dei genitori, viene meno l’ambiente familiare in cui sono cresciuti. È intorno a questa esigenza che si svilupperà il convegno in programma per venerdì prossimo a Palazzo di Città – inizio dei lavori alle ore 16 presso il Salone dei Marmi – dedicato al tema “Dalla frattura coniugale alla continuità genitoriale: affido e tutela dei minori”, un’occasione di riflessione anche sui nuovi strumenti offerti dal legislatore per la tutela dell’interesse dei minori, ad iniziare dalla formula dell’affido paritetico.
L’obiettivo è quello di individuare formule e strumenti per garantire ai figli, in particolare se bambini, di superare nel miglior modo possibile l’evento, naturalmente traumatico, della separazione dei genitori e della conseguente dissoluzione dell’ambiente familiare in cui sono nati e cresciuti.
Di fatto il crollo di un sistema di riferimenti e certezze che ha caratterizzato la vita dei minori, anche nell’eventualità di una separazione non conflittuale.
“Per i più piccoli – sottolinea lo psicologo e psicoterapeuta Paolo Landi, tra gli ospiti del convegno di venerdì prossimo – la separazione è equiparabile di fatto ad un lutto, viene vissuta come una rottura che spaventa perché proietta verso una realtà sconosciuta.
Non è eccessivo paragonare questa rottura al crollo dei pilastri su cui si è basata finora la crescita e l’identità stessa dei minori.
Questo in generale, tanto più poi se i coniugi che si stanno separando non riescono ad elaborare la rabbia e la delusione che accompagnano questo processo: allora i bisogni dei bambini non vengono percepiti né letti, anzi solitamente inizia una battaglia che ha nei figli uno degli oggetti del contendere”.
Quali sono le conseguenze negative che possono derivare per i bambini da una cattiva gestione della separazione?
“Quando si è piccoli non sempre si ha la capacità di tirar fuori le emozioni, quindi sofferenza e turbamento si manifestano principalmente attraverso il comportamento. In età adolescenziale gli effetti di una separazione conflittuale si riscontrano principalmente sulla stabilità emotiva, per arrivare poi alla scelta del partner e della gestione della relazione da adulti.
Se è vero che in alcuni casi la separazione è l’unica soluzione – il conflitto costante in famiglia è certamente peggiore -, è pur vero che bisognerebbe imparare a separarsi.
Troppo spesso nella fine di una famiglia si prendono in considerazione solo gli aspetti materiali, economici in primis, sarebbe ora di preoccuparsi anche di come fare attenzione a non far male a tutti”.
Negli ultimi anni si è iniziato a far ricorso alla formula dell’affido paritetico nel tentativo di tutelare meglio gli interessi dei figli minori. Si può fare una prima valutazione di questo strumento?
“Questa formula prevede che i bambini abbiano a che fare con entrambi i genitori in maniera paritaria, ci sono sentenze che hanno assegnato la casa di famiglia ai figli con l’obbligo per madre e padre di alternarsi: un modo per garantire ai minori stabilità nei propri riferimenti quotidiani.
Evitare di trascorrere una vita facendo le valige, spostandosi tra due case diverse, bene questo è già un grande risultato per il benessere dei bambini, si potrebbe dire che la continuità rispetto al proprio vissuto, la stabilità, rappresentino il 50% almeno del benessere dei figli di una coppia che si separa”.
Cosa occorre perché questa formula funzioni?
“C’è bisogno di mettere a posto le proprie emozioni. Durante la separazione non sono solo le idee ad essere confuse, ma anche e soprattutto le emozioni che governano le nostre scelte.
Solitamente i coniugi, o i conviventi, sono accecati da rabbia e rancore pertanto il problema non si pone tanto sul piano razionale, quanto su quello emotivo.
Per questo è opportuno accompagnare la coppia in questo percorso, aiutarla ad affrontare lo sconvolgimento che l’evento separazione rappresenta per entrambi.
Rimettendo a posto le proprie emozioni si compiono scelte migliori. Fortunatamente oggi tanti dei tabù legati a percorsi psicologici o psicoterapeutici sono caduti, rendendo più agevole questo processo”.

Scuola e didattica a distanza - Rischi e opportunità
Serata speciale venerdì 27 per l’interclub organizzato in remoto su Piattaforma Zoom dai Rotary Club Cava de’ Tirreni e Rotary Club Nocera Apudmontem, con la partecipazione di altri 9 Club Rotary del Distretto 2100 Campania-Calabria.
Il tema dell’incontro: “Scuola e Didattica a distanza. Rischi ed opportunità” ha suscitato notevole interesse nei numerosissimi partecipanti. Hanno fatto gli onori di casa Pasquale Montuoro, Presidente del R.C. Cava de’ Tirreni e Nino Miranda Presidente del R.C. Nocera Apudmontem.
Gli interventi dei relatori sono stati moderati dalla giornalista del Corriere della Sera Valentina Santarpia che nella sua attività cura, oltre economia e politica, in modo speciale anche tutto ciò che riguarda il mondo della scuola. Chiari e puntuali i suoi interventi che hanno stimolato le competenze dei relatori.
Sulla specificità della didattica a distanza, mettendo a confronto i rischi e le opportunità, hanno espresso le loro considerazioni i due dirigenti scolastici Maria Giuseppa Vigorito, del Liceo Artistico Galizia di Nocera Inferiore, socia onoraria del R.C. Nocera Apudmontem e Gerardo Cipriano dell’Istituto Superiore Francesco De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi, socio del R.C. Hirpinia Goleto Sant’Angelo dei Lombardi. Con i loro interventi hanno focalizzato l’attenzione sulle esperienze che vivono nei propri istituti con le diverse realtà socio-ambientali che si confrontano all’interno degli stessi.
Alle senatrici Bianca Laura Granato e Luisa Angrisani il compito di fornire indicazioni specifiche sul ruolo delle Istituzioni in questa gravosa fase di ammodernamento emergenziale che ha toccato in modo particolare la scuola.
Paolo Landi psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, che vanta un’esperienza decennale nel campo dell’indagine clinica della psicologia del bambino, ha analizzato nello specifico i rischi e le opportunità che la didattica a distanza può provocare negli allievi e non solo.
Il Governatore del Distretto Rotary 2100, professor Massimo Franco, ha concluso i lavori evidenziando l’importanza del tema, trattato in modo preciso ed interessante dai relatori, ringraziandoli unitamente ai Club organizzatori ed a tutti gli altri club che hanno partecipato.

Scuola e didattica a distanza - Rischi e opportunità
Serata speciale venerdì 27 per l’interclub organizzato in remoto su Piattaforma Zoom dai Rotary Club Cava de’ Tirreni e Rotary Club Nocera Apudmontem, con la partecipazione di altri 9 Club Rotary del Distretto 2100 Campania-Calabria.
Il tema dell’incontro: “Scuola e Didattica a distanza. Rischi ed opportunità” ha suscitato notevole interesse nei numerosissimi partecipanti. Hanno fatto gli onori di casa Pasquale Montuoro, Presidente del R.C. Cava de’ Tirreni e Nino Miranda Presidente del R.C. Nocera Apudmontem.
Gli interventi dei relatori sono stati moderati dalla giornalista del Corriere della Sera Valentina Santarpia che nella sua attività cura, oltre economia e politica, in modo speciale anche tutto ciò che riguarda il mondo della scuola. Chiari e puntuali i suoi interventi che hanno stimolato le competenze dei relatori.
Sulla specificità della didattica a distanza, mettendo a confronto i rischi e le opportunità, hanno espresso le loro considerazioni i due dirigenti scolastici Maria Giuseppa Vigorito, del Liceo Artistico Galizia di Nocera Inferiore, socia onoraria del R.C. Nocera Apudmontem e Gerardo Cipriano dell’Istituto Superiore Francesco De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi, socio del R.C. Hirpinia Goleto Sant’Angelo dei Lombardi. Con i loro interventi hanno focalizzato l’attenzione sulle esperienze che vivono nei propri istituti con le diverse realtà socio-ambientali che si confrontano all’interno degli stessi.
Alle senatrici Bianca Laura Granato e Luisa Angrisani il compito di fornire indicazioni specifiche sul ruolo delle Istituzioni in questa gravosa fase di ammodernamento emergenziale che ha toccato in modo particolare la scuola.
Paolo Landi psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, che vanta un’esperienza decennale nel campo dell’indagine clinica della psicologia del bambino, ha analizzato nello specifico i rischi e le opportunità che la didattica a distanza può provocare negli allievi e non solo.
Il Governatore del Distretto Rotary 2100, professor Massimo Franco, ha concluso i lavori evidenziando l’importanza del tema, trattato in modo preciso ed interessante dai relatori, ringraziandoli unitamente ai Club organizzatori ed a tutti gli altri club che hanno partecipato.

Contrasto ad usura ed estorsione - seminario con la DIA di Salerno
Dopo le giornate formative svolte a settembre dello scorso anno con il Comando provinciale dei Carabinieri, S.O.S. Antiracket Antiusura prosegue e consolida il Patto per la Legalità con le Forze dell’Ordine impegnate ogni giorno sui territori, grazie al seminario di oggi con la D.I.A. di Salerno.
L’incontro rientra nelle attività di formazione che da anni l’Associazione promuove nelle scuole, nelle Università e con le Forze dell’Ordine. Ad introdurre i lavori il Capo Sezione D.I.A. Salerno Ten. Colonnello CC Enzo Ferrara, che ha fortemente voluto e condiviso l’iniziativa, seguito dall’intervento del Presidente di S.O.S. Antiracket Antiusura Tommaso Battaglini.
L’evento ha costituito l’occasione per approfondire, con la trasversalità garantita dalle diverse professionalità coinvolte, tematiche vecchie e nuove legate ai fenomeni di usura e estorsione. Tra i vari argomenti si è discusso del ruolo delle associazioni antiracket e antiusura nella prevenzione e nel contrasto ai reati, delle modalità di approccio alla vittima di reato nel corso delle investigazioni, richiamando casi e questioni dell’attualità giuridica.
Il seminario ha visto alternarsi i focus di Andrea R. Castaldo (Professore Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Salerno, Avvocato), Antonio Picarella (Avvocato Penalista – Responsabile Ufficio Legale S.O.S. Antiracket Antiusura APS), Fabio Coppola (Avvocato Penalista – Presidente di Scuola Giuridica Salernitana), Paolo Landi (Psicologo e Psicoterapeuta), Arturo Denza (Dottore commercialista, esperto contabile SOS Antiracket Antiusura), Giovanbattista Greco (Avvocato Civilista – Professore incaricato Università̀ degli Studi di Salerno).
«Le giornate di formazione con le Forze dell’Ordine rappresentano per la nostra Associazione un prezioso momento di confronto sui temi della lotta alla criminalità e al racket dell’usura e dell’estorsione. Queste iniziative ci rafforzano nella convinzione che sia necessario consolidare stabili interconnessioni tra attori istituzionali e delle società civile i quali, su piani diversi, dirigono le proprie azioni verso orizzonti comuni».

L'angolo dell'anima - conoscere l'identità
Il concetto di identità è fondamentale nella vita dell’uomo. Attraverso la domanda “chi sono” ci poniamo nella realtà attraverso il riconoscimento di sé e dell’Altro.Ognuno di noi è unico.
L’aspetto fisico e altre caratteristiche percepibili ci distinguono dagli altri.
Eppure per riconoscerci veramente abbiamo bisogno di qualcos’altro, di qualcosa che ci permetta di scoprire il senso del nostro essere e del nostro operare, qualcosa che ci permetta di identificarci e considerarci in tutta la propria irripetibilità, qualcosa che permetta di sviluppare un senso di soggettività personale.
La nozione di identità rinvia all’unicità di ogni persona, ai sentimenti di individualità, di intenzionalità, alla capacità di pensare a se stessi, ad avere coscienza e conoscenza di sé.
Tale costrutto è il risultato di diversi processi psicologici, intrapersonali ed interpersonali, che confluiscono in una struttura organizzatrice della conoscenza individuale relativa a se stessi.
Ciascuno ha un’identità per gli altri e una per sé. La prima è l’identità oggettiva, ossia la nostra riconoscibilità; essa si presenta secondo tre modalità: fisica (ad es. caratteristiche del viso e del corpo), sociale (ad es. età, stato civile, professione, livello culturale..) e psicologica (ovvero la personalità, lo stile costante del nostro comportamento).
La seconda è l’identità soggettiva ed è l’insieme delle caratteristiche così come le vediamo e le descriviamo in noi stessi. Attraverso l’identità soggettiva o personale i soggetti non solo hanno un’esperienza cognitiva ed emotiva di sé, ma sono in grado di elaborare ed integrare in modo coerente anche un sistema di regole e segni condivisi, attraverso cui si genera un’identità sociale.
Esiste inoltre un rapporto molto stretto fra l’identità e le particolarità individuali del carattere; cioè tra identità e personalità. Quest’ultima può essere definita come l’insieme delle caratteristiche biologiche, psicologiche e sociali che individuano una persona nel suo modo unico di essere e di porsi in relazione con gli altri, e si costruisce potenziando e sviluppando le proprie peculiarità, ma anche utilizzando gli stimoli, gli apporti provenienti dall’ambiente.
Alla costruzione dell’identità contribuiscono fattori diversi, in particolar modo quelli collegati alle relazioni interpersonali. Esiste certamente un patrimonio ereditario e congenito di attitudini e disposizioni, individualmente connotate, ma su di esso s’inseriscono le influenze dell’esperienza, della cultura, della società.
La società di oggi non presenta solo elementi di rischio per il processo di formazione dell’identità, ma presenta anche molti elementi estremamente positivi: la riduzione dei forti condizionamenti espressi da un costume fatto spesso solo da pregiudizi; una migliore conoscenza della vita e del suoi problemi; la possibilità, nella dialettica del dialogo culturale.
Insomma, nella società di oggi si intrecciano valenze positive e valenze negative e chi si affaccia alla vita deve costruire la sua identità tra molte inevitabili difficoltà.
Comprendere e definire il processo di costruzione dell’identità, e quindi del Sé dell’individuo, diviene allora fondamentale per capire come avviene e si sviluppa la nascita psicologica della persona, che, alla nascita si presenta privo di qualsiasi riconoscimento e riferimento personale.
E di conseguenza a percepirsi e definirsi come un individuo unico nella propria singolarità, differenziato dagli altri, e consapevole della propria “essenza”.
Questa comprensione è inoltre fondamentale per l’individuazione, e l’eventuale cura o trattamento di quelle forme patologiche in cui queste dinamiche non seguono un corso regolare, ma subiscono, per vari e diversi motivi, degli arresti o delle deviazioni dalla normalità.

Accudimento vs Attaccamento
La supervisione psicologica nei servizi residenziali per anziani: uno strumento per permettere all’operatore di sintonizzarsi con se stesso e di entrare in relazione con gli altri in modo autentico.
Abbiamo chiesto al dott. Paolo Landi, psicologo-psicoterapeuta e supervisore presso LifeforLife Palazzo Belvedere di raccontarci l’importanza della supervisione psicologica nelle strutture residenziali.
“Per un operatore dei servizi residenziali per anziani, “essere bravo” significa essenzialmente essere capace di sintonizzarsi con l’altro. Il personale delle residenze per anziani racchiude professionisti specializzati nella presa in carico di specifici bisogni intensi e capillari delle persone ospiti.
Risulta così fondamentale il concetto di supervisione rivolto agli operatori oltretutto impegnati in una formazione continua atta ad ampliare specifiche capacità nello svolgere compiti che includono, oltre a cure sul piano tecnico, competenze sul piano emotivo-relazionale.
Una supervisione che diventa, attraverso i colloqui individuali o di gruppo, una vera opportunità di crescita e di miglioramento per l’intera equipe e per gli ospiti, destinatari finali del benessere degli operatori. Fondamentale, in quest’ottica, la possibilità di potenziare l’intelligenza emotiva e la capacità empatica degli operatori per sviluppare competenze interpersonali che aiutino ad interagire in modo più funzionale con se stessi e con gli altri.
L’assunto è che ci possiamo “mettere nei panni dell’altro” solo e soltanto se siamo capaci di sintonizzarci prima con noi stessi.
Gli operatori di una struttura residenziale geriatrica sono spesso mossi da una profonda motivazione ad aiutare l’altro e di riflesso a dare un senso attraverso l’aiuto alla propria vita.
Essere quindi sensibili al benessere dell’operatore rappresenta un punto di forza di una struttura residenziale”.

Accudimento vs Attaccamento
DALLA FUNZIONE DI ACCUDIMENTO ALLO SVILUPPO DELL’ATTACCAMENTO
Il sistema di accudimento ci guida nel fornire protezione e supporto ad altri individui che si trovano in uno stato di bisogno.
Sebbene accudimento e attaccamento siano sistemi comportamentali separati, si influenzano reciprocamente nel modellare il comportamento delle persone.
Il sistema di accudimento si attiva quando si è in presenza di qualcuno che sperimenta sofferenza o necessita di cure e protezione Per questo motivo il sistema di accudimento è considerato complementare al sistema di attaccamento in quanto motiva le persone ad offrire aiuto, conforto e sostegno in risposta ai segnali generati dallo stato di bisogno di un’altra persona
Le emozioni derivanti dall’attivazione di questo sistema sono ansia, compassione, tenerezza protettiva o colpa per il mancato accudimento. Il sistema si disattiva alla cessazione delle condizioni attivanti, quindi alla percezione di segnali di sollievo e sicurezza da parte dell’altro.
E’ nella diade madre – bambino che prima di tutto si evince la relazione tra sistema di accudimento e sistema di attaccamento.
Madre e bambino hanno entrambi un ruolo attivo nell’instaurare una relazione: essi sono alla costante ricerca di interazione, in particolar modo nelle prime fasi di sviluppo. Tale interazione è molto importante in quanto influenza lo sviluppo emotivo, cognitivo e quella che sarà la personalità adulta del bambino.
Entrambe le parti della diade nella relazione madre-figlio svolgono ruoli attivi nell’ambito della loro relazione. Il bambino ha un ruolo attivo nell’instaurare una relazione grazie ad una dotazione genica, ovvero a schemi di comportamento innati, efficaci sin dalla nascita nel promuovere vicinanza e contatto con la madre. Data questa osservazione, l’attaccamento può essere considerato come una motivazione primaria del bambino, nonché un suo bisogno primario e non più una conseguenza del soddisfacimento di bisogni alimentari o fisici.
La predisposizione all’accudimento da parte degli adulti nei confronti dei bambini piccoli sarebbe legata a specifici meccanismi fisiologici innati e reciproci che si attivano in maniera automatica nella madre che risponde ai segnali del piccolo, ma anche nel bambino che richiama la sua attenzione e vicinanza.
Il bambino, seppur non abbia la capacità motoria di avvicinarsi alla madre o mantenersi presso di essa, viene al mondo dotato di numerosi strumenti che, fin dalla nascita, hanno la funzione di mostrare certi segnali differenziati che inducono in modo peculiare particolari tipi di risposta da parte di chi li cura; i più evidenti sono il pianto e il sorriso. Queste due forme di comportamento, che hanno l’effetto di far avvicinare la madre al bambino, vengono raggruppate da Bowlby, nella classe dei “comportamenti di segnalazione” in cui possiamo trovare anche altri comportamenti quali il richiamo e tutti i gesti classificabili come segnali sociali. Un episodio di pianto ad esempio, è uno stimolo in grado di attivare il Sistema Nervoso Centrale sia del bambino che lo produce sia dell’ascoltatore, creando uno stato di attenzione reciproca. Inoltre, riesce a modificare e attivare lo stato funzionale dei genitori, promuovendo prossimità e contatto con essi e in particolar modo con la madre, attivando il suo comportamento di accudimento e motivandola a rispondere prontamente e in maniera adeguata nutrendo il piccolo, proteggendolo o confortandolo.
La capacità materna di mettere in atto comportamenti di accudimento in risposta ai segnali del bambino promuove lo sviluppo della comunicazione: i bambini che piangono meno all’età di un anno, appunto grazie alla sensibilità delle loro madri, hanno maggiore probabilità di sviluppare altre strategie comunicative, quali ad esempio le espressioni facciali gesti corporei e vocalizzazioni rispetto a quelli che piangono di più. Inoltre la reattività di un caregiver, svolge un ruolo importante nello sviluppo della personalità, temperamento e capacità cognitive e linguistiche del bambino.
Un recente studio ha evidenziato che nei padri che vedono i loro bambini in difficoltà, i livelli di testosterone si abbassano facendo risultare gli uomini, di fatto, maggiormente sensibili e pazienti: ne consegue uno stile genitoriale associato ad un miglior sviluppo sociale, emotivo e cognitivo del bambino. Infatti, ridotti livelli di testosterone faciliterebbero l’ accudimento dei figli da parte del padre. Evolutivamente parlando, questo meccanismo sarebbe utile ad incrementare la risposta di accudimento del padre. Livelli di testosterone elevati, infatti, correlano con una maggiore propensione a mettere in atto comportamenti aggressivi, potenzialmente dannosi per l’incolumità fisica ma anche psicologica del bambino.
Sebbene l’ accudimento e l’attaccamento siano sistemi comportamentali separati, e ogni sistema influisce sul comportamento in modo univoco, i due sistemi interagiscono nel modellare il comportamento delle persone.
L’interazione tra i due sistemi è ancora più complicata in quanto un caregiving (principalmente durante l’infanzia) può influenzare lo sviluppo dello stile di attaccamento.
Pertanto, la cura sensibile e di supporto da parte di un educatore primario è probabile che si traduca in un attaccamento sicuro, che può facilitare la capacità di un individuo di mettere in atto un accudimento sensibilie e supportivo. Viceversa, scarsi sensibilità e supporto possono portare a uno stile di attaccamento insicuro, che è noto per essere associato a scarsa capacità di accudimento nell’età adulta.
Nello specifico, l’attaccamento sicuro facilita uno stile di caregiving caratterizzato da elevata prossimità, sensibilità e reattività; uno stile di caregiving evitante invece predispone a un accudimento più controllato e distante caratterizzato da scarsa prossimità e sensibilità; e infine uno stile di caregiving ansioso è collegato a uno stile di accudimento compulsivo, invadente e incoerente, scarsamente sensibile al reale bisogno dell’altro.
Ciò suggerisce un legame evolutivo tra attaccamento e caregiving. Infatti, secondo Bowlby, nell’uomo esiste una tendenza innata a ricercare la vicinanza con la figura d’attaccamento in situazioni di pericolo, stress e solitudine. Il comportamento d’attaccamento si attua come ricerca attiva della figura di riferimento che accudisce e protegge. Nel tempo le modalità con le quali si entra in relazione con le figure d’attaccamento, inizialmente la madre, si stabilizzano e tendono a generalizzarsi, formando schemi cognitivi interpersonali, che Bowlby chiama Modelli Operativi Interni (MOI). Queste rappresentazioni apprese di sé, della relazione con l’altro e delle figure d’attaccamento, s’innestano sulle componenti innate del sistema e costituiscono una caratteristica individuale che modella le relazioni interpersonali, portando alla strutturazione di uno specifico stile di attaccamento: sicuro, insicuro evitante, ansioso-ambivalente, disorganizzato.

Alcool e Adolescenti
L’adolescenza è un periodo di grandi sconvolgimenti ormonali, fisici ed emotivi, che caratterizza il passaggio dall’essere bambini al mondo degli adulti, e, proprio in questo periodo della vita, per ragazzi e ragazze è fondamentale essere parte di un gruppo e dunque sostenere la maggior parte delle scelte e delle tendenze che “il gruppo” impone. E, tra le mode, o meglio cattive abitudini, diffuse tra i nostri adolescenti vi è l’eccessivo consumo di alcol, il cui potenziale pericolo viene valutato solo, e purtroppo con rammarico, nel corso di qualche evento drammatico o nel corso degli anni quando ci si rende conto dei danni che questa sostanza ha creato al proprio corpo.
I giovani sono particolarmente a rischio per le conseguenze dannose del consumo eccessivo di alcol perché questo interferisce con la loro crescita, lo stato nutrizionale e lo sviluppo della personalità. Questo non è unicamente dovuto all’immaturità fisica, ma anche a fattori psicologici.
L’alcol colpisce lo sviluppo del cervello nei giovani, quindi il consumo, in particolare il consumo eccessivo, prima che il cervello abbia completato il suo sviluppo, può avere delle conseguenze disastrose sulle funzioni cerebrali.
La messa in atto di comportamenti a rischio in questa fase della crescita rappresenta principalmente un tentativo di andare contro le regole e staccarsi da quei modelli imposti dagli adulti, per ricercare una propria autonomia e identità. Nell’adolescenza, i giovani, acquisendo la capacità del ragionamento ipotetico-deduttivo, diventano in grado di comprendere la relatività dei giudizi, dei punti di vista, di ragionare su semplici ipotesi. Nasce la capacità di critica rivolta verso gli adulti, ma anche nei confronti di se stessi.
A questo sviluppo dei processi cognitivi, che permettono ai ragazzi una notevole capacità di riflessione, si accompagna però una grande instabilità affettiva e una tendenza provocatoria nei confronti degli adulti di riferimento. I compiti evolutivi degli adolescenti possono determinare la predisposizione dei soggetti all’attuazione di comportamenti a rischio.
Questi atteggiamenti a rischio assumono un significato e possono essere compresi in quanto in un certo modo funzionali al raggiungimento degli obiettivi di crescita specifici in quel ciclo di vita, quali acquisizione di autonomia, individuazione e sviluppo. Talvolta il comportamento a rischio può costituire un rito di passaggio che permette di assumere lo status di adulto oppure una strategia per fronteggiare lo stress (coping). Di conseguenza, per il ragazzo, l’azione “rischiosa”, è da un certo punto di vista quasi necessaria per verificare quali sono i suoi limiti e poter quindi meglio definire le proprie potenzialità e le risorse da incrementare. D’altra parte l’adolescente sente il bisogno di modellare e presentare al gruppo dei pari, assunti ora come punto di riferimento al posto dei genitori una immagine di sé diversa da quella che si era costruito all’interno del gruppo familiare.
Più specificatamente tali obiettivi si concretizzano nel bisogno di sperimentare nuove sensazioni e ricerca di autoaffermazione ed autonomia, sfida agli adulti e trasgressione alle regole. Bere, fumare, drogarsi è segno, per tanti di loro, di omologazione sociale e anche social, visto che spesso queste attività vengono condivise nei profili social per testimoniare ciò che è stato fatto, alla ricerca di approvazione e riconoscimento.
Per tale ragione, è fondamentale la presenza dei genitori o comunque degli adulti di riferimento, in grado di accompagnarli in questa fase delicata di crescita.
Questo perché rivestono un ruolo fondamentale in termini preventivi e contenitivi.
Prima di tutto è importante che costituiscano un modello positivo per i loro figli. Per questi ultimi, infatti, l’apprendimento indiretto, attraverso i gesti e i comportamenti, vale più di tante parole ed è il più efficace in termini di messaggio educazionale.
E’ quindi importante da parte dei genitori avviare e mantenere costante un buon canale di comunicazione e dialogo. Nel caso specifico è fondamentale riportare ai figli esempi concreti, ossia situazioni realmente accadute che si sono verificate dannose. Tutto questo però sempre nel rispetto e nell’ascolto dei bisogni dei figli in relazione alla loro età.
E’ importante che il genitore mantenga il proprio ruolo educativo delineando delle regole. I ragazzi hanno bisogno di limiti, anche se poi tendono a metterli in discussione e, se si riesce ad instaurare una relazione basata sul dialogo e l’ascolto, e non solo sui divieti, sarà più facile porre delle regole chiare, che siano condivise con i figli.
In questo modo i ragazzi sono più portati ad accettare e a seguire le raccomandazioni genitoriali, ed hanno bisogno di sentire che possono contare su di loro, che saranno pronti ad accoglierli, in caso di aiuto o se vorranno aprirsi con loro.
È fondamentale dunque da parte degli adulti trasmettere la propria costante presenza e disponibilità, verso qualsiasi esperienza i giovani possano compiere in questo stadio del loro sviluppo di vita.

Alcool e minori
L’adolescenza è un periodo di grandi sconvolgimenti ormonali, fisici ed emotivi, che caratterizza il passaggio dall’essere bambini al mondo degli adulti, e, proprio in questo periodo della vita, per ragazzi e ragazze è fondamentale essere parte di un gruppo e dunque sostenere la maggior parte delle scelte e delle tendenze che “il gruppo” impone. E, tra le mode, o meglio cattive abitudini, diffuse tra i nostri adolescenti vi è l’eccessivo consumo di alcol, il cui potenziale pericolo viene valutato solo, e purtroppo con rammarico, nel corso di qualche evento drammatico o nel corso degli anni quando ci si rende conto dei danni che questa sostanza ha creato al proprio corpo.
I giovani sono particolarmente a rischio per le conseguenze dannose del consumo eccessivo di alcol perché, questo interferisce con la loro crescita, lo stato nutrizionale e lo sviluppo della personalità. Questo non è unicamente dovuto all’immaturità fisica, ma anche a fattori psicologici.
L’alcol colpisce lo sviluppo del cervello nei giovani, quindi il consumo, in particolare il consumo eccessivo, prima che il cervello abbia completato il suo sviluppo, può avere delle conseguenze disastrose sulle funzioni cerebrali.
La messa in atto di comportamenti a rischio in questa fase della crescita rappresenta anche un tentativo di andare contro le regole, staccarsi da quei modelli imposti dagli adulti, per ricercare una propria autonomia e identità. Bere, fumare, drogarsi è segno, per tanti di loro, di omologazione sociale e anche social, visto che spesso queste attività vengono condivise nei profili social per testimoniare ciò che è stato fatto, alla ricerca di approvazione e riconoscimento.
Per tale ragione, è fondamentale la presenza dei genitori o comunque degli adulti di riferimento, in grado di aiutarli a sviluppare una capacità critica e di accompagnarli in questa fase delicata di crescita, proprio perché. quando subentra il sentirsi parte di un gruppo, la condivisione tra amici, è ancora più facile mettere in atto condotte pericolose senza conoscerne a fondo le conseguenze, ma unicamente perché lo fanno gli altri. Il vero problema, infatti, quando si parla di alcol o anche di droghe è l’essere condizionabili, il non poter apparire “diversi” dagli altri, per paura magari di non essere accettati o esclusi dai coetanei.
Molti genitori non sono pronti a questo, non sanno come comportarsi, molte volte pensano che certi comportamenti non possano riguardare il figlio, altre volte fanno finta di niente, minimizzano, pensando che si tratti di una fase dell’adolescenza che andrà a scomparire col tempo. Invece, proprio i genitori rivestono un ruolo fondamentale in termini preventivi e contenitivi.
Prima di tutto è importante che costituiscano un modello positivo per i loro figli. Per questi ultimi, infatti, l’apprendimento indiretto, attraverso i gesti e i comportamenti, vale più di tante parole ed è il più efficace in termini di messaggio educazionale.
E’ poi importante da parte dei genitori avviare e mantenere costante un buon canale di comunicazione e dialogo. Nel caso specifico è fondamentale riportare ai figli esempi concreti, ossia situazioni realmente accadute che si sono verificate dannose. Tutto questo però sempre nel rispetto e nell’ascolto dei bisogni dei figli in relazione alla loro età.
E’ importante che il genitore mantenga il proprio ruolo educativo delineando delle regole. I ragazzi hanno bisogno di limiti, anche se poi tendono a metterli in discussione e, se si riesce ad instaurare una relazione basata sul dialogo e l’ascolto, e non solo sui divieti, sarà più facile porre delle regole chiare, che siano condivise con i figli.
In questo modo i ragazzi sono più portati ad accettare e a seguire le raccomandazioni genitoriali, ed hanno bisogno di sentire che possono contare su di loro, che saranno pronti ad accoglierli, in caso di aiuto o se vorranno aprirsi con loro.
È fondamentale da parte degli adulti trasmettere la propria costante presenza e disponibilità, verso qualsiasi esperienza i giovani possano compiere in questo stadio del loro sviluppo di vita.

Articolo 18 agosto 2021
LA STRAORDINARIA ESPERIENZA DELLA BELLEZZA
La bellezza è un’esperienza assolutamente soggettiva che esprime una relazione tra un oggetto e un soggetto dotato di sensi e capacità di intelletto. Se la realtà oggettiva esiste anche senza un testimone umano, non altrettanto si può affermare della bellezza: senza una mente che la coglie non c’è bellezza.
Ci appare bello ciò che ci sembra in grado di poter soddisfare un nostro bisogno o scopo. In questo modo si spiega la diversità individuale, storica e culturale del giudizio di “bello”.
Se alcune cose appaiono belle quasi a tutti e ci fanno pensare all’esistenza di una bellezza oggettiva è semplicemente perché apparteniamo tutti alla specie umana e condividiamo un’ampia parte dei nostri scopi, primi fra tutti quelli inerenti la sopravvivenza.
Seguendo questa prospettiva di equilibrio tra universalità ed individualità si potrebbero elencare una serie di bisogni comuni degli esseri umani, fisici e psicologici, che si personalizzano in ogni individuo e per ciascuno di essi immaginare un certo tipo di bellezza, consistente nell’aspettativa che la relazione con quell’oggetto possa portare alla soddisfazione di quel bisogno.
Già secondo Freud, la bellezza ha il compito di tenere l’apparato psichico in uno stato di costante contenuta eccitazione. Prima che effettivamente lo faccia: la bellezza è l’anticipazione, la promessa, l’aspettativa di un soddisfacimento.
La bellezza, ci fa intuire la possibilità dell’appagamento di un desiderio o di un bisogno profondo senza che questo avvenga veramente.
Percepire una bellezza equivale ad avvertire una mancanza e la possibilità di colmarla.
I canoni di bellezza vantano una duplice origine biologico/ereditaria e culturale. Questi ultimi sono certamente più universali e prioritari sopratutto per quanto riguarda la bellezza fisica e la connessa appetibilità sessuale a scopo riproduttivo.
Pur privilegiando in queste riflessioni un approccio soggettivistico e relazionale al tema del bello è doveroso darne una definizione quanto più possibile oggettiva.
E riferiamoci alla varietà del bello, opposta all’uguaglianza e alla monotonia e ciò forse in relazione al fatto che tutti i nostri organi di senso apprezzano sopratutto le differenze, i cambiamenti, le discontinuità.
O la regolarità, che mitiga la varietà stessa e trasmette il rassicurante senso di prevedibilità e familiarità, tanto caro soprattutto ai bambini. E la semplicità, che consente di afferrare tutto l’oggetto con un solo atto percettivo.
Fino alla grandezza, come quantità e abbondanza, che talvolta si immerge, in particolare per quanto riguarda la bellezza femminile nella tensione armonica tra gli opposti.
E proprio come come già sosteneva Eraclito: “se esistono nell’universo degli opposti, delle realtà che paiono non conciliarsi, come l’unità e la molteplicità, l’amore e l’odio, la pace e la guerra, la calma e il movimento, l’armonia tra questi opposti non si realizzerà annullando uno di essi, ma proprio lasciando vivere entrambi in una tensione continua. L’armonia non è assenza bensì equilibrio di contrasti”.
A noi come individui e come specie in fondo il senso della bellezza, consistendo in una valutazione spontanea immediata e complessiva della positività di qualcosa è la strada maestra verso la vita.
Ai giovani potremmo dire “seguite la bellezza” e vivrete a lungo felici…

Articolo bias cognitivi
GLI ERRORI COGNITIVI: I BIAS
Bias è un termine inglese, e significa obliquo, inclinato. Inizialmente, tale termine era usato nel gioco delle bocce, soprattutto per indicare i tiri storti, che portavano a conseguenze negative. Nella seconda metà del 1500, il termine bias, assume un significato più vasto, infatti sarà tradotto come inclinazione, predisposizione, pregiudizio
I bias cognitivi, in psicologia, sono errori sistematici di valutazione, con creazione di un giudizio che non corrisponde alla realtà; utilizzati spesso per prendere decisioni in fretta e senza fatica.
Gli errori sistematici possono essere visti come delle scorciatoie poco efficaci che il nostro cervello utilizza per risparmiare risorse. Si possono trattare i bias cognitivi come una forma di adattamento del nostro cervello; essi, infatti, hanno effetti sul ragionamento e sul comportamento.
Quando si deve emettere un giudizio, spesso interviene una sorta di risparmio cognitivo che gli psicologi chiamano euristiche.
Le euristiche sono, al contrario dei bias, procedimenti mentali intuitivi e sbrigativi, scorciatoie mentali, che permettono di costruire un’idea generica su un argomento senza effettuare troppi sforzi cognitivi. Sono strategie veloci utilizzate di frequente per giungere rapidamente a delle conclusioni.
Le euristiche sono, dunque, escamotage mentali che portano a conclusioni veloci con il minimo sforzo cognitivo.
Quindi, i bias sono particolari euristiche usate per esprimere dei giudizi, che alla lunga diventano pregiudizi: le euristiche si possono definire come delle strade rapide che seguiamo per affrontare determinati problemi. Quando un’euristica compie un’imprecisione, un errore, ci troviamo di fronte a un bias cognitivo.
In sintesi, se le euristiche sono scorciatoie comode e rapide estrapolate dalla realtà che portano a veloci conclusioni, i bias cognitivi sono euristiche inefficaci, pregiudizi astratti che non si generano su dati di realtà, ma si acquisiscono a priori senza critica o giudizio.
Il ragionamento umano fa ampio impiego di euristiche, scorciatoie di pensiero e modalità rapide e intuitive che esulano dal ragionamento logico. Ciò che rende questi stili di pensiero disfunzionali non è la loro presenza, ma la loro rigidità e inflessibilità, specialmente se ci conduce ad interpretare gli eventi, e noi stessi, in modo irrealisticamente negativo.
Gli errori di ragionamento, quando avvengono in modo sistematico, possono causare problemi, perchè sono alla base di pensieri e credenze disfunzionali, poco realistiche che determinano sofferenza emotiva.
I bias, inseriti nella comunicazione alla quale siamo soggetti ogni giorno, influenzano il nostro pensiero e le nostre decisioni.
Ad esempio, in un periodo come quello attuale, non facile per la sanità, l’economia e la politica mondiale a causa del Coronavirus è bene essere consapevoli delle decine di bias cognitivi ai quali siamo soggetti e agli effetti che hanno sul nostro processo decisionale, per cui, avere un’attenzione al modo in cui si presentano le informazioni può avere un grandissimo effetto sui comportamenti delle persone, come dimostrano i risultati.
I Bias cognitivi sono il rovescio della medaglia delle euristiche, nel senso che hanno lo scopo di rendere l’essere umano “cieco” rispetto a certe informazioni per favorire rapidità e frugalità decisionali.
Negli ultimi decenni la psicologia cognitiva ha chiarito che è impossibile adottare un pensiero esclusivamente razionale perchè la mente umana ha incorporato, durante l’evoluzione, una serie di comportamenti intuitivi che hanno consentito all’uomo, fin dal principio della sua evoluzione, di sopravvivere in ambienti ostili prendendo decisioni euristiche.
Le euristiche sono dunque processi di pensiero automatici, sorti durante l’evoluzione, che aiutano il rapido raggiungimento di una soluzione nel momento in cui occorre prendere una decisione in uno specifico contesto.
Però, oggi, l’essere umano è immerso in un ambiente molto meno ostile dal punto di vista fisico, ma più ostile dal punto di vista psichico (il sovraccarico informativo e la manipolazione mediatica sono ormai alla base della vita quotidiana).
Diventa dunque importante conoscere il funzionamento di entrambi i sistemi mentali (razionale e intuitivo) che governano la nostra mente.
Tra i bias cognitivi più comuni possiamo identificarne alcuni:
Bias di conferma
A ciascuno di noi piace essere d’accordo con le persone che sono d’accordo con noi e ciascuno di noi tende ad evitare individui o gruppi che ci fanno sentire a disagio. Si tratta di una modalità di comportamento preferenziale che porta al bias di conferma, ovvero l’atto di riferimento alle sole prospettive che alimentano i nostri punti di vista preesistenti.
Bias di gruppo
Molto simile al bias di conferma è il bias di gruppo, che ci induce a sopravvalutare le capacità ed il valore del nostro gruppo, a considerare i successi del nostro gruppo come risultato delle qualità dello stesso, mentre si tende ad attribuire i successi di un gruppo estraneo a fattori esterni non insiti nelle qualità delle persone che lo compongono.
Bias di Ancoraggio
Con questo bias, nel prendere una decisione tendiamo a confrontare solo un insieme limitato di elementi: l’errore è quello di ancorarsi, cioè fissarsi su un valore che viene poi usato, arbitrariamente, in modo comparativo, cioè come termine di paragone per le valutazioni in atto, invece che basarsi sul valore assoluto.
Fallacia di Gabler
Un altro bias cognitivo frequente è la cosiddetta fallacia di Gabler, ovvero la tendenza a dare rilevanza a ciò che è accaduto in passato, così che i giudizi attuali siano del tutto influenzati da tali eventi passati. In virtù di questo bias cognitivo chi ha ricevuto un giudizio positivo nel passato tenderà a ricevere un giudizio positivo anche nel presente, anche a dispetto delle reali prestazioni attuali, che potrebbero essere negative o in calo rispetto a quelle passate.
Nell’errore per somiglianza, apprezziamo nell’altro aspetti simili a quelli che riconosciamo in noi stessi; mentre nell’errore per contrasto, al contrario, apprezziamo i tratti di personalità diametralmente opposti ai nostri: il risultato può portare a sovrastimare negli altri quei tratti che riconosciamo opposti ai nostri. Per esempio se siamo timidi o introversi saremo indotti da questo bias cognitivo a giudicare gli altri più sicuri ed estroversi di quanto siano in realtà.
Bias di proiezione
Simile è il bias di proiezione, per il quale pensiamo che la maggior parte delle persone la pensi come noi. Questo errore cognitivo si correla al bias del falso consenso per il quale riteniamo che le persone non solo la pensino come noi, ma anche che siano d’accordo con noi.
Bias della negatività
Comporta un’eccessiva attenzione rivolta verso elementi negativi, che vengono anche considerati come i più importanti. A causa di questa distorsione cognitiva, si tende a dare maggior peso agli errori, sottovalutando i successi e le competenze acquisite ed attribuendo così una valutazione negativa alla prestazione.
Bias dello status quo
E’ una distorsione valutativa dovuta alla resistenza al cambiamento: il cambiamento spaventa e si tenta di mantenere le cose così come stanno. La parte più dannosa di questo pregiudizio è l’ingiustificata supposizione che una scelta diversa potrà far peggiorare le cose.
Bias del pavone
In relazione a questo bais, siamo indotti a condividere maggiormente i nostri successi, rispetto ai nostri fallimenti. L’uso che la maggior parte delle persone fa dei social è una fotografia esaustiva di questo tipo di bias. Sui social, infatti, le persone tendono a mostrare per lo più un’ immagine positiva di sé, tanto da far sembrare la vita di tutti ideale.
Illusione della frequenza
In questo caso, il cervello tende a selezionare informazioni che ci riguardano – per esempio a farci notare donne con i capelli corti se per esempio ci siamo appena tagliate i capelli corti o auto rosse se abbiamo appena acquistato una macchina rossa – il nostro errore di valutazione è quello di credere che ci sia realmente un incremento nella frequenza di donne con i capelli corti o di macchine rosse, cioè tendiamo a sovrastimare la frequenza di informazioni che ci riguardano.
Bias dell’ottimismo
Questo baias ci porta a ritenere l’essere umano più ottimista che realista, nonostante ci piaccia pensare di essere creature razionali capaci di fare giuste previsioni sulla base di valutazioni obiettive.
Questa tendenza a percepire il futuro roseo, anche paragonandolo al passato e al presente, è nota come bias dell’ottimismo e ci riguarda tutti, indipendente dall’età, dal sesso, dalla condizione economica e sociale.
Questo atteggiamento mentale sopravvive generalmente anche in tempi di crisi, di momenti difficili, perché la nostra mente se la cava immaginando un difficile futuro per la collettività ma non per se stessi.

Articolo narcisismo
DAL NARCISISMO AL NARCISISMO ESTREMO: LA TRIADE OSCURA
Le persone con una personalità narcisistica sono caratterizzate da senso di superiorità, esigenza di ammirazione e mancanza di empatia. Esprimono una credenza esagerata nel loro proprio valore o importanza, comunemente denominata “grandiosità”. Possono essere estremamente sensibili ai fallimenti, alla sconfitta o alla critica.
Se incontrano un fallimento, a causa della loro elevata opinione di se stessi, possono facilmente manifestare estrema rabbia o depressione. Dal momento che si vedono superiori agli altri spesso pensano di essere ammirati o invidiati. Credono di essere autorizzati a soddisfare i propri bisogni senza attendere, per cui possono sfruttare gli altri, i cui bisogni e opinioni vengono ritenuti di scarso valore.
Questi “manipolatori emotivi” per assicurarsi il loro nutrimento narcisistico si servono di un gran numero di strategie che hanno appreso spontaneamente nell’arco della loro esistenza.
Nella gran parte dei casi il manipolatore emotivo mette in atto queste strategie perché sono gli unici modelli relazionali che conosce. Inoltre, a mano a mano che interagisce con l’altro, consolida il proprio potere, tendendo ad abbassare l’autostima di quest’ultimo. Nella vittima subentra una sorta di assuefazione, legata a dissonanze cognitive e implicazioni psicologiche, che portano alla svalutazione del sé. Fino ad indebolire o perdere del tutto il suo senso di identità.
Coloro che non hanno la capacità di connettersi con gli altri o hanno la capacità di disconnettere deliberatamente le proprie emozioni, sono spesso parte della Triade Oscura di Personalità.
Un insieme di caratteristiche della personalità, o ancor meglio dimensioni di essa, quali narcisismo, machiavellismo e psicopatia, vanno a configurare questa Triade.
Essa mostra costrutti che in parte si sovrappongono ma che restano comunque differenziati.
Tutti e tre i tratti della triade condividono caratteristiche come:
- mancanza di empatia
- ostilità interpersonale
- aggressività interpersonale
Le tre componenti che formano la personalità oscura hanno caratteristiche in parte sovrapponibili, ma di per sé distinte che si miscelano a formare una personalità unica e differente dalle tre che la generano.
Per narcisismo, qui, in una nuova e breve sintesi, si intende una tendenza alla grandiosità, alla ricerca continua di ammirazione e approvazione, senso di superiorità e sensazione di essere speciali con una fatica ad accettare le critiche, che porta a ricercare situazioni e persone che donano lusinga e riconoscimento.
Il machiavellismo indica invece abilità manipolatorie, elevata razionalità e pianificazione al minimo dettaglio delle mosse, al punto da giustificare anche i mezzi meno adeguati, scarsa moralità e sfruttamento di altri e delle situazioni per il proprio tornaconto.
Infine la psicopatia è caratterizzata da assenza di empatia scarsa presenza di rimorso, senso di colpa e ansia rispetto alle conseguenze del proprio agire talvolta aggressivo e sleale, disinteresse verso molte aree del proprio agire e difficoltà nell’esprimere sentimenti ed emozioni risultando insensibile.
I tre aspetti caratteristici della personalità oscura portano ad assumere caratteristiche significative a livello di personalità e comportamento.
Nello specifico, la persona con triade oscura è tendenzialmente manipolatoria al punto da strumentalizzare l’altro per un proprio tornaconto, con atteggiamento distaccato e freddo rispetto alle conseguenze generate e un pensiero costante di grandiosità e diritto, che animano il suo agire.
Nella sfera emotiva, ricerca sensazioni forti in diversi ambiti, fino a compiere atti estremi e pericolosi per sé o altri, senza preoccupazione, senso di colpa o senso morale. Ha una cura eccessiva di sé e del proprio aspetto fisico, con attenzione ai dettagli e noncuranza delle critiche esterne che vengono percepite come manifestazione di incapacità e ignoranza altrui, con conseguente chiusura delle relazioni animate da queste circostanze.
In ambito lavorativo capita spesso di osservare leader abili razionali ma estremamente insensibili. Questi soggetti infatti hanno ottime doti di leadership, sono carismatici, abili pianificatori e organizzatori, sono bravissimi ad influenzare il comportamento altrui generando un clima misto tra terrore ed ammirazione. Il loro agire è spesso caratterizzato da manipolazione e strumentalizzazione con lo scopo di raggiungere obiettivi sempre più elevati che sono ciò che spesso garantisce loro successo e posizioni di prestigio.
Nella vita privata e nelle relazioni con l’altro sesso tendono a mettere in gioco il proprio carisma e le proprie tendenze manipolatorie raggiungendo livelli alti di accoppiamento nel breve periodo, con rapporti sessuali casuali, relazioni extraconiugali e fugaci senza un reale interesse verso il partner.
Sono spesso attraenti specialmente per persone con personalità fragile, vittime di delusioni in vari ambiti della vita che sanno far sentire bene e desiderate per poi lascarle dopo il raggiungimento del proprio scopo di piacere.

Paolo Landi 1
IL DISAGIO DI RIPRENDERE LA VITA NELLA FASE 2 , I CASI DI FOBIA SOCIALE DA TERRORE DA CONTAMINAZIONE
La seconda fase dell’emergenza Coronavirus, Fase 2, iniziata lo scorso 4 maggio, segnerà il graduale ritorno ad una condizione di normalità nella vita di molti cittadini.
Questo nuovo momento si sta presentando per ognuno come una conquista di libertà verso cui andare, un traguardo auspicato, ma anche temuto.
Il periodo di quarantena, con quella sensazione di sospensione dal tempo e la modifica dei ritmi quotidiani, ci ha permesso di recuperare degli aspetti trascurati di sé e della relazione con le persone care. (E’ stato possibile riscoprire il piacere, tante volte negato dalla fretta, dalla stanchezza degli impegni di ogni giorno, di giocare con i propri figli; oppure quello di trovare il tempo di leggere finalmente quel libro chiuso e riposto sul comodino tante volte, dopo giornate di intensi impegni; o recuperare passioni abbandonate; o ancora poter dedicare del tempo alla famiglia; e, non in ultimo, la possibilità di ritagliarsi spazi personali di contatto più intimo con se stessi.)
Allo stesso modo però, la permanenza in questa condizione, ha acuito un senso di auto-protezione dai fattori esterni, particolarmente rappresentati dalla pericolosità del virus.
Con l’ingresso in questa nuova fase, invece, siamo entrati in una condizione di attesa, verso la ripresa di una nuova quotidianità.
In questa situazione di incertezza, di continuo cambiamento e di attesa del ristabilirsi della normalità, siamo stati chiamati ad adattarci ad un nuovo ritmo di vita e a norme di comportamento atte alla prevenzione.
Riprendere però una vita solo parzialmente normale mentre ancora c’è un virus in giro, certamente non aiuta a pensare positivamente.
Tutto questo sta generando naturalmente dei risvolti dal punto di vista psicologico, con preoccupazione, ansia, angoscia, tristezza. In particolare, con la ripresa delle relazioni, si è andata a sperimentare intensamente la fobia di essere contagiati.
Mentre la quarantena, con l’evitamento e la protezione, dal fatto di dover rimanere in casa, ha ridotto almeno temporaneamente il timore della contaminazione, la graduale ripresa della normalità sta accentuando la paura del contagio.
E’ probabile quindi che il timore del contatto e di un possibile contagio, si venga a stabilizzare dentro di noi, con conseguenze comportamentali ed emotive.
Le strategie di evitamento conseguenti possono essere pervasive, causando difficoltà relazionali e sociali profonde e disfunzionali.
Il sentirsi eccessivamente preoccupati della possibilità di contrarre il virus può essere considerato però come un tratto caratteristico attualmente, ma transitorio.
Elemento importante in questa fase sarà dunque quello di attribuire centralità ai fattori di protezione personale e altrui attraverso il rispetto delle norme sanitarie; continuare a mantenere costanti le relazioni significative e sociali sempre nel rispetto delle indicazioni fornite gradualmente; nutrirsi di informazioni attendibili sulla pandemia senza lasciarsi sopraffare da una sovraesposizione inadeguata.
Ricordiamoci che siamo persone resilienti, capaci di fronteggiare le difficoltà in modo positivo, per cui, avere delle preoccupazioni per la nostra salute in questo momento è normale, purchè non diventino eccessive.
Una strategia utile, potrà essere “un giorno alla volta”, facendo programmi per domani, cercando comunque di concentrarsi nel tempo attuale di ogni giornata.
E vivere questo tempo, insieme a molte altre persone nel mondo, come una sorta di prova sociale universale.

Paolo Landi 2
DOC da Contaminazione e Coronavirus:
Il nuovo Coronavirus, o Covid-19 ha provocato forti ansie e paure nella popolazione.
E’ la prima volta, infatti, che la nostra generazione affronta una situazione di questo tipo. Ci siamo trovati improvvisamente di fronte ad una totale rottura della routine, delle abitudini, in cerca di rassicurazioni e indicazioni su cosa fare per salvare la nostra vita.
Tutto ciò ha portato, in chi viveva il quotidiano in modo ordinato e routinario, a sperimentare un’ulteriore destabilizzazione.
Chi soffriva di disturbi di personalità, ansia o disturbi depressivi ed era abituato quotidianamente a vivere il disagio generato dal proprio disturbo, facendo fatica ad inserirsi nella routine normale, incredibilmente è stato meglio.
Il disagio invece più condizionato dalla attuale emergenza sanitaria da Covid-19 è stato il Doc da Contaminazione.
Chi soffre di questo disturbo, già in periodi non a rischio epidemia come quello attuale, ha sperimentato una particolare forma di disturbo ossessivo compulsivo (DOC) consistente nell’esigenza continua e compulsiva di lavarsi e decontaminarsi. Il terrore è appunto quello di un potenziale contagio, sia mediante agenti patogeni (virus, batteri, particolari alimenti), sia mediante agenti presenti nell’ambiente.
Le ossessioni di contaminazione e le relative compulsioni di pulizia possono essere così intense da portare a comportamenti veramente esasperati, al punto da essere eccessivi, amplificati, scollegati da un piano di realistico allarme per il rischio temuto.
Questi comportamenti sono compulsivi, e quindi quasi impossibili da trattenere: la persona si sente assolutamente impossibilitata a non farli, pena il vivere un intenso stato di ansia e di disagio.
Chi soffre di DOC è in primis una persona apprensiva e ansiosa, che è dominata da uno schema difensivo basato sulla percezione di estrema vulnerabilità da parte del mondo esterno.
Ovvio che in una situazione di emergenza sanitaria come quella attuale e con le misure necessarie messe in atto dalle istituzioni per contenere il rischio contagio, il peggiore timore per un paziente affetto da DOC da contaminazione si è trasformato in realtà.
Essendo stati costretti a rimanere a casa, e dovendo, per decisione di altri, disinfettare tutto, chi soffriva di un disturbo ossessivo compulsivo, oltre a sapere perfettamente come attenersi a queste “semplici” regole, si è trovato, nel periodo di quarantena, nella sua zona di comfort, avendo meno ossessioni legate al contagio.
Paradossalmente quindi il problema per un periodo si è neutralizzato, generando nei soggetti colpiti meno ansia ed una conseguente riduzione dei sintomi.
Attualmente invece, questo proliferare ossessivo, alla ripresa di una graduale normalità, si può incastrare benissimo all’interno del panico da Coronavirus.
È dunque importante riflettere, pur con grande sforzo, che lasciarsi andare ad eccessi e irrazionalità nei comportamenti non avrà esiti “più protettivi” ma contribuirà solo ad aumentare l’ansia e il panico individuale trasformandosi in un vero disturbo ossessivo compulsivo, oltretutto aggravato se già preesistente.

Paolo Landi 3
DOC da Contaminazione e Coronavirus:
Il nuovo Coronavirus, o Covid-19 ha provocato forti ansie e paure nella popolazione.
E’ la prima volta, infatti, che la nostra generazione affronta una situazione di questo tipo. Ci siamo trovati improvvisamente di fronte ad una totale rottura della routine, delle abitudini, in cerca di rassicurazioni e indicazioni su cosa fare per salvare la nostra vita.
Tutto ciò ha portato, in chi viveva il quotidiano in modo ordinato e routinario, a sperimentare un’ulteriore destabilizzazione.
Chi soffriva di disturbi di personalità, ansia o disturbi depressivi ed era abituato quotidianamente a vivere il disagio generato dal proprio disturbo, facendo fatica ad inserirsi nella routine normale, incredibilmente è stato meglio.
Il disagio invece più condizionato dalla attuale emergenza sanitaria da Covid-19 è stato il Doc da Contaminazione.
Chi soffre di questo disturbo, già in periodi non a rischio epidemia come quello attuale, ha sperimentato una particolare forma di disturbo ossessivo compulsivo (DOC) consistente nell’esigenza continua e compulsiva di lavarsi e decontaminarsi. Il terrore è appunto quello di un potenziale contagio, sia mediante agenti patogeni (virus, batteri, particolari alimenti), sia mediante agenti presenti nell’ambiente.
Le ossessioni di contaminazione e le relative compulsioni di pulizia possono essere così intense da portare a comportamenti veramente esasperati, al punto da essere eccessivi, amplificati, scollegati da un piano di realistico allarme per il rischio temuto.
Questi comportamenti sono compulsivi, e quindi quasi impossibili da trattenere: la persona si sente assolutamente impossibilitata a non farli, pena il vivere un intenso stato di ansia e di disagio.
Chi soffre di DOC è in primis una persona apprensiva e ansiosa, che è dominata da uno schema difensivo basato sulla percezione di estrema vulnerabilità da parte del mondo esterno.
Ovvio che in una situazione di emergenza sanitaria come quella attuale e con le misure necessarie messe in atto dalle istituzioni per contenere il rischio contagio, il peggiore timore per un paziente affetto da DOC da contaminazione si è trasformato in realtà.
Essendo stati costretti a rimanere a casa, e dovendo, per decisione di altri, disinfettare tutto, chi soffriva di un disturbo ossessivo compulsivo, oltre a sapere perfettamente come attenersi a queste “semplici” regole, si è trovato, nel periodo di quarantena, nella sua zona di comfort, avendo meno ossessioni legate al contagio.
Paradossalmente quindi il problema per un periodo si è neutralizzato, generando nei soggetti colpiti meno ansia ed una conseguente riduzione dei sintomi.
Attualmente invece, questo proliferare ossessivo, alla ripresa di una graduale normalità, si può incastrare benissimo all’interno del panico da Coronavirus.
È dunque importante riflettere, pur con grande sforzo, che lasciarsi andare ad eccessi e irrazionalità nei comportamenti non avrà esiti “più protettivi” ma contribuirà solo ad aumentare l’ansia e il panico individuale trasformandosi in un vero disturbo ossessivo compulsivo, oltretutto aggravato se già preesistente.

Articolo
DIFFERENZA TRA AUTOSTIMA E FALSO SE’ GRANDIOSO
L’immagine che abbiamo di noi stessi si forma nei primissimi anni di vita, a contatto con le figure primarie di riferimento, in particolare i genitori.
E, proprio in questa delicatissima fase si aprono quelle ferite che condizioneranno la formazione dell’individuo e, soprattutto, della sua autostima.
Il pediatra e psicoanalista Winnicot sostiene che il bambino forma l’immagine di sé specchiandosi negli occhi dei propri genitori, in particolare della madre.
L’individuo che riceve dal proprio genitore una immagine svalutata, si forma una personalità segnata da profonde ferite narcisistiche.
Il narcisista, infatti, è stato un bambino che non si è sentito “visto” e riconosciuto all’interno di una relazione intima ed in particolare, che non ha potuto fare l’esperienza di riconoscere i propri limiti attraverso lo sguardo dei genitori e sentirsi, nonostante questo, accettato e amato nella propria reale natura. Per cui, il narcisista non conosce se stesso e vive sempre dietro la maschera di un falso sé grandioso e illusorio, dipendente dai successi e dall’approvazione degli altri.
Inoltre, nel disconoscere le fragilità che gli sono proprie, rischia di non essere consapevole delle proprie debolezze, ma neanche delle proprie reali potenzialità.
Da adulto tutto ciò si riflette nella mancanza di un adeguato livello di autostima.
Quando avviene un rispecchiamento distorto in cui ci viene rimandata un’immagine svalutata di noi stessi, è come se ci guardassimo in uno specchio deformante. Accade dunque di trovarsi di fronte ad un falso sé, che si modella non sulla base dell’affetto e dell’attenzione altrui, ma fondando il proprio senso dell’identità sull’accondiscendenza verso le richieste degli altri.
Falso sé di compensazione, grandioso, da non confondere con grandezza e autostima sani! L’atteggiamento tipico che ne consegue è quello iper-efficientista, con la tendenza ad incanalare tutte le energie nello sforzo di inseguire un ideale di sé irraggiungibile.
Tutto questo in antitesi con il reale concetto di autostima. Quest’ultima invece propriamente intesa come un processo cognitivo di valutazione di sé stessi.
La valutazione positiva di noi stessi dipende prima di tutto dalla consapevolezza di poter piacere agli altri e di essere a propria volta in grado di amare. Ancora poi fondamentale nella costruzione dell’autostima è il senso di autoefficacia, cioè la fiducia nelle proprie capacità.
L’autoefficacia nasce dalla percezione di poter esercitare una certa dose di autocontrollo e di controllo verso l’esterno per poter ottenere risultati positivi e realizzare i propri propositi.
Una buona autostima nasce proprio dalla riunione delle dimensioni suddette e lo stato narcisistico conduce proprio allo sviluppo di una scarsa autoefficacia.
Fondamentale dunque un lavoro psicologico su se stessi al fine di abbandonare l’impalcatura che spinge difensivamente a compiere scelte sbagliate, falsamente costruita agli occhi di sé e del mondo.
Può trattarsi di un percorso lungo e faticoso, ma favorisce la nascita di una vera autostima e fiducia in se stessi.

La supervisione psicologica
1.1 L’approccio preventivo e terapeutico della supervisione in Strutture Residenziali per anziani
Il personale delle residenze per anziani sono professionalità che direttamente o in modo trasversale sostengono persone in difficoltà di tipo esistenziale e sociale, queste professionalità, guidate da motivazioni intrinseche ed estrinseche lavorano per migliorare la vita di qualcun altro partendo da stessi.
Essere in contatto con tante storie e esperienze diverse può essere emotivamente usurante e portare l’operatore a una situazione di disagio con effetti negativi sia per l’individuo che per l’organizzazione.
Riteniamo dunque importante scegliere come figure responsabili della supervisione psicologi-psicoterapeuti che abbiamo la mission di monitorare il benessere dei lavoratori e di migliorarlo incidendo su elementi soggettivi che entrano in campo nel fronteggiare situazioni che si rivelano stressanti per l’operatore.
Pensiamo a una supervisione psicologica che si realizza attraverso fasi di osservazione, valutazione e feedback. Il supervisore è così, in questo contesto, un tutor che facilita l’operatore ad entrare in contatto con gli ospiti promuovendo in ogni professionista la meta-riflessione sulle emozioni ed i vissuti legati all’attività lavorativa nel contesto descritto.
Il modello che proponiamo si incentra su due direzioni complementari, da un lato un modello di supervisione utilizzata in psicoterapia e focalizzata sulle emozioni, dall’altro azioni con approccio terapeutico bio- sistemico, il disagio psicocorporeo del supervisionato e dell’ospite è affrontato a partire dall’unità corpo-mente che si rispecchia nelle emozioni.
Un modello di supervisione che è essenzialmente aiuto personale, professionale ed emotivo: uno spazio di elaborazione e condivisione che mira al benessere degli operatori e quindi degli ospiti e che ha l’obiettivo di ridurre i fattori stressanti, aspetto quest’ultimo, considerato una necessità etica e deontologica in ambiti professionali basati sulla qualità delle relazioni d’aiuto quale è una struttura residenziale.
Bernard (1997) ha proposto tre ruoli generali che il supervisore dovrebbe avere:
• Ruolo di insegnante: in cui si assume la responsabilità di stabilire quali conoscenze sono necessarie al supervisionato affinché divenga più competente;
• Ruolo di counseling: in cui il supervisore facilita l’esplorazione occupandosi della realtà interpersonale e intrapersonale del supervisionato;
• Il ruolo di consulente: in cui il supervisore agisce come risorsa che incoraggia il supervisionato a fidarsi dei propri pensieri, dei propri insight e di ciò che sente rispetto al lavoro con i clienti.
La supervisione basata sulle emozioni (EFT) adotta tutti e tre i ruoli; il supervisore è “un’insegnante” che fa apprendere abilità impegnandosi in una relazione collaborativa basata sulla mutualità favorendo la crescita del supervisionato; il supervisore è colui che supporta offrendo un counseling supportivo al supervisionato che porta dei blocchi personali o problemi che attengono alla sua vita personale che influenzano la vita professionale; il supervisore è un consulente che svolge la funzione di facilitatore dello sviluppo del supervisionato, incoraggiandolo ad avere fiducia nei suoi sentimenti e nelle sue idee riguardo al lavoro con i clienti.
1.2 L’approccio bio-sistemico nei colloqui con il personale
Uno degli obiettivi della supervisione psicologica è fornire all’operatore strumenti affinché partendo da se stesso possa inserirsi in modo positivo e funzionale nell’equipe intesa come gruppo rivolto al benessere dell’anziano ospite.
Partire da se stessi implica trovare ascolto per i propri bisogni, un ascolto che il supervisore psicoterapeuta può perseguire attraverso incontri con un approccio di natura bio-sistemica.
La biosistemica nasce dall’opera dello psichiatra e psicoterapeuta americano Jerome Liss, un’opera di assoluta ricchezza di contenuti e applicazioni.
La biosistemica ha due tratti caratteristici. Il primo è la costante integrazione di strutture concettuali provenienti da discipline diverse, in primis psicologia e neurobiologia. Il secondo tratto è l’integrazione costante tra teoria e pratica, tra basi concettuali e modalità concrete di agire. I paradigmi della biosistemica vanno sperimentati e provati dal professionista per alleviare sofferenze e disagio presso individui o gruppi.
La biosistemica indaga la salute personale come sistema integrato, tra un versante soggettivo, profondo ed interno e un versante sociale, esterno, pubblico.
L’ambiente condiziona la persona e la persona condiziona l’ambiente. Questa diade persona-ambiente è la stessa che ha prodotto il termine bio-sistemica dove bio è riferito alla persona, mentre sistemica si riferisce alla complessità interpersonale, delle interazioni e delle culture in gioco. La complessità ci dice come ogni comportamento abbia tre radici: individuale, interpersonale e ambientale.
La biosistemica applicata al lavoro da vent’anni a questa parte ha prodotto funzioni che ne definiscono il valore euristico e gli sbocchi operativi.
E’ un metodo per la consulenza al cambiamento nei gruppi e nelle organizzazioni ed è uno strumento di formazione alle competenze comportamentali per le professioni, in questa sede professioni d’aiuto.
E’ un servizio di facilitazione sul campo, quale aiuto diretto alle persone. Gli incontri individualizzati con il personale mirano ad allenare l’operatore a familiarizzare con la propria vitalità e a sostenere una fisiologica alternanza di stati emotivi caratterizzanti le professioni d’aiuto. I risultati da perseguire attraverso gli incontri individualizzati sono, come descritti anche in biosistemica (Giampiero Genovese, Marina Saviozzi):
– segnalare un modello di comunicazione-che può essere appreso-orientato alla chiarezza del proprio pensiero e alla capacità/utilità di verbalizzarlo;
– valorizzare le possibilità del contesto in cui si trova, setting come luogo in cui è possibile dire quello che si sente e prova;
– promuovere un processo di autodeterminazione del supervisionato attraverso l’espressione delle proprie esigenze nei diversi contesti.
2.1 L’intelligenza emotiva come attenzione costante alla miglior versione di se stessi, il supervisore come promotore dell’avanzamento professionale in termini emotivi-relazionali.
Il supervisore ha il ruolo di incoraggiare le abilità che fanno capo all’intelligenza emotiva, la supervisione psicologica mira ad incoraggiare e sviluppare con determinati strumenti di azioni tali abilità.
I risultati, nel lungo periodo, saranno elevata soddisfazione lavorativa, elevato attaccamento all’organizzazione, attenzione nei confronti della propria crescita professionale, performance migliori individuali e di team: caratteristiche queste di chi ha imparato a sviluppare una buona intelligenza emotiva.
L’espressione intelligenza emotiva concerne alla capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, motivare noi stessi, gestire positivamente le emozioni, tanto interiormente, quanto nelle nostre relazioni.Essa si riferisce alle abilità che, per quanto complementari, sono distinte dall’intelligenza accademica e quindi dalle capacità puramente cognitive misurate dal QI.
L’intelligenza intellettuale ed emotiva esprimono l’attività diparti diverse del cervello. L’intelletto si basa sulle elaborazioni che si hanno a livello della neocorteccia, ossia gli strati superficiali del cervello; i centri emotivi invece, si trovano in profondità, nelle regioni sottocorticali: l’intelligenza emotiva comporta il funzionamento integrato di questi centri con quelli intellettuali. Howard Gardner, psicologo di Harvard nel 1983 propose un modello molto apprezzato di intelligenza multipla ed è uno dei teorici più autorevoli che sostengono la distinzione tra capacità intellettuali ed emotive: il suo elenco di sette tipi di intelligenze non comprendeva solo le abilità verbali e di calcolo, ma anche due varietà personali che sono la conoscenza del proprio mondo interiore e la destrezza sociale.
Una teoria competa dell’intelligenza emotiva è stata proposta da Peter Salovey e John Mayer nel 1990. Ancora un altro modello pioneristico di intelligenza emotiva era stato proposto negli anni Ottanta da Reuven Bar On, psicologo israeliano. Salovey e Mayer definirono l’intelligenza emotiva come la capacità di dominare i sentimenti propri ed altrui e di usare i primi per guidare il pensiero e l’azione. Daniel Goleman, psicologo statunitense, ha adattato il modello di Salovey e Mayer traendone una versione che è molto utile per comprendere come i talenti emotivi si rivelano importanti nella vita lavorativa, tale adattamento comprende cinque fondamentali competenze emotive e sociali:
• Consapevolezza di sé: conoscere in ogni particolare momento i propri sentimenti e le proprie preferenze e usare questa conoscenza per usare i propri processi decisionali; avere una valutazione realistica delle proprie abilità e una ben fondata fiducia in se stessi;
• Dominio di sé: gestire le proprie emozioni affinché esse facilitino il compito in corso; essere capaci di metter in un secondo momento le gratificazioni per perseguire i propri obiettivi e sapersi riprendere dalla sofferenza emotiva;
• Motivazione: usare le proprie preferenze più intime per spronare e guidare se stessi al raggiungimento dei propri obiettivi e per aiutarsi a prendere l’iniziativa, essere efficienti nonostante eventuali insuccessi e frustrazioni;
• Empatia: percepire i sentimenti degli altri, essere capaci di adottare la loro prospettiva e coltivare fiducia e sintonia emotiva con una ampia gamma di persone fra loro diverse (colleghi, ospiti della struttura, rete familiare degli ospiti);
• Abilità sociali: gestire bene le emozioni nelle relazioni e saper leggere con accortezza le reti sociali e le singole situazioni; usare queste capacità per cooperare e lavorare in team.
2.2 Fare la differenza: l’operatore empatico
Lavorare a contatto con persone istituzionalizzate, comporta un carico emotivo non indifferente in quanto non sempre l’anziano ha scelto. Inoltre le diverse patologie che compromettono la qualità della vita in età avanzata tra cui la demenza senile, rappresentano quasi un ostacolo alla piena sintonia tra operatore e utente.
Sintonizzarti con l’altro è qualcosa che necessita di competenza empatica, quest’ultima è un aspetto che può essere rafforzato attraverso strumenti che il supervisore fornisce all’équipe e che competono la capacità di cogliere quello che gli altri provano senza bisogno che lo esprimano verbalmente.
La chiave fondamentale per conoscere il terreno emotivo altrui è necessariamente avere un’intima familiarità con il nostro. E’ proprio l’intima familiarità uno dei punti di partenza nonché di arrivo di una supervisione impostata sulle emozioni e sul sentire affinché l’operatore sia capace di ascoltare l’ospite in modo autentico.
E’ raro che le persone ci dicano cosa che cosa provano, piuttosto ce lo comunicano con l’espressione del volto, con il tono di voce o in altri modi non verbali. L’abilità di captare queste comunicazioni impercettibili si fonda su determinate capacità, soprattutto sulla consapevolezza di sé e sull’autocontrollo.
Aspetti quest’ultimi su cui una supervisione psicologica come impostata a palazzo Belvedere, lavora attraverso i colloqui e le tecniche di rilassamento ed ascolto di sé descritte. Se non siamo capaci di ascoltare i nostri sentimenti o di impedire che gli altri ci sommergano, non avremo alcuna speranza di entrare in contatto con gli stati d’animo degli altri.
L’empatia è il nostro radar sociale, quando le persone mancano di empatia sono “fuori”. Essere infatti sordi emotivamente ci rende goffi e si palesa attraverso un’errata interpretazione dei sentimenti, un’ottusità meccanica e desintonizzata, un’indifferenza che può distruggere un rapporto o non farlo affatto iniziare.
Una delle possibili forme assunte dalla mancanza di empatia è quella di interagire con gli altri considerandoli come stereotipi invece che come individui unici, così l’ospite della casa albergo diventa solo l’anziano uguale a tutti gli altri anziani con i pregiudizi che la condizione di senilità inevitabilmente porta.
L’empatia, come minimo, implica la capacità di leggere le emozioni altrui; a un livello superiore essa ci porta a percepire e a reagire alle preoccupazioni o ai sentimenti non verbalizzati dell’altro. Al massimo livello, l’empatia, coincide con la comprensione dei problemi e delle ansie che stanno dietro ai sentimenti altrui.
Il lavoro del supervisore è far riconoscere all’operatore il valore delle sue emozioni in modo da poter lavorare in sintonia con l’ospite.
Il presupposto è che le emozioni sono contagiose, lo sono le emozioni del supervisore nei confronti del supervisionato e viceversa, lo sono le emozioni degli operatori nei confronti dei pazienti e viceversa.
A sostegno di ciò, tra gli altri, ci pare doveroso citare il pensiero del grande psicanalista svizzero C.G. Jung, egli disse “nella psicoterapia, anche se il medico è del tutto distaccato dai contenuti emotivi del paziente, il fatto stesso che questi abbia delle emozioni ha un effetto su di lui.
Ed è un grande errore se il medico pensa di potersi sollevare al di sopra di questo. Non può far altro che diventare consapevole del fatto che è influenzato. Se non si rende conto di questo, è troppo distante e quindi non capisce nulla”.
Ciò che vale nello scambio in psicoterapia non è meno vero in altri contesti e nel nostro caso, nello scambio tra operatore e ospite della struttura.
Crediamo che saper sintonizzarsi con le proprie e altrui emozioni sia tra l’altro, uno strumento valido per prevenire il burnout soprattutto nelle professioni d’aiuto.
Aiutare in un contesto in cui l’anziano magari non ha scelto di essere, significa fornire all’operatore abilità emotive affinché si sintonizzi con l’ospite senza esserne però sopraffatto.
L’empatia non significa soffrire o gioire quanto l’altro, ma sentire l’altro e aiutarlo a canalizzare in modo positivo le sue stesse emozioni proprio perché abbiamo imparato a riconoscerle.
Inoltre, nel momento in cui l’operatore impara a riconoscere le emozioni che prova, impara anche a gestirle e a prevenire e riconoscere situazioni che portano a un rischio per se stesso e per la persona di cui si prende cura.

Attaccamento e stile educativo
Paolo Landi, psicologo-psicoterapeuta, supervisore Casa Albergo per Anziani “Palazzo Belvedere” Sicignano degli Alburni
La supervisione psicologica nei servizi residenziali per anziani: uno strumento per permettere all’operatore di sintonizzarsi con se stesso e di entrare in relazione con gli altri in modo autentico.
Key words: supervisione-rsa-intelligenza emotiva-psicologia-biosistemica
“La supervisione è un’occasione per ricondurre qualcuno alla sua mente, per mostrargli quanto può esser bravo.” (Nancy Kline).
Che cosa significa “essere bravo” se pensiamo agli operatori dei servizi residenziali per anziani? Significa essenzialmente essere capaci di sintonizzarsi con l’altro.
Il personale delle residenze per anziani non è un semplice contenitore delle fragilità degli ospiti: è un personale chiamato a rispondere a situazioni sempre più complesse: chi opera nelle residenze per anziani è un professionista di alto livello, moderno, intelligente e orgoglioso di affrontare compiti difficili che sono l’aver in carico bisogni umani profondi delle persone ospiti.
E’ quindi, in questi scenari, fondamentale un concetto di supervisione che è se stessa relazione d’aiuto per l’operatore ed è indagine e formazione continua affinché il professionista si senta anche orgoglioso di svolgere compiti che includono, oltre a cure sul piano tecnico, il sedare le paure, l’accompagnare solitudini, il garantire libertà.
Una supervisione che diventa, attraverso i colloqui individuali, psicoterapia per gli operatori e che diventa attraverso strumenti di gruppo, una vera opportunità di crescita e di miglioramento per l’intera equipe e per gli ospiti, destinatari finali del benessere degli operatori.
Fondamentale in quest’ottica diventa potenziare l’intelligenza emotiva degli operatori per sviluppare competenze interpersonali che aiutano ad interagire in modo più funzionale con noi stessi e con gli altri.
Il presupposto è che alla base di ogni rapporto umano in cui si generano interazioni sociali ci debba essere intelligenza emotiva e di conseguenza empatia: competenze queste che il supervisore può educare ed allenare attraverso un lavoro costante che si serve degli strumenti della psicologia.
L’assunto è che ci possiamo “mettere nei panni dell’altro” solo e soltanto se siamo capaci di sintonizzarci prima con noi stessi.
La supervisione psicologica presentata in questo lavoro mira a far comprendere che diverse skills, indispensabili nelle professioni d’aiuto, possono essere apprese e messe in pratica con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dell’anziano istituzionalizzato.
Un operatore che sa ascoltarsi e sa leggere le proprie emozioni è capace di entrare in relazione con gli altri, essere presente nel momento ponendosi con una sensibile capacità responsiva.
Gli operatori di una struttura residenziale geriatrica sono spesso mossi da una profonda motivazione ad aiutare l’altro e di riflesso a dare un senso attraverso l’aiuto alla propria vita, condizioni queste di vulnerabilità allo stress lavorativo e al rischio burnout.
La letteratura psicosociale mostra che avere un sano rapporto con se stessi contribuisce a prevenire questi ultimi fenomeni : essere quindi sensibili al benessere dell’operatore è di gran lunga un punto di forza di una struttura residenziale.
Lo psicologo che svolge il ruolo di supervisore è promotore di benessere, mette al centro l’operatore e il suo vissuto emotivo, promuove un approccio positivo ed interventi finalizzati al potenziamento e alle abilità della persona mettendo in relazione il benessere dell’operatore con quello più generale della struttura in cui opera.
Tutta la vita effettiva è un incontro, siamo convinti che favorire incontri positivi con se stessi sia il modo migliore per promuovere sicurezze e per perseguire un miglioramento dell’autostima, in un’ottica positiva da trasmettere in ogni contesto lavorativo.
L’educatore come figura di attaccamento e la proiettività di attaccamento
Partendo dai ben noti fondamenti bowlbiani (modelli operativi interni e tipologie di attaccamento: sicuro, insicuro-evitante, insicuro-ambivalente, insicuro-disorganizzato), ho analizzato la teorizzazione sul “sistema di attaccamento-accudimento” allargandolo dalla diade madre-bambino alla relazione educativa in senso lato.
Da un’analisi della letteratura, è emerso come l’educatore possa a pieno titolo configurarsi come figura secondaria di attaccamento, andando ad interagire con i modelli di attaccamento trasmessi dalle figure primarie. Si tratta del costrutto di “trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento”. Con questo termine si indica quel processo di assimilazione e accomodamento che porta al cristallizzarsi dei modelli operativi interni, che peraltro saranno complementari a quelli del genitore.
Ciò è tanto più importante, se si considera che molti studi hanno mostrato la predittività di stili di attaccamento insicuro nell’infanzia rispetto a possibili futuri esiti psicopatologici.
Si è potuto quindi affermare, sulla scorta di ricerche e studi approfonditi, tre punti fondamentali:
• l’attaccamento influenza la psiche del bambino e, se disfunzionale, può contribuire a disorganizzare la personalità in evoluzione, soprattutto in famiglie ad elevato rischio psicosociale;
• l’educatore può avere un ruolo nello sviluppo dell’attaccamento infantile ed attutirne l’impatto sulla personalità attraverso l’attivazione di un sistema attaccamento-accudimento alternativo;
• la funzione di accudimento dell’educatore è influenzata dalle sue rappresentazioni di attaccamento.
Si potrebbe parlare di una sorta di proiettività delle rappresentazioni di accudimento, sviluppatesi in stretta relazione con le esperienze di attaccamento. Queste rappresentazioni, o modelli operativi, di accudimento agirebbero come una sorta di filtro.
Se la ricerca afferma che l’educatore può avere un ruolo nello sviluppo delle rappresentazioni di attaccamento, questo ha una ricaduta pratica più che evidente: l’attivazione di servizi educativi attachment-oriented può
• su un piano immediato, migliorare la capacità di mentalizzazione dei bambini provenienti da contesti ad alto rischio e quindi, nell’immediato, migliorare la qualità delle loro relazioni e dirimere le tante ambiguità (doppio legame) che provocano sofferenza
• su un piano prospettico, agire come fattore protettivo rispetto alla prognosi di disturbi clinici e di personalità.
…………………………………………………………………………………………………………
Il sistema di accudimento ci guida nel fornire protezione e supporto ad altri individui che si trovano in uno stato di bisogno.
Sebbene accudimento e attaccamento siano sistemi comportamentali separati, si influenzano reciprocamente nel modellare il comportamento delle persone.
Il sistema di accudimento si attiva quando si è in presenza di qualcuno che sperimenta sofferenza o necessita di cure e protezione Per questo motivo il sistema di accudimento è considerato complementare al sistema di attaccamento in quanto motiva le persone ad offrire aiuto, conforto e sostegno in risposta ai segnali generati dallo stato di bisogno di un’altra persona.
Le emozioni derivanti dall’attivazione di questo sistema sono ansia, compassione, tenerezza protettiva o colpa per il mancato accudimento. Il sistema si disattiva alla cessazione delle condizioni attivanti, quindi alla percezione di segnali di sollievo e sicurezza da parte dell’altro.
La relazione tra sistema di accudimento e sistema di attaccamento
Madre e bambino hanno entrambi un ruolo attivo nell’instaurare una relazione: essi sono alla costante ricerca di interazione, in particolar modo nelle prime fasi di sviluppo. Tale interazione è molto importante in quanto influenza lo sviluppo emotivo, cognitivo e quella che sarà la personalità adulta dell’infante.
Entrambe le parti della diade nella relazione madre-figlio svolgono ruoli attivi nell’ambito della loro relazione. Studi recenti, hanno dimostrato la presenza di determinati meccanismi fisiologici che permettono al bambino di richiamare, in maniera quasi automatica, l’attenzione della madre (o caregiver) che a sua volta ha meccanismi fisiologici che, sempre automaticamente, le consentono di rispondere ai richiami e ai segnali del bambino.
Il bambino ha un ruolo attivo nell’instaurare una relazione grazie ad una dotazione genica, ovvero a schemi di comportamento innati, efficaci sin dalla nascita nel promuovere vicinanza e contatto con la madre.
Data questa osservazione, l’attaccamento può essere considerato come una motivazione primaria del bambino, nonché un suo bisogno primario e non più una conseguenza del soddisfacimento di bisogni alimentari o fisici.
Anche la predisposizione all’ accudimento da parte degli adulti nei confronti dei bambini piccoli sarebbe legata a specifici patterns di attivazione cerebrale: recenti studi hanno dimostrato la presenza di meccanismi fisiologici innati, biologicamente basati, e reciproci che si attivano in maniera automatica nella madre, che risponde ai segnali del piccolo ma anche nel bambino che richiama la sua attenzione e vicinanza.
Nella specie umana, i bambini nascono in uno stadio di sviluppo meno avanzato rispetto ad altri animali, pertanto nei primissimi mesi, sono le madri a contribuire notevolmente a far sì che i piccoli rimangano vicini: siccome appunto il piccolo non è in grado di aggrapparsi, esse lo sorreggono offrendo in questo modo un contatto fisico, che fornisce a sua volta calore e affetto.
Numerosi studi hanno evidenziato che questo contatto fisico (carezze, abbracci ect.) contribuisce, sin dalla nascita, allo sviluppo di attività come la respirazione, la vigilanza, le difese immunitarie, la socievolezza e il senso di sicurezza essenziali per un regolare sviluppo sessuale oltre che per la salute mentale del piccolo (Anzieu, 1985).
Altro effetto sul funzionamento corporeo della relazione madre-figlio, dovuto al contatto fisico, è l’aspetto di termoregolazione: una madre riesce a mantenere la temperatura corporea del suo piccolo al pari di apparecchi da riscaldamento altamente tecnologici, nel momento in cui il figlio nudo ed asciutto viene posizionato pelle a pelle sul suo petto.
Per quanto riguarda il bambino, seppur non abbia la capacità motoria di avvicinarsi alla madre o mantenersi presso di essa, viene al mondo dotato di numerosi strumenti che, fin dalla nascita, hanno la funzione di mostrare certi segnali differenziati che inducono in modo peculiare particolari tipi di risposta da parte di chi li cura: i più evidenti sono il pianto e il sorriso (Schaffer, 1998).
Queste due forme di comportamento, che hanno l’effetto di far avvicinare la madre al bambino, vengono raggruppate da Bowlby, nella classe dei “comportamenti di segnalazione” in cui possiamo trovare anche altri comportamenti quali il richiamo e tutti i gesti classificabili come segnali sociali. Un episodio di pianto è uno stimolo in grado di attivare il Sistema Nervoso Centrale sia del bambino che lo produce sia dell’ascoltatore, creando uno stato di attenzione reciproca (Esposito e Venuti, 2009).
Inoltre, rappresenta una ‘sirena biologica’ che, operando in larga misura come un rinforzo negativo (Barr et al.,2006; Soltis, 2004), riesce a modificare e attivare lo stato funzionale dei genitori, promuovendo prossimità e contatto con essi e in particolar modo con la madre, attivando il suo comportamento di accudimento (Bell and Ainsworth, 1972) e motivandola a rispondere prontamente e in maniera adeguata nutrendo il piccolo, proteggendolo o confortandolo (Venuti e Esposito, 2007).
La capacità materna di mettere in atto comportamenti di accudimento in risposta ai segnali del bambino promuove lo sviluppo della comunicazione: i bambini che piangono meno all’età di un anno, appunto grazie alla sensibilità delle loro madri, hanno maggiore probabilità di sviluppare altre strategie comunicative, quali ad esempio le espressioni facciali, gesti corporei e vocalizzazioni rispetto a quelli che piangono di più. Inoltre la reattività di un caregiver, svolge un ruolo importante nello sviluppo della personalità, temperamento e capacità cognitive e linguistiche del bambino (Esposito e Venuti, 2009).
E’ stato dimostrato che la risposta materna si attiva in maniera automatica e, per tale ragione, è possibile ipotizzare che l’evoluzione abbia permesso di sviluppare nelle donne, in particolare quelle in età fertile, particolari meccanismi fisiologici per percepire e rispondere appropriatamente al pianto.
Un recente studio ha evidenziato che nei padri che vedono i loro bambini in difficoltà, i livelli di testosterone si abbassano facendo risultare gli uomini, di fatto, maggiormente sensibili e pazienti: ne consegue uno stile di parenting associato ad un miglior sviluppo sociale, emotivo e cognitivo del bambino.
Infatti, ridotti livelli di testosterone faciliterebbero l’ accudimento dei figli da parte del padre. Evolutivamente parlando, questo meccanismo sarebbe utile ad incrementare la risposta di accudimento del padre.
Livelli di testosterone elevati, infatti, correlano con una maggiore propensione a mettere in atto comportamenti aggressivi, potenzialmente dannosi per l’incolumità fisica ma anche psicologica del bambino.
Come lo stile di attaccamento influenza l’ accudimento
Mikulincer e Shaver hanno suggerito che le differenze individuali nel sistema di accudimento possono anche essere concettualizzate come modelli di iperattivazione o disattivazione del sistema. Attraverso vari studi, hanno dimostrato che l’iperattivazione o la disattivazione del sistema di caregiving è associata a problemi nella regolazione di emozioni, impulsi e azioni dirette agli obiettivi e mette una persona a rischio di problemi emotivi e disadattamento (ad esempio, essere meno utili o mostrando minore cura e maggiore disagio nei vari contesti assistenziali).
Sebbene l’ accudimento e l’attaccamento siano sistemi comportamentali separati, e ogni sistema influisce sul comportamento in modo univoco, i due sistemi interagiscono nel modellare il comportamento delle persone ((Bowlby, 1969/1982; George & Solomon 2008; Mikulincer & Shaver, 2009).
L’interazione tra i due sistemi è ancora più complicata in quanto un caregiving (principalmente durante l’infanzia) può influenzare lo sviluppo dello stile di attaccamento.
Pertanto, la cura sensibile e di supporto per i caregiver primari è probabile che si traduca in un attaccamento sicuro, che può facilitare la capacità di un individuo di mettere in atto un accudimento sensibilie e supportivo.
Viceversa, scarsi sensibilità e supporto possono portare a uno stile di attaccamento insicuro, che è noto per essere associato a scarsa capacità di accudimento nell’età adulta.
Come risultato, gli individui sviluppano un modello di comportamento che riflette la scarsa sensibilità del caregiving, imparando a fornire aiuto con una modalità distante e fredda, o controllante e invadente.
Nello specifico, l’attaccamento sicuro facilita uno stile di caregiving caratterizzato da elevata prossimità, sensibilità e reattività; uno stile di caregiving evitante invece predispone a un accudimento più controllato e distante caratterizzato da scarsa prossimità e sensibilità; e infine uno stile di caregiving ansioso è collegato a uno stile di accudimento compulsivo, invadente e incoerente, scarsamente sensibile al reale bisogno dell’altro.
Ciò suggerisce un legame evolutivo tra attaccamento e caregiving (ad esempio, Kestenbaum et al., 1989).
Nell’uomo, secondo Bowlby (1969, 1973, 1979, 1980, 1988), esiste una tendenza innata a ricercare la vicinanza con la figura d’attaccamento in situazioni di pericolo, stress e solitudine. Il comportamento d’attaccamento si attua come ricerca attiva della figura di riferimento che accudisce e protegge.
Nel tempo le modalità con le quali si entra in relazione con le figure d’attaccamento, inizialmente la madre, si stabilizzano e tendono a generalizzarsi, formando schemi cognitivi interpersonali, che Bowlby chiama Modelli Operativi Interni (MOI).
Queste rappresentazioni apprese di sé, della relazione con l’altro e delle figure d’attaccamento s’innestano sulle componenti innate del sistema e costituiscono una caratteristica individuale che modella le relazioni interpersonali, portando alla strutturazione di uno specifico stile di attaccamento: sicuro, insicuro evitante, ansioso-ambivalente, disorganizzato.
L’educatrice di asilo nido si trasforma in copertina di Linus – L’attaccamento come passaggio del testimone dal caregiver all’educatrice
Un attaccamento sicuro verso l’educatrice è molto importante e costituisce la base per un sano sviluppo socio-emozionale e cognitivo del bambino.
A partire dai primi scambi tra madre e bambino si sviluppa il legame di attaccamento. Le specifiche modalità interattive esperite dalla diade portano allo sviluppo dei modelli operativi interni (MOI), grazie ai quali il bambino potrà crearsi aspettative, circa le risposte ai propri bisogni.
Con l’ingresso al nido la figura dell’educatrice diviene centrale nel processo di crescita cognitiva, emotiva e sociale del piccolo: promotore di un sano sviluppo è il legame di attaccamento instaurato tra educatrice e bambino.
Cos’è il legame di attaccamento
Il legame di attaccamento, come teorizzato da John Bowlby, si sviluppa grazie ai primi scambi tra figura di riferimento (principalmente la madre) ed il bambino. Il motore dell’attaccamento non è dato, secondo l’autore, come sosteneva la psicoanalisi, dal nutrimento, ovvero dalla ricerca di cibo e dalla spinta alla sopravvivenza, quanto piuttosto dalle emozioni e dal riconoscimento delle stesse.
Bowlby dimostrò come l’instaurarsi di un adeguato stile di attaccamento comportasse lo sviluppo di una personalità armoniosa, affermando che l’attaccamento è parte integrante del comportamento umano dalla culla alla tomba (Bowlby, 1982).
Sulla scorta dei modelli operativi interni (Bowlby, 1969; 1988), sviluppatisi grazie ai propri legami affettivi, il genitore si rapporta al bambino in un determinato modo, rispondendo alle sue richieste di attenzione in modo costante/incostante.
Da tali input il bambino interiorizza, a propria volta, specifici schemi del Sé, dell’altro e del rapporto Sé-Altro, sviluppando un tipo di attaccamento sicuro o insicuro.
Nello specifico, se il caregiver si mostra responsivo e disponibile emotivamente, il bambino lo cercherà con fiducia nelle situazioni di stress, sicuro di poter essere consolato; di contro, un genitore imprevedibile e disponibile in modo incostante porterà allo sviluppo di un attaccamento insicuro, in quanto non in grado di contenere e regolare le emozioni cui il piccolo si trova a far fronte.
Un’adeguata sintonizzazione emotiva porta allo sviluppo di apprendimenti positivi, basati su cure sintoniche ai bisogni del piccolo (Van Der Kolk, 2015).
Le modalità relazionali co-costruite dalla diade bambino-madre durante l’infanzia verranno, poi, potenzialmente estese a tutti i rapporti futuri.
Il rapporto di attaccamento educatrice-bambino
Quando un bambino fa il suo ingresso al nido (età: 3 mesi-3 anni) si inizia, generalmente, con una prima fase di inserimento, della durata variabile e dipendente da fattori quali età del bambino, temperamento della madre e del bambino, precedenti esperienze di separazione dalla figura di riferimento, durante la quale l’educatrice, gradualmente, si inserisce nel rapporto diadico.
Questa fase di ambientamento è molto delicata e di forte impatto emotivo per tutti i soggetti coinvolti.
Mentre il bambino inizia ad esplorare il nuovo ambiente, l’educatrice ha modo di fare domande al caregiver al fine di ottenere informazioni su cui innescare il processo di conoscenza col piccolo.
La presenza della madre diverrà sempre più evanescente, fino a giungere al momento del ‘saluto alla porta’, dove, all’arrivo, l’educatrice accoglie il bambino per fare l’ingresso in classe e la madre resta all’esterno. Ciò decreta il termine della fase di inserimento.
Questi primi momenti, molto delicati ed importanti, rappresentano un’opportunità di studio per entrambi, bambino ed educatrice, risultando propedeutici allo stabilirsi del rapporto di attaccamento: la condivisione delle routines permetterà lo sviluppo di uno scenario ‘prevedibile’, grazie allo scandirsi di momenti ripetibili nella quotidianità, quali l’accoglienza, il cambio e la pulizia personale, il pranzo, il riposino, la merenda (Galardani, 201; Catarsi e Baldini, 2008; Weikert, 2005).
L’assimilazione delle routines funge, dunque, da vettore spaziale-temporale, orientando il bambino e dando lui sicurezza e costanza nella quotidianità (Corsaro, 1979).
L’educatrice costituisce l’anello di congiunzione e di comunicazione centrale nel sistema triangolare madre-educatrice-bambino (Fig.1), dove ogni elemento influenza l’omeostasi del sistema di attaccamento.
Gli adulti di riferimento svolgono un’importante funzione di scaffolding (Wood, Bruner, Ross, 1976) ovvero di sostegno, favorendo gli schemi di esplorazione e gioco del bambino. Ergo nell’ambiente nido l’educatrice diviene la bussola del bambino, cui rivolgersi nei momenti di conflitto, frustrazione, nonché condivisione delle emozioni positive.
Attaccamento sicuro educatrice-bambino
All’arrivo nell’asilo nido il bambino si trova nel momento di massimo sviluppo dell’attaccamento: 8-25 mesi (Bolwlby, 1969).
Come dimostrato dagli studi di Howes, Rodning, Galuzzo e Myers (1998) la creazione di legami di attaccamento sicuro verso una o più educatrici è molto importante e costituisce la base per un sano sviluppo socio-emozionale e cognitivo del bambino, potendo, inoltre, compensare una relazione insicura con la madre. Ciò è stato ampiamente dimostrato in letteratura (Cassibba, 2009; Cassibba et al., 2000).
Il bambino invia costanti segnali sui propri bisogni ed il modo in cui essi vengono accolti dall’adulto lo porta a crearsi delle rappresentazioni interne su di sé e sull’altro, alimentando aspettative future. Rispondere in modo costante e coerente alle richieste del bambino conduce quest’ultimo a sviluppare fiducia nell’altro, rappresentato come individuo disponibile ed attento, e fiducia in sé, auto-rappresentato come soggetto degno di amore ed attenzioni.
La strategia idonea per le educatrici di asilo nido al fine di favorire un attaccamento sicuro è data dunque:
• dall’interpretazione dei segnali inviati dai bambini;
• da risposte costanti e coerenti a tali segnali.
L’educatrice deve mostrarsi disponibile, non solo fisicamente, ma soprattutto empaticamente, mantenendo il contatto oculare (a turno tra i vari bambini, ma sufficientemente lungo per ognuno), avvicinarsi a ciascuno, contenendo coloro che più ne necessitano.
È importante ed imprescindibile sintonizzarsi con i bisogni dei bambini, stimolando l’autonomia di ciascuno e sostenendo nel momento di difficoltà.
Strumento elettivo di cui l’educatrice deve fare buon uso è l’osservazione: per suo tramite riuscirà a tenere a mente il bambino, a pensarlo, cogliendo sfumature individuali e non cadendo in clichés.
Quando il piccolo percepirà l’educatrice come base sicura (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1988) si sentirà libero e desideroso di esplorare l’ambiente, in grado di interagire con i pari ed acquisire nuove conoscenze (Bergin e Bergin, 2009), sperimentarsi e conoscersi, con la consapevolezza che, in caso di bisogno, avrà la sua ancora di salvezza sapendo per certo che sarà il benvenuto, nutrito sul piano fisico ed emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato (Bowlby, 1988, p.10).
Attaccamento ed esplorazione possono, infatti, essere visti come sistemi complementari, laddove al disattivarsi dell’uno si attiva l’altro: è l’adulto che, ponendosi come base sicura, favorisce la regolazione dei due sistemi.
Ecco come l’educatrice si trasforma in copertina di Linus all’interno del nido: l’oggetto transizionale che il bambino porta con sé in sostituzione della propria madre per sentirsi non solo protetto, nell’ambiente nido è dato dalla presenza dell’educatrice di riferimento.
Non dimentichiamo, infatti, che nei primi 3 anni di vita si raggiungono le tappe di sviluppo più importanti legate al linguaggio, alla motricità, alla socialità, al controllo sfinterico e che dunque, il bambino co-costruisce la propria identità giorno dopo giorno.
D’altro canto le educatrici esperiscono dalla creazione di legami di attaccamento sicuro un maggior senso di efficacia educativa, contribuendo ad incrementare il senso di autostima ed abbassando il livello di stress, elevato in tale professione.
È dunque chiaro come il miglior modo per promuovere lo sviluppo del bambino nell’ambiente nido sia la creazione di legami di attaccamento sicuro.
Educare alla creatività
L’apprendimento è per definizione un atto creativo.
La persona che apprende destruttura, mastica la materia trasmessa dal professore, dall’esperto o dal software, la digerisce, l’assimila e la ricostruisce secondo le proprie strutture mentali.
Dunque un modello didattico per essere efficace dovrebbe ricalcare questo processo di metabolizzazione e le tecniche creative sono particolarmente utili per sviluppare le abilità di imparare ad apprendere.
“Se gli uomini si dividono in due gruppi: quello della ristretta élite di persone predestinate che hanno ricevuto alla nascita in regalo il potere della creazione, e quello della massa immensa destinata alla contemplazione del genio irraggiungibile e alla semplice utilizzazione dei suoi prodotti, l’umanità avrà delle difficoltà nel progredire.
Se al contrario la creatività è una funzione universale, potenzialmente presente in ogni individuo, allora la realizzazione di questa funzione diventa un problema di educazione”. (R. Golton, C. Clero, L’activité créatrice chez l’enfant)
Henri Poincaré ci ha fornito la seguente definizione: creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuove, che siano utili.
Da questa prima definizione – secondo la quale creare consiste nel realizzare un assemblaggio originale e utile associando elementi pre-esistenti – possiamo rilevare importanti criteri di riconoscibilità della creatività, ma occorre tenere ben presente che la parola americana creativity indica tre cose: una capacità delle persone, un processo, ossia il percorso che segue qualsiasi creatore utilizzando determinate logiche, e infine un metodo, che consiste nel fare ricorso a delle tecniche e degli strumenti per la risoluzione dei problemi (Problem solving).
La capacità
Lo psicologo Torrance ha definito 4 criteri che definiscono il profilo creativo:
1. La fluidità che si misura in base al numero di risposte che una persona è capace di dare.
2. La flessibilità che misura l’elasticità mentale, ossia il numero di categorie nelle quali è possibile classificare le idee prodotte.
3. L’originalità che è il fattore più relativo in quanto dipende dal contesto nel quale l’idea è prodotta.
4. L’elaborazione valuta il grado di precisione, la ricchezza dei dettagli, secondo il quale le idee sono descritte.
La nostra opinione su questi test è che servono più che a definire un profilo strutturale di personalità a dare indicazioni utili su cosa dobbiamo fare per ottenere dei miglioramenti, a breve e a lungo termine.
John Paul Guilford ha tentato di costruire un modello tridimensionale dell’intelligenza… Una delle dimensioni di questo modello raggruppa le operazioni della cognizione, della memoria, del giudizio, della convergenza e della divergenza.
La convergenza può schematicamente essere riportata a quello che di solito si definisce intelligenza e che si misura con il Q.I., mentre la divergenza è quella forma di pensiero che va oltre i dati immediati dei problemi, che esplora in grandissima parte il campo delle possibilità e non è affatto a disagio nello stabilire tra i concetti dei collegamenti spesso impertinenti.
Certamente l’intelligenza convergente ci fornisce delle soluzioni già praticate, evitando di re-inventarle ogni volta che ci servono.
Di fronte a sfide alle quali non siamo ancora preparati abbiamo la scelta tra due possibilità: la prima consiste nel cercare di applicare soluzioni già conosciute – e purtroppo spesso risultano non adatte al problema da risolvere – la seconda consiste nell’inventare soluzioni e convalidarle per verificare quella che corrisponde meglio al problema.
Ed è questo secondo atteggiamento che esprime una certa capacità creativa, ossia la capacità di inventare oggetti o soluzioni allo stesso tempo nuovi ed efficaci.
La creatività nasce dalla dialettica Divergenza/Convergenza realizzando così quello che Silvano Arieti ha chiamato la “sintesi magica”. E durante la fase divergente l’utilizzo delle tecniche di creatività resta relativamente sterile se non si rispettano le seguenti regole della “ruota libera” ispirate al famoso brain storming, “la madre di tutte le tecniche”:
– Censura abolita: qualsiasi forma di valutazione è sospesa, sia positiva che negativa. La critica delle idee deve essere proposta nella fase successiva.
– Quantità prima di tutto!: più il numero delle idee è elevato, più aumenta la possibilità di trovarne alcune interessanti. Fare fluire il fiume del pensiero, aprire le porte del pensiero non può che produrre due effetti positivi: statistico (ci sono più possibilità di avere un’idea interessante se se ne producono cento anziché dieci) e psicologico (le idee che arrivano per prime sono generalmente le più banali; è raschiando il fondo del barile che si troveranno le idee più originali).
– Stravaganza benvenuta!: immaginare delle idee straordinarie, stupefacenti (non è cosi semplice come sembra). Più l’idea è originale, più è facile trasformarla in una realizzabile.
– Moltiplicazione sistematica!: da un’idea ne nasce un’altra, le combinazioni fra le idee sono utili. Questa regola si applica a se stessi se si è da soli, ma è ancora più feconda se si lavora in gruppo. Si raccomanda di non seguire il filo del proprio pensiero ma di essere all’ascolto delle intenzioni degli altri affinché possa essere possibile “agganciarsi” per produrre altre nuove idee.
Queste bi-associazioni hanno una probabilità di essere più originali grazie alla unicità e alla diversità dei partecipanti del gruppo di lavoro.
Il processo
Contrariamente a quanti comunemente credono che essere creativi significhi abdicare alla logica per lasciarsi andare in balia dell’irrazionale, l’espressione della creatività si avvale di un approccio multi-logico. Oltre alla logica classica, quella deduttiva o aristotelica o (del terzo escluso), la creatività si appoggia su quattro logiche creative o euristiche: la logica associativa, la logica analogica, la logica combinatoria e la logica onirica.
Il metodo
A questo punto occorre differenziare la creatività e l’immaginazione introducendo il criterio di utilità.
Questa valutazione dell’utilità di una nuova idea è realizzata ovviamente facendo riferimento a delle realtà oggettive, realtà che sono comprese e descritte da strutture.
E’ chiaro che qualsiasi organismo sociale spende una gran parte della sua energia per mantenere lo status quo, ma, allo stesso tempo, desidera sopravvivere, e la sopravvivenza, in un universo in movimento e in perpetuo cambiamento, si ottiene a prezzo di modifiche dell’organismo stesso; ed ecco che si manifesta questa dolorosa dialettica dell’innovazione, questo ruolo drammatico dell’innovatore che è allo stesso tempo figlio della sua tribù e lo straniero incaricato di farla cambiare, di costringerla a cambiare, di farle capire che se non cambia, morirà.
Così l’innovatore sarà spesso come Mowgli, né uomo, né lupo, un piede nel presente, uno nel futuro.
Uno degli slogan più noti della creatività è: to be creative is not to think but to act creatively.
Ogni innovatore segue un percorso, chiaramente delineato ed applica inconsciamente o consciamente queste “regole del gioco”.
In effetti segue il movimento dialettico del pensiero, dal disordine all’ordine ricostruito, dalla destrutturazione all’emersione di forme nuove, dal magico (meraviglioso ed impossibile), al creativo (originale e realizzabile).
Il percorso parte dalla percezione non filtrata di elementi del contesto per andare fino all’azione, alla realizzazione concreta dell’idea vincente, passando per le tappe della percezione e dell’analisi, della produzione di idee e della selezione dell’idea che realizzerà la migliore sintesi tra originalità e fattibilità, per arrivare alla tappa dell’applicazione.
La creatività non è l’arte di produrre idee ad ogni costo evitando di confrontarle con la realtà, ma è l’arte di saper dare un giudizio differito, l’arte di separare le due fasi essenziali del processo: la fase di apertura (fase divergente) e la fase di chiusura (fase convergente).
Quindi la creatività nasce da un atteggiamento di ricettività per le idee nuove, non da un atteggiamento critico e si avvale di un metodo che utilizza i vari tipi di logiche per individuare delle situazioni originali e potenzialmente efficaci.
Si riorganizzano elementi già esistenti in una nuova forma, si scoprono forme in precedenza non conosciute, si introducono nuovi elementi.
E innovare consiste nel trasformare queste idee in fatti, prodotti, soluzioni… di successo.
La creatività passa dalla persona alla realtà e viceversa: la persona raccoglie una sfida, è mossa da un desiderio.
Per immaginare una risposta vincente l’innovatore ricorre a modalità, utilizza dei percorsi e delle tecniche generalmente in modo inconsapevole.
E l’atto della creazione ha quasi sempre un doppio effetto: egoista (il piacere di avere fatto) e altruista (essere riconosciuto per avere reso un servizio a un pubblico più o meno ampio) e questa dialettica varia da una persona all’altra.
Poiché la creatività è una dote innata ed è universale, a livello potenziale, l’educazione – dai genitori agli insegnanti – può esaltare o, purtroppo troppo spesso – inibirla.
Mai distruggerla in modo definitivo. Gli psicologi dell’infanzia hanno dimostrato che è verso l’età di due anni che il bambino inizia a perdere la sua facoltà di fantasticare, che fuoriesce dal suo universo narcisista per integrare, interiorizzare le strutture del mondo esterno.
È il modo in cui si realizza questa integrazione che, secondo Louis Astruc, autore del notevole libro “Creatività e scienze umane” (Créativité et sciences humaines), determinerà ciò che sarà il “tipo” creativo dell’adulto.
Riprendiamo Jean Piaget: l’apprendimento è per definizione un atto creativo. La persona che apprende destruttura, mastica la materia trasmessa dal professore, dall’esperto o dal software, la digerisce, l’assimila e la ricostruisce secondo le proprie strutture mentali.
Dunque un modello didattico per essere efficace dovrebbe ricalcare questo processo di metabolizzazione e le tecniche creative sono particolarmente utili per sviluppare le abilità di imparare ad apprendere.
In particolare, l’educazione ha tre funzioni essenziali:
– trasmettere delle conoscenze ai discenti,
– insegnare loro a servirsene,
– insegnare loro ad imparare.
Il ruolo fondamentale dell’educatore è quello di far crescere, che non vuol dire modellare i suoi allievi, formarli conformemente all’ideale da lui definito.
Significa aiutarli a realizzare il più possibile le loro potenzialità, a spingerli a conoscersi meglio per definire il loro percorso di vita.
Significa dare loro strumenti e sostegno affinché si realizzino, diventino se stessi.
Il pedagogo israeliano Reuven Feuierstein ha sviluppato il suo metodo in un bellissimo volume intitolato Don’t accept me as I am.
Accanto a questa tradizione pedagogica della creatività basata su un insegnamento molto attivo certamente, ma mantenendo la dualità insegnante-discente, dobbiamo citare i metodi attuati nel College di Dorsmouth, negli Stati Uniti.
In questo college il ciclo di studi dell’ingegnere mira, oltre alla trasmissione di un corpus di conoscenze, a stimolare negli studenti l’espressione di una creatività selvaggia, che si tradurrà nella realizzazione pratica di progetti.
Naturalmente dispongono di mezzi tecnici e finanziari per realizzare i loro progetti e, per ottenere le informazioni o le conoscenze tecniche di cui hanno bisogno, possono rivolgersi a vari consulenti.
In altre parole, non si insegnano agli allievi-ingegneri né delle teorie psicologiche sulla creatività e l’immaginazione, né delle tecniche che permettono di avere più idee, ma li si mette direttamente in una situazione che li motiva poiché saranno votati sulla base della validità e dell’originalità delle loro idee.
Ed è in questa creatività selvaggia che consiste il pensiero creativo.
Crediamo che sia arrivato il momento di porre le basi di un sistema educativo nuovo – indipendentemente dalle discipline – e di tracciare le basi di una pedagogia della creatività.
Regola base: non dissociare divergenza e convergenza
Rimane, dunque, da compiere uno sforzo costante per migliorare il nostro strumento logico preoccupandoci, in contemporanea, di sviluppare la divergenza. C’è dunque un dialogo continuo della divergenza con la convergenza ed ogni sforzo educativo che non mirerebbe ad abbracciare questa continuità avrebbe per risultato, ancora una volta, di mutilare la personalità.
Primo passo: decondizionare
Perché decondizionare? Perché si è constatato che nel processo di invenzione e di scoperta non era coinvolta la sola ragione del ricercatore, ma la totalità del suo essere, della sua affettività, del suo vissuto allo stesso tempo corporale e mentale.
Inoltre vediamo esseri e cose soltanto in una sola dimensione, quella che può essere utile al nostro progetto, e siamo generalmente incapaci di una battitura multidimensionale e multisensoriale.
Dobbiamo dunque compiere uno sforzo importante su noi stessi per trovare l’ingenuità della nostra percezione per come lo diceva William J.J. Gordon: “osservare le cose familiari come se fossero sconosciute”.
Si tratta, attraverso esercizi e giochi insoliti, di ritrovare atteggiamenti fisici e mentali che il bambino vive spontaneamente.
Uno dei vantaggi di questo percorso è che ci permette di risalire nel nostro passato psicologico e demolire, nel migliore dei casi, alcuni blocchi psicologici che ostruiscono la libera espressione della nostra immaginazione.
Questo riferimento al mondo dell’infanzia è molto importante, poiché esalta l’aspetto ludico della creazione: creare è un gioco, si crea veramente soltanto giocando, occorre non dimenticare che il gioco è qualcosa di molto serio (v. i lavori di Winnicott e di Caillois).
Un altro aspetto molto importante di questo decondizionamento psicosensoriale è legato al carattere non verbale e collettivo degli esercizi: se la lingua è un veicolo indispensabile del pensiero, può spesso apparire come una diga alla comunicazione piuttosto che come un vero mezzo di comunicazione. Infatti, ognuno di noi ha sviluppato una grande abilità a ripararsi dietro le parole, mettere tra sé e gli altri una costruzione verbale più o meno elegante che permette di conservare la distanza che crediamo imposta dalle regole del Saper Vivere.
La pratica non verbale costringe le persone ad inventare mezzi di espressione inauditi e, pertanto, aiuta tutti ad aprirsi completamente. Si arriva in questo modo a delle vere scorciatoie emozionali che rafforzano la coesione del gruppo di ricerca.
Apprendere a combinare
L’uomo non crea nulla ex-nihilo: ha il potere di raggruppare in combinazioni originali, ed a volte pertinenti, gli elementi preesistenti.
Più andrà a cercare questi elementi in campi distanti, più modulerà assemblaggi diversi e numerosi, e avrà più possibilità di ottenere qualcosa – allo stesso tempo nuovo e realizzabile – che porterà all’innovazione o, più modestamente, ad una soluzione originale.
È’ dunque auspicabile e abbastanza facilmente realizzabile stimolare la capacità di dissociazione e l’attitudine a combinare.
Riapprendere a fantasticare
Tutti i bambini hanno un’attitudine enorme a fantasticare e ben pochi adulti la conservano.
Ma, la pratica delle infra-logiche non può accontentarsi di mettere in atto i meccanismi coscienti che sono utilizzati nel processo di ragionamenti logici formali.
Le tecniche da praticare sarebbero quelle dell’identificazione al problema (tecnica dell’analogia personale) del sogno ad occhi aperti (Rêve Eveillé Dirigé), e, infine, l’analogia fantastica da praticare da soli o in gruppo.
Filosofia delle scienze
I ricercatori sono i primi interessati alla storia e alla filosofia dei movimenti di pensiero che hanno condotto alle invenzioni tecnologiche, sociali e politiche e che hanno fatto del nostro mondo quello che è.
Ma, più generalmente, tutti coloro che hanno o avranno per funzione quella di comprendere ed agire, possono trarre un grande profitto, per via deduttiva o analogica, dallo studio della filosofia delle scienze che potrà essere insegnata utilizzando le vie più classiche.
Concentrazione, serendipità, attenzione fluttuante
Il ruolo della concentrazione in alcune fasi della ricerca è stato riconosciuto da tutti: molti inventori hanno utilizzato mezzi particolari per facilitare questa concentrazione necessaria; oggi, è possibile fare praticare esercizi, principalmente tratti dallo yoga.
Serendipidità è una parola forgiata sul principato di Serendip, antico nome del Sri Lanka dove i tre fratelli regnanti avevano la caratteristica di rispondere non direttamente alla domanda, e ciascuna delle loro risposte era una soluzione valida per un altro problema che era stato posto.
Inoltre l’attenzione fluttuante è uno stato mentale che abbiamo spesso spontaneamente, ma che possiamo apprendere a sviluppare per captare attraverso le nostre letture, le nostre riunioni, le nostre osservazioni, diversi elementi materiali o concettuali che contribuiranno alla soluzione del nostro problema.
La cultura generale
Se inventare, è soprattutto combinare tra di loro elementi diversi, più l’individuo conoscerà più cose ed in settori di interesse diversi, più avrà la possibilità di operare delle invenzioni originali.
Certamente, il gruppo pluri-disciplinare è una forma di risposta all’impossibilità assoluta di essere un Pico della Mirandola.
Tuttavia l’idea di cultura generale, con contenuti e allo stesso tempo matrici di conoscenze, e di flessibilità mentale mi sembra debba essere difesa con tutti i mezzi.
Apprendere a lavorare in gruppo
Se, ai nostri occhi, l’atto di creazione è fondamentalmente individuale, si può essere aiutati in modo straordinario da diverse fasi di lavoro in gruppo. Ma è ben noto che, in modo generale, i latini non sanno lavorare bene in gruppo. Senza cercare le spiegazioni di questo stato di fatto, si potrebbe compiere uno sforzo per l’addestramento al lavoro in gruppo. Ovviamente questo sforzo suppone che ci si debba preoccupare anche della comunicazione emozionale.
Accendere la passione
Occorre infine, e soprattutto, suscitare il desiderio di creare. Abbiamo già citato più le esperienze del collegio di Dorsmouth: ci sembrano molto importanti, poiché non serve a nulla far apprendere alle persone di avere delle idee se non hanno voglia di averle.
Quindi, sia a livello scolastico sia a livello universitario, è urgente modificare la forma di controllo degli alunni e degli studenti, e introdurre nuovi tipi di prova di esami, perché sia riconosciuto ed incoraggiato il diritto di produrre delle idee originali.
Un’idea sottende tutto il nostro discorso, ed è un’ idea che occorre esprimere chiaramente: il cambiamento è progresso.
Il cambiamento è progresso perché, come lo ha dimostrato il filosofo Emmanuel Mounier, fondatore del Personalismo, una volta per tutte viviamo in uno stato “di disordine stabilito” tutto quello che può contribuire all’evoluzione di questo disordine verso un ordine più giusto, non può che farsi attraverso un cambiamento, un cambiamento che non può essere soltanto economico o politico, un cambiamento che deve anche essere morale.
Ed è certamente uno dei ruoli più esaltanti della creatività quello di riconciliare l’uomo con se stesso, permettendogli di trovarsi nella sua totalità psichica e somatica, di riconciliare l’uomo con il mondo e con la sua realtà rivelandogli e confermandogli l’esistenza del suo potere di trasformazione che conferma la sua specificità e la sua superiorità su tutte le macchine che si potranno inventare.
La creatività implica dialogo, democrazia, ascesi e gioia nello stesso tempo, ed è forse il mezzo per l’uomo di inventarsi inventando il mondo. In breve, la creatività riguarda tutti:
– gli esperti, uomini di azione che, in un mondo in movimento, hanno bisogno di inventare le soluzioni più economiche e più eleganti per risolvere i problemi e le nuove sfide che si pongono;
– i ricercatori il cui ruolo è di aiutarci a capire e di proporre degli schemi di interpretazione e anche dei modelli di azione;
– gli insegnanti la cui funzione è di aiutarci ad apprendere, a comprendere e a trasformarci.
È di grande speranza il constatare che il fossato che per molto tempo è esistito tra queste tre funzioni si colma, almeno per un certo numero di persone che sono allo stesso tempo esperti, ricercatori e insegnanti.
È senza alcun dubbio questa nuova generazione multi-funzionale che ci aiuterà a diventare dei veri e propri «gestori del cambiamento».
* uno dei massimi esperti nel campo della creatività applicata e della gestione dell’innovazione. Dopo un percorso che l’ha portato dalla ricerca scientifica al marketing dei nuovi prodotti, nel 1973 ha creato l’istituto Gimca. I suoi interventi riguardano il marketing, la comunicazione, la leadership, la gestione del cambiamento, lo sviluppo personale e professionale.
**di formazione umanistica, collabora con Gimca da vari anni, coordinando progetti di innovazione e tenendo sessioni di creatività applicata e seminari per aziende e istituzioni. Si occupa, dell’associazione Createca e dell’organizzazione del Festival della Creatività.

Bambini e ragazzi nel post Covid
Essere adolescenti in epoca COVID-19
Il mondo intero e la Comunità scientifica sono ormai impegnati da lungo tempo a fronteggiare l’emergenza del Covid-19. La maggior parte degli sforzi è diretta verso problemi di natura pratica, in particolare per evitare i contagi e ridurre la mortalità, in una quotidianità completamente sovvertita.
Allo stesso tempo però si cerca anche di prevedere le conseguenze di aspetti apparentemente meno eclatanti, ma i cui effetti potrebbero palesarsi a distanza.
Le misure di distanziamento sociale che di certo possono avere effetti importanti sul benessere delle persone in relazione ai contagi, potrebbero invece incidere pesantemente sui percorsi di chi, bambino o adolescente, attraverso la socializzazione, definisce se stesso e la propria identità.
Mentre per i più piccoli, i bisogni relazionali possono essere soddisfatti almeno temporaneamente dagli adulti di riferimento, per gli adolescenti, che stabiliscono relazioni più complesse con i coetanei, la deprivazione sociale può avere effetti a lungo termine sulla salute psicologica.
Gli adolescenti hanno bisogni specifici distinti da quelli infantili o dell’età adulta. In questo periodo, si sono imbattuti nella dimensione della responsabilità e sacrificio in maniera potente. Nulla è più impegnativo che togliere la libertà a una persona e noi stiamo chiedendo loro di stare “imprigionati” proprio in una fase della vita che per definizione si deve svolgere fuori, e vivere di esplorazione e di relazione.
Da un giorno all’altro, si sono visti reclusi nelle proprie abitazioni e lontani da tutto ciò che in adolescenza permette di sostenere lo sviluppo. Ovviamente è doveroso che gli adolescenti siano obbligati a restare in casa in questo momento, come è chiesto al resto della popolazione. Ma nello stesso tempo è necessario avere consapevolezza dell’impegno e del paradosso che è loro richiesto; è imposto loro di rinunciare agli strumenti (come la socialità e la scuola) e ai momenti fondamentali che servono per costruire la loro identità e porre le basi del loro futuro.
Fino a mesi fa, motivo di preoccupazione per genitori docenti ed esperti nel settore, era rappresentato dalla ridotta socialità tra i giovani, immersi nella maggior parte del loro quotidiano in un mondo virtuale, dove sentirsi a proprio agio, protetti.
In questo periodo così complesso invece, i rapporti familiari, la socialità, le relazioni lavorative, sono stati stravolti dall’emergenza, e gli strumenti di comunicazione mediata non sono più una scelta per nessuno, ma una necessità.
Siamo passati in un attimo, da ciò che è considerata una sindrome adolescenziale allarmante come l’Hikikomori, ad una situazione, seppur confinata in un determinato periodo, in cui il ritiro sociale diventa una necessità che entra a far parte della quotidianità dei giovani.
Oggi, il fenomeno dell’Hikikomori, arrivato dall’Oriente, non è più frutto di una scelta dolorosa dettata da una profonda fragilità interiore, ma dalla necessità di doversi isolare per preservare la propria salute e quella degli altri.
L’adolescenza, come sappiamo, è un periodo delicato e complesso, caratterizzato da alcuni bisogni e sfide specifiche. Tra questi il bisogno di autonomia e separazione dai genitori, al fine di costruire una propria identità, attraverso nuove relazioni al di fuori da quelle familiari.
Purtroppo, in questa sospensione del tempo e dello spazio attuali, gli adolescenti sono necessariamente confinati in spazi limitati, con un protrarsi sempre uguale delle giornate, senza che si possa sapere quando terminerà questa sospensione.
L’interazione tra i cambiamenti dello stile di vita e lo stress psicosociale causato dal confinamento in casa potrebbero avere effetti dannosi per questa fascia d’età, e instaurare un pericoloso circolo vizioso da cui potrebbe essere difficile uscire una volta terminato il lockdown.
Si consideri la situazione di molti adolescenti che, prima dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, presentavano un ritiro sociale, ragazzi e ragazze che rimanevano la maggior parte del tempo confinati nelle loro camere e che evitavano ogni forma di relazione reale privilegiando quelle virtuali. A loro era diretta la grande preoccupazione dei genitori e delle strutture scolastiche, educative, psicologiche, e lo sforzo congiunto per promuovere la socialità contrastando l’isolamento. Si è verificato poi un rovesciamento di prospettive: è necessario adesso promuovere proprio quell’isolamento e quella solitudine da cui volevamo guarirli.
Lavori pubblicati parlano di resilienza degli adolescenti durante l’epidemia Covid-19, ma la resilienza, che indica la capacità degli individui di affrontare anche le più gravi calamità attraverso un cambiamento positivo, è spesso un obiettivo da sostenere attraverso il supporto sociale, educativo, psicologico.
Quello che troveremo sarà forse un mondo molto diverso da quello che abbiamo lasciato, in cui l’obbligo a mantenere la distanza fisica e le precauzioni contro il contagio renderanno meno lineare e spontanea la socialità e le relazioni. E gli adolescenti stessi saranno usciti cambiati da questa reclusione forzata.
Stiamo chiedendo loro di fare esattamente il contrario di quello che evolutivamente sarebbero chiamati a fare. E se siamo incoraggiati a rassicurarli dicendo loro che questo tempo passerà, che la vita riprenderà non sapendo però esattamente quando, non offriamo una visione pensabile del futuro che sia veramente di sostegno alla speranza.
Per loro, però, dentro questo sacrificio c’è anche un allenamento alla vita che forse nel terzo millennio non avremmo mai immaginato di dover imporre.
Ancora una volta possiamo prendere spunto dal grande Leopardi, così attuale in questi giorni. Quel Leopardi che chiude tutto il suo percorso interiore con l’immagine della ginestra, il fiore del deserto. Mentre, ci trasmette che siamo chiamati a consolare, come dice lui, a profumare e a migliorare il deserto, fiorendo; e non possiamo prendere il deserto come alibi per non fiorire, ma prendere nel deserto proprio l’occasione, addirittura il nutrimento, per fare qualcosa di bello al mondo.
E rivolgiamo questo pensiero ai giovani in particolare, come un invito a rivalutare la prospettiva della fase che li attenderà dopo questo momento, e a considerarla la risultante di una forte rielaborazione individuale e sociale. Cambierà il nostro modo di stare al mondo, e potrebbe essere una opportunità che ognuno trasformerà in qualcosa…positiva o non.

Burn out - Definizioni e Cause
Il soggetto colpito da burn-out manifesta sintomi aspecifici (irrequietezza, senso di stanchezza ed esaurimento, apatia, nervosismo, insonnia), sintomi somatici (tachicardia, cefalee, nausea, ecc.), sintomi psicologici (depressione, bassa stima di sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, rabbia e risentimento, alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno, indifferenza, negativismo, isolamento, sensazione di immobilismo, sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento, difficoltà nelle relazioni con gli utenti, cinismo, atteggiamento colpevolizzante nei confronti degli utenti). Tale situazione di disagio molto spesso induce il soggetto ad abuso di alcool o di farmaci.
Gli effetti negativi del burnout non coinvolgono solo il singolo lavoratore ma anche l’utenza, a cui viene offerto un servizio inadeguato ed un trattamento meno umano.
Dagli studi presenti in letteratura e multifattoriale a determinare il quale concorrono: variabili individuali, fattori socio-ambientali e lavorativi.
Per l’insorgenza del burnout possono avere importanza fattori socio-organizzativi quali le aspettative connesse al ruolo, le relazioni interpersonali, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, l’organizzazione stessa del lavoro.
Inoltre sono state studiate le relazioni tra variabili anagrafiche (sesso, età, stato civile) e insorgenza del burn-out.
Tra queste l’età è quella che ha dato luogo a maggiori discussioni tra i diversi autori che si sono occupati dell’argomento. Alcuni sostengono che l’età avanzata costituisca uno dei principali fattori di rischio di burn-out mentre altri ritiene invece che i sintomi di burnout sono più frequenti nei giovani, le cui aspettative sono deluse e stroncate dalla rigidezza delle organizzazioni lavorative.
L’insorgenza della sindrome di burn-out negli operatori segue generalmente quattro fasi.
La prima fase (entusiasmo idealistico) è caratterizzata dalle motivazioni che hanno indotto gli operatori a scegliere un lavoro di tipo assistenziale: ovvero motivazioni consapevoli (migliorare il mondo e se stessi, sicurezza di impiego, svolgere un lavoro meno manuale e di maggiore prestigio) e motivazioni inconsce (desiderio di approfondire la conoscenza di sé e di esercitare una forma di potere o di controllo sugli altri); tali motivazioni sono spesso accompagnate da aspettative di “onnipotenza”, di soluzioni semplici, di successo generalizzato e immediato, di apprezzamento, di miglioramento del proprio status e altre ancora.
Nella seconda fase (stagnazione) l’operatore continua a lavorare ma si accorge che il lavoro non soddisfa del tutto i suoi bisogni. Si passa così da un superinvestimento iniziale a un graduale disimpegno.
La fase più critica del burn-out è la terza (frustrazione). Il pensiero dominante dell’operatore è di non essere più in grado di aiutare alcuno, con profonda sensazione di inutilità e di non rispondenza del servizio ai reali bisogni dell’utenza; come fattori di frustrazione aggiuntivi intervengono lo scarso apprezzamento sia da parte dei superiori che da parte degli utenti, nonché la convinzione di una inadeguata formazione per il tipo di lavoro svolto.
Il soggetto frustrato può assumere atteggiamenti aggressivi (verso se stesso o verso gli altri) e spesso mette in atto comportamenti di fuga (quali allontanamenti ingiustificati dal reparto, pause prolungate, frequenti assenze per malattia.
Il graduale disimpegno emozionale conseguente alla frustrazione, con passaggio dalla empatia alla apatia, costituisce la quarta fase, durante la quale spesso si assiste a una vera e propria morte professionale.
Oggi lavoreremo utilizzando noi stessi per prevenire i sintomi di un futuro burn-out.
Ti chiedo di riflettere sulla tua professione (ti ricordo che questa scheda la conserverai tu e potrai decidere o meno di condividere ciò che riporterai qui nel nostro gruppo, se deciderai di non condividerlo in gruppo questo NON AVRA UN SIGNIFICATO DI CHISURA VERSO IL GRUPPO!
Facciamo un passo indietro….
Cerca di recuperare il perché della tua scelta professionale: le motivazioni per le quali hai scelto di fare l’educatrice (motivazioni interne, opportunità lavorativa, sicurezza economica, riconoscibilità sociale e/o altro) e quando lo hai scelto (durante il percorso scolastico, nella prima ricerca attiva del lavoro, dopo aver rinunciato ad altri sogni lavorativi etc.)?
Rispetto ai primi tre anni di lavoro, cosa è migliorato nel tuo sentirti educatore e cosa è venuto meno, rispetto al tuo “sogno lavorativo?
Nella relazione con il partner e/o con le persone significative riesci a condividere aspetti positivi e negativi del tuo lavoro? Cosa comprende l’altro del tuo lavoro e su cosa non riesce a sintonizzarsi?
Chi e/o cosa ti aiuta a superare i momenti di apatia, noia, perdita di interesse nel tuo lavoro?
Pensando al tuo prossimo triennio lavorativo, cosa potrebbe aiutarti a viverlo con entusiasmo?
Quali condizioni potrebbero prevenire la perdita di interesse (condizione economica, maggiore riconoscimento sociale, maggiore coesione del gruppo di lavoro, progetti innovativi, nuove prospettive di lavoro, diversa organizzazione, nuova visione del progetto pedagogico e/o altro)?

Disregolazione emotiva
La sindrome del burn-out
Alcuni autori lo identificano con lo stress lavorativo specifico delle helping professions, altri affermano che il burn-out si discosta dallo stress per la depersonalizzazione, cui esso dà luogo, che è caratterizzata da un atteggiamento di indifferenza, malevolenza e di cinismo verso i destinatari della propria attività lavorativa.
Il burn-out può anche essere inteso come una strategia particolare adottata dagli operatori per contrastare la condizione di stress lavorativo determinata da uno squilibrio tra richieste/esigenze lavorative e risorse disponibili.
Comunque esso va inteso come un processo multifattoriale che riguarda sia i soggetti che la sfera organizzativa e sociale nella quale operano. Il concetto di burn-out (alla lettera essere bruciati, esauriti, scoppiati) è stato introdotto per indicare una serie di fenomeni di affaticamento, logoramento e improduttività lavorativa registrati nei lavoratori inseriti in attività professionali a carattere sociale.
Questa sindrome è stata osservata per la prima volta negli Stati Uniti in persone che svolgevano diverse professioni d’aiuto: infermieri, medici, insegnanti, assistenti sociali, poliziotti, operatori di ospedali psichiatrici, operatori per l’infanzia.
Attualmente non esiste una definizione universalmente condivisa del termine burn-out. Freudenberger è stato il primo studioso a usare il termine “burn-out” per indicare un complesso di sintomi, quali logoramento, esaurimento e depressione riscontrati in operatori sociali americani.
Successivamente Cherniss con “burn-out syndrome” definiva la risposta individuale ad una situazione lavorativa percepita come stressante e nella quale l’individuo non dispone di risorse e di strategie comportamentali o cognitive adeguate a fronteggiarla.
Secondo Maslach, il burn-out è un insieme di manifestazioni psicologiche e comportamentali che può insorgere in operatori che lavorano a contatto con la gente e che possono essere raggruppate in tre componenti: esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale.
L’esaurimento emotivo consiste nel sentimento di essere emotivamente svuotato e annullato dal proprio lavoro, per effetto di un inaridimento emotivo del rapporto con gli altri.
La personalizzazione si presenta come un atteggiamento di allontanamento e di rifiuto (risposte comportamentali negative e sgarbate) nei confronti di coloro che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il servizio o la cura.
La ridotta realizzazione personale riguarda la percezione della propria inadeguatezza al lavoro, la caduta dell’’autostima ed il sentimento di insuccesso nel proprio lavoro.
Uno dei motivi per cui spesso si sceglie di iniziare un percorso terapeutico è la difficoltà di gestione di un’emozione specifica e dei suoi riflessi a livello personale e interpersonale.
Le emozioni, infatti, hanno una funzione importante di regolazione all’interno dell’ambiente che si manifesta soprattutto nella relazione con gli altri. Cosa significa regolare le proprie emozioni?
Ed esiste un collegamento tra le nostre esperienze precoci di attaccamento a una figura di riferimento, la regolazione delle emozioni e come tendiamo a comportarci con i nostri partner e più in generale nei rapporti interpersonali?
Come sappiamo, e probabilmente come abbiamo provato più volte nell’arco di un’intera giornata, le nostre emozioni variano, sono mutevoli e dinamiche in risposta ad eventi di varia natura, compresi eventi interni come ad esempio un ricordo, un pensiero o anche un’immagine mentale.
Hanno una funzione fondamentale nell’aiutarci a conoscere e ad interagire con la realtà che ci circonda. Esse ci segnalano che è presente un cambiamento nella realtà esterna o interna che da noi è percepito come rilevante.
All’emozione si accompagna una valutazione cognitiva dello stimolo emotigeno che ci prepara all’azione attraverso un’attivazione fisiologica e corporea (ad esempio sensazioni corporee e mutamenti dell’espressione facciale). Tutto ciò si traduce in una specifica risposta comportamentale (Zorzi e Girotto, 2004).
La maggior parte degli approcci teorici sulle emozioni evidenziano come ciò che pensiamo sia interdipendente e sia parte del processo emotivo. Pertanto, la variabilità dell’esperienza emotiva è dovuta a un processo multidimensionale e complesso.
Cos’è la competenza emotiva e dove la impariamo?
La competenza emotiva è la capacità di percepire e riconoscere le emozioni, di discriminare tra di esse, di nominarle e dare loro un nome.
Questo comporta anche l’apprendimento e lo sviluppo di abilità metacognitive e di autoriflessività, la capacità sociale di riconoscimento delle emozioni altrui e l’abilità di regolazione del nostro comportamento e della manifestazione delle nostre emozioni.
Quando si manifestano problemi legati alla sfera emotiva, sono presenti difficoltà legate all’acquisizione di queste competenze che ci aiutano anche a gestire lo stress e le situazioni difficili.
Un contributo fondamentale nello sviluppo e nell’apprendimento di tale competenza sono le esperienze precoci avute durante l’infanzia, mediate dai nostri caregiver.
Per permettere ciò è necessario un ambiente che validi le nostre esperienze emotive senza negarci di provare emozioni positive e negative, riconoscendone le funzioni e le espressioni adeguate al contesto, aiutandoci a sviluppare la nostra competenza emotiva.
Disregolazione emotiva e alessitimia
La regolazione emotiva è un’abilità che ci aiuta nel rapporto con noi stessi e con gli altri perché ci permette di capire cosa stiamo provando e cosa stanno provando e sentendo gli altri.
Quando questa abilità è deficitaria si parla in psicologia clinica di alessitimia e di disregolezione emotiva. L’alessitimia è la difficoltà a identificare i sentimenti propri e altrui, a riconoscere le espressioni facciali, a descrivere le emozioni.
Consiste inoltre, nell’avere una scarsa capacità immaginativa, uno stile di pensiero orientato verso l’esterno e la tendenza alla somatizzazione delle emozioni (Taylor, Bagby & Parker, 1997).
La disregolazione emotiva è una difficoltà nell’autoregolazione dei propri stati interni e nell’espressione di tali stati emotivi in modo adeguato in risposta all’ambiente circostante.
Ciò significa che sono presenti deficit nell’utilizzo flessibile di strategie per modulare l’intensità e/o la durata dell’esperienza emotiva (Gross & John, 2004).
Quando l’ambiente di sviluppo viene definito invalidante, il bambino non apprende ad utilizzare strategie efficaci di regolazione degli stati emotivi né a tollerare emozioni difficili imparando a mettere spesso in atto strategie di evitamento e di mancata accettazione di esse prolungando di conseguenza l’esperienza emotiva negativa (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999).
In particolare la disregolazione emotiva è associata alla tendenza ad agire legata all’emozione e a uno scarso controllo degli impulsi (Linehan, 1993; Melnick & Hinshaw, 2000).
Campbel-Sills e Barlow (2007) suggeriscono che le persone con problemi di ansia e depressione impiegano delle strategie di regolazione degli stati affettivi controproducenti.
Queste azioni hanno infatti il duplice effetto di accentuare l’intensità e la frequenza delle emozioni indesiderate (regolazione delle emozioni inefficace) e di contribuire all’intensificazione e alla persistenza dell’umore negativo (regolazione dell’umore inefficace).
Più specificatamente, gli individui con disturbi d’ansia e/o depressivi, evidenziano una serie di difficoltà nel fronteggiamento dei vissuti emotivi: scarsa conoscenza delle emozioni e delle relative componenti, elevata tendenza a reagire negativamente alle esperienze emozionali e difficoltà nel recupero dalle emozioni negative (Mennin, Heimberg, Turk & Fresco, 2005).
Nei disturbi di personalità si rileva spesso la presenza di una difficoltà nella regolazione delle emozioni. Il cluster più rappresentativo di questa difficoltà è il cluster b. In particolare nel disturbo borderline di personalità è possibile rilevare numerose difficoltà nella regolazione degli stati affettivi.
I soggetti con tale disturbo sono caratterizzati da: un eccesso di esperienze emozionali avversive, l’incapacità di regolare l’intenso arousal fisiologico, la difficoltà a distogliere l’attenzione dallo stimolo emozionale, la presenza di distorsioni cognitive e di difetti nella elaborazione delle informazioni, un insufficiente controllo dei comportamenti impulsivi correlati a emozioni positive e negative, la difficoltà a coordinare ed organizzare le attività utili al raggiungimento di un obiettivo non coerente con l’umore in condizioni di forte attivazione e la tendenza a “congelare” o dissociare i vissuti emotivi in condizioni di forte stress (Linehan, Bohus & Lynch, 2007).

Disturbo antisociale e personalità
Disturbo Antisociale di Personalità
Il disturbo antisociale di personalità si caratterizza per un atteggiamento di disprezzo, inosservanza e violazione dei diritti altrui. L’inganno e la manipolazione sono le modalità comportamentali privilegiate di questo tipo di personalità. In molti casi, i comportamenti ostili e aggressivi possono comparire già durante l’infanzia e l’adolescenza. L’infanzia è di solito caratterizzata da piccoli furti, menzogne e scontri con chi rappresenta l’autorità. L’adolescenza è segnata generalmente da episodi di abuso di sostanze (marjuana, cocaina, eroina), gesti violenti nei confronti di persone e/o animali. Le persone con disturbo antisociale di personalità commettono atti illeciti, fraudolenti, tendenti allo sfruttamento e sconsiderati per profitto personale o per piacere e senza rimorso
Il disturbo antisociale di personalità è più comune tra gli uomini che tra le donne e c’è una forte componente ereditabile. La prevalenza tende a diminuire con l’età, il che suggerisce che i pazienti possano imparare nel tempo a cambiare il loro comportamento disadattivo. Gli individui con questo disturbo non riescono a conformarsi alle norme sociali per quanto riguarda il comportamento legale , sono frequentemente disonesti e manipolativi per profitto o per piacere personale e possono prendere decisioni sotto l’impulso del momento, senza riflettere e senza considerare le conseguenze per sé e per gli altri.
Tendono a essere irritabili e aggressivi mostrano una noncuranza sconsiderata della sicurezza propria o degli altri tendono anche a essere spesso estremamente irresponsabili e mostrano scarso rimorso per le conseguenze delle proprie azioni.
Si evince che, le persone che rispondono ai criteri del disturbo antisociale di personalità presentino scarso senso di colpa.
La colpa è un’emozione fortemente legata alla sfera dello scambio sociale e manifesta implicazioni morali, in quanto l’attenzione della persona si focalizza in modo specifico su un atto compiuto valutato come trasgressivo, su una valutazione delle ripercussioni che tale comportamento potrà avere sugli altri, sulle eventuali modalità con le quali riparare ai danni arrecati.
In chiave evolutiva, la colpa è stata selezionata per mantenere l’ordine sociale e la coesione del gruppo: nella cultura dove siamo immersi ci sono coordinate sociali e morali per muoversi adeguatamente all’interno del gruppo sociale, per cui il colpevole di aver trasgredito tali norme ne rischia l’esclusione.
La tendenza delle persone con disturbo antisociale di personalità a non curarsi dei bisogni dell’altro, l’atteggiamento di totale indifferenza e l’assenza di rimorso pregiudicano gravemente la nascita di relazioni personali sincere con queste persone. Gli unici rapporti sviluppati sono basati sullo sfruttamento dell’altro finalizzato al raggiungimento dei propri scopi.
Questi pazienti mancano di empatia verso gli altri e possono essere sprezzanti o indifferenti ai sentimenti, ai diritti, e alla sofferenza degli altri. Anche se talvolta, piuttosto che avere un deficit di empatia potrebbero avere scopi antisociali e quindi far uso dell’empatia per scopi immorali: lo scarso peso attribuito alla sofferenza degli altri, al pari dello scarso senso morale, sembra nascere dalla limitata importanza attribuita al rispetto degli scopi morali e al peso rilevante attribuito a scopi esplicitamente antisociali, come dominanza, vendetta.
Allo stesso tempo, molto spesso evidenziano un’accresciuta emozionalità positiva. Questo deficit nell’esperienza emozionale potrebbe addirittura essere alla base del successo spesso ottenuto dagli antisociali nel manipolare e mentire agli altri.
Così l’emozione soggettivamente esperita dall’antisociale trapela meno dall’espressione simulata dell’emozione rispetto ad altri individui, e tutto questo potrebbe rendere questi individui più convincenti e persuasivi agli occhi degli altri.
Per quanto riguarda le caratteristiche cognitive, sembrerebbe che gli schemi di base di sé, degli altri e del mondo siano piuttosto rigidi e inflessibili per questi individui.
L’antisociale vede se stesso come forte e autonomo da solo, mentre gli altri sono visti come sfruttatori e da sfruttare, deboli, vulnerabili e da predare Inoltre, i pazienti con disturbo antisociale di personalità tendono ad avere un’alta opinione di se stessi e possono essere molto supponenti, sicuri di sé, o arroganti. Essi possono essere affascinanti, volubili, e verbalmente superficiali nelle loro azioni per ottenere ciò che vogliono.

Disturbo bipolare
Dal disturbo bipolare al genio creativo
Nella letteratura: Virginia Woolf
Il Disturbo Bipolare è una patologia caratterizzata da periodi in cui sono presenti alterazioni dell’umore, delle emozioni e dei comportamenti. Le modificazioni d’umore sono contraddistinte dall’alternarsi di Episodi Maniacali ed Episodi Depressivi, da qui la definizione Bipolare. L’Episodio Maniacale si contraddistingue per esempio da felicità estrema, a volte immotivata, e da espansività non sempre giustificata nei confronti delle persone vicine.
L’Episodio Depressivo è invece caratterizzato da umore basso e/o perdita di interesse nei confronti di attività prima considerate piacevoli, frequente stato di disperazione, sensazione di vuoto, pessimismo, scoraggiamento.
Esiste poi una “fase mista”, spesso di passaggio tra la fase depressiva e quella maniacale, che è caratterizzata dalla presenza contemporanea di sintomi depressivi e maniacali.
Si parla, infatti, a questo proposito di Disturbo Ciclotimico, per delineare l’alternarsi di periodi di iperattività, creatività e spirito di iniziativa, con periodi di ipersonnia e apatia, lentezza di riflessi e difficoltà nella concentrazione. Normalmente durante queste fasi la persona intraprende progetti anche grandiosi affrontati con grande entusiasmo per poi essere abbandonati appena sopraggiunge la fase depressiva.
Nel Disturbo Ciclotimico tuttavia, i sintomi non sono quasi mai così gravi da compromettere gravemente la vita sociale e lavorativa dell’individuo. La ciclotimia è dunque una forma meno invalidante del disturbo bipolare.
Dietro l’Estro Creativo quasi costantemente esiste un mondo bipolare.
Aristotele fu forse il primo a notare questa interessante correlazione fra “follia” e creatività.
L’intuizione aristotelica che ebbe un seguito nei secoli, fin quasi a sottolineare come la genialità altro non fosse che una particolare forma di malattia mentale. Da Ernest Hemingway a Virginia Woolf, da Michelangelo a Van Gogh, alcuni talenti, dietro le cui opere si cela un mondo di alti e bassi, di infinita gioia ed infinita tristezza.
Un’altalena fra stati di iperattività e stati depressivi è ciò che caratterizza l’andamento dell’umore in coloro che soffrono di disturbo bipolare.
L’artista ha da sempre avuto un modo sui generis di distinguersi, di affrontare la vita e le persone.
E non per altro è dall’epoca di Aristotele che ci interroghiamo sui limiti esistenti tra genialità e follia. Ad oggi ciò che i dati ci dicono è che esiste un legame fra stato maniacale e creatività, legame valido solo per coloro che soffrono di forme più leggere di maniacalità.
La creatività non è una sorta di psicopatologia: tra creatività e psicopatologia esiste una correlazione, ma la presenza dell’una non determina di certo la presenza dell’altra.
Fra maniacalità e creatività c’è un legame inversamente proporzionale tale per cui, nelle forme più gravi di maniacalità, la creatività viene meno, viceversa si può osservare un estro creativo in coloro che soffrono del disturbo in forma più lieve.
Da ricerche recenti è emerso come l’apertura a nuove esperienze, l’estroversione, ed in minima parte anche quel tratto di psicoticismo, da vedersi nell’originalità dei pensieri creativi, siano tutte connesse ad una personalità creativa.
Poi bisogna tenere conto del livello di originalità dei pensieri che si riescono a produrre, un tratto che può sfociare anche in quei tratti di antisocialità che non infrequentemente si trovano nelle personalità molto creative.
Infine c’è l’estroversione, quella particolare forma di apertura verso gli altri che caratterizza soprattutto gli artisti che effettuano performance, come musicisti, cantanti e attori, mentre risulta meno presente tra coloro che lavorano essenzialmente nel proprio studio, senza avere contatti diretto con il pubblico, come scrittori, pittori e compositori.
Un altro aspetto da tenersi in considerazione riguarda l’impulsività; nel disturbo bipolare il tratto impulsivo risulta particolarmente accentuato anche nei momenti di benessere della persona.
Per quanto riguarda creatività ed impulsività inoltre si può notare come spesso nella prima vi sia un’espressione totalmente libera dei propri bisogni e dei propri impulsi.
Come se l’artista, libero da qualsiasi costrizione, potesse lasciare libera la sua espressività sotto ogni qual forma, facendo scaturire dall’arte un prodotto unico, che in altre condizioni non sarebbe stato creato.
Dietro la creatività, molto spesso, si cela un mondo fatto di poli opposti, di positivo e negativo, di entusiasmo e di apatia, un mondo che affascina e allo stesso spaventa, che Virginia Woolf descrive con queste semplici e quanto mai taglienti parole: “La bellezza del mondo, che dovrà così presto soccombere, ha due tagli, uno di gioia, l’altro d’angoscia, che ci dividono il cuore.”
Virginia Woolf soffriva di disturbo bipolare a cui sembrano essersi uniti, nell’ultimo periodo della sua vita, dei sintomi psicotici.
Nei suoi romanzi riversava il suo male di vivere e la sofferenza dell’esistenza umana e ne faceva arte letteraria, in questo modo l’atto di scrivere risultava anche una terapia per la scrittrice, un modo per evadere dal suo malessere interiore e farlo fuoriuscire trasformandolo in parole scritte, in arte.
Sicuramente i disturbi mentali della scrittrice hanno influenzato non solo la sua vita ma anche la sua arte. Il monologo interiore in particolare, da cui fuoriesce il flusso di coscienza dei personaggi è una tecnica distintiva e utilizzata assai spesso dalla Woolf in tutti i suoi romanzi.

Disturbo di panico e coronavirus
Il Disturbo di Panico o Attacco di Panico è caratterizzato da un’acuta e intensa reazione d’ansia, che coinvolge mente e corpo attraverso una rapidissima sequenza di reazioni fisiche ed emotive.
Le crisi di panico iniziano in modo brusco e giungono alla loro massima espressione rapidamente.
Gli individui che le sperimentano, si trovano al cospetto di una paura intensa e sperimentano condizioni quali: “avere un infarto”; “perdere il controllo”; “impazzire” o addirittura “essere sul punto di morire”.
Tutto ciò genera, in chi ne è colpito, un desiderio molto forte di abbandonare il luogo in cui si sta manifestando l’attacco.
Le sensazioni sperimentate durante un attacco di panico sono così spiacevoli, da indurre nel soggetto il timore di riprovarle, per cui si sviluppa la “paura della paura”.
E così si viene trascinati all’interno di un circolo vizioso, in cui la paura diventa patologica e si nutre di sé stessa.
In alcuni individui gli attacchi di panico sono così frequenti, che tendono a compromettere gravemente la qualità della vita.
La persona tenderà quindi a mettere in atto comportamenti di evitamento delle situazioni o ancor più comportamenti protettivi, fino a richiedere la presenza rassicurante di un’altra persona.
Proprio per i suoi aspetti legati al bisogno di avere delle persone o dei luoghi “rassicuranti”, il disturbo di attacchi di panico si può correlare all’ attaccamento.
Secondo la Teoria dell’Attaccamento, infatti, ogni individuo che si trova in una situazione di pericolo tende a ricercare la vicinanza protettiva di un altro membro del proprio gruppo di appartenenza.
Questa condizione di sofferenza, generata dall’insorgere di questi stati, quasi sempre contribuisce a compromettere i rapporti interpersonali e, con la tendenza ad un ritiro dalla vita sociale, genera stati depressivi.
Nella situazione che stiamo vivendo attualmente, dove non tutti stanno rispondendo allo stesso modo al superamento dell’infezione da Covid-19, una delle espressioni comportamentali diffuse, potrebbe essere proprio lo sviluppo di una eccessiva preoccupazione, fino a sconfinare in panico da Coronavirus.
Avere paura ed essere preoccupati a causa di questa emergenza è comprensibile, ma è importante che la paura sia solo un campanello d’allarme e non la causa principale delle nostre ansie. Al fine di aiutarci a reagire in modo razionale e non a farci adottare comportamenti dettati dal panico.
Per cercare di reagire in modo appropriato rispetto a questa situazione attuale, sarebbe opportuno evitare una informazione eccessiva, ma privilegiare un aggiornamento equilibrato fornito da fonti ufficiali.
E, di conseguenza, cercare di condurre una vita normale, caratterizzata se possibile da attività rilassanti e che possano stimolare il nostro interesse, pur nel rispetto delle indicazioni e delle precauzioni consigliate.
La Terapia Cognitivo Comportamentale rappresenta l’intervento che ha dimostrato maggiore efficacia nel trattamento del Disturbo da Attacchi di Panico e potrebbe essere impiegata verso la psicosi di massa creata dal Coronavirus.
Infatti, nella condizione attuale sono diversi i meccanismi di pensiero che alterano la percezione della minaccia del virus.
Il modello cognitivo afferma che non è la situazione in sé a spaventare le persone coinvolte, ma il modo in cui esse interpretano quella determinata situazione.
Solitamente il trattamento comprende:
– Una prima fase di informazione sulle cause del problema e su tutti i fattori che lo mantengono (evitamento e comportamenti protettivi).
– Una seconda fase in cui vengono insegnate tecniche di respirazione diaframmatica e rilassamento muscolare progressivo, per gestire i sintomi del panico.
– Una terza fase che comprende interventi di esposizione graduale alle situazioni temute.
Successivamente vengono apprese tecniche per individuare e modificare i pensieri negativi responsabili dello scatenarsi dell’attacco.

Contamizazione Coronavirus
La paura del futuro
Chi sperimenta la paura del futuro inevitabilmente si ritrova ad avere un pensiero fortemente catastrofico, a dover mettere da parte i progetti e a preoccuparsi e aver paura più del previsto che questi possano essere interrotti a causa di imprevisti o errori personali.
L’effetto coronavirus sulle domande emotive che generano dubbi
Aumentano le domande emotive che spesso nascono nella mente di chi tende a preoccuparsi del futuro, alla ricerca di risposte certe che mai potrà dare. Il futuro, infatti, più che mai in questo periodo è ancor più incerto e viene percepita inevitabilmente una maggiore ansia di fronte a un pericolo di restare senza lavoro o di non farcela. Non si sa quando passerà tutto. Se si potrà tornare a lavoro a breve o più in là.
Stando chiusi in casa verranno infatti domande del tipo: “Starò male domani? Perderò il lavoro? Mi verrà l’ansia? Andrà bene l’esame? Mi potrò laureare?“.
Come potenziare le difese in questo periodo
Per lavorare sulla paura del futuro, approfittando del momento, il suggerimento consiste nel cercare di stare nel presente, interrompendo la catena di creazione dei dubbi. Per fare ciò è importante allenarsi a stare sul presente.
Se ci pensi bene, prima di essere catapultato/a in questo momento, sicuramente stavi applicando la solita strategia disfunzionale, ovvero controllare tutto per evitare gli imprevisti e mandare all’aria qualcosa a cui veramente tenevi.
Ti saresti mai aspettato/a che un virus avrebbe creato una tale e totale interruzione? Bene, così funziona la vita e prima interiorizzerai la capacità di stare sul presente, prima imparerai a vivere meglio (leggi le strategie per affrontare la paura del futuro).
Dipendenze da internet in adolescenza
In genere si parla di dipendenza quando si supera il limite di utilizzo di una sostanza come ad esempio alcool, droghe, ecc. fino al punto di non poterne più fare a meno.
Nel caso della rete, invece, si parla di “dipendenza senza sostanza”, in quanto si è dipendenti da un comportamento ripetuto nel tempo che genera gli stessi effetti di una tossicodipendenza generata dall’uso di droga (leggi se soffri di dipendenza da internet).
L’effetto coronavirus su chi soffre di dipendenze
La quarantena forzata ha avuto come effetto che molti adolescenti si ritrovano a stare chiusi in casa e non poter uscire rischiando di accrescere l’utilizzo compulsivo della rete.
Questo può avvenire specificatamente ad un’area (social network, materiale erotico, giochi online, azzardo, ecc.) o in modo più generalizzato che si manifesta occupando le proprie giornate stando “attaccati” al monitor e girando per ore ed ore, senza sapere dove andare o controllando tutto ciò che si “possiede” su internet (e-mail, contatti di chat, siti personali, profili, ecc.).
Come potenziare le difese in questo periodo
Se sei deciso/a a prendere di petto il problema e vuoi riprendere in mano la tua vita, questo è il momento migliore per farlo e sai perché? Non hai l’obbligo di dover fare altro, fuori dal mondo virtuale.
E’ infatti quello da cui fuggi, che spesso ti porta a rinchiuderti in questo mondo parallelo.
A questo punto ti suggerisco di porti le seguenti domande:
1. Se non avessi questo problema di dipendenza, con quale altro problema più grave mi dovrei confrontare? La risposta a questa domanda, ti servirà a capire ciò su cui devi mettere la testa per iniziare a rendere la tua vita migliore di prima.
2. Se ad un certo punto non avessi improvvisamente più la connessione che funziona e tutto ciò che le ruota attorno, cosa mi darebbe così tanto piacere stando qui in casa? Anche qui, la risposta ti aiuterà a trovare dei piaceri alternativi su cui puoi mettere la testa. Vedrai, che quando ti occuperai in questi, dimenticherai il resto.
Chi vive con un narcisista perverso
La relazione con un narcisista perverso, spesso è molto travagliata, perché questa persona fatica a provare emozioni.
Questo perché è una persona fredda, ossessiva e apparentemente anaffettiva. Così, superata la prima fase del love bombing (strategia manipolatoria dove chi la mette in pratica prima fa sentire il proprio partner come la persona più amata al mondo, per poi, una volta consolidata la relazione, gettare via la maschera e rivelarsi invece come il più subdolo dei manipolatori) e quella dove il narcisista a livello sociale agisce per isolare il partner dalla sua famiglia, dai suoi amici, dal lavoro, entra nella fase della distruzione dell’altro.
Questa è la fase in cui il narcisista perverso mostra la sua vera personalità, utilizzando violenza verbale e fisica.
A livello verbale alterna momenti di dolcezza a momenti di aggressività e sono proprio queste oscillazioni a rendere ancora più dipendente la partner, la quale si destabilizza e non sa più come comportarsi, esita a perdonarlo e poi lo perdona pensando che cambierà. Attraverso i maltrattamenti la partner si paralizza, perde le sue capacità.
L’effetto coronavirus sulla relazione con un narcisista
Chi è vittima di abuso narcisistico, costretto a stare chiuso in casa con il partner narcisista, senza poter uscire e “staccare” a causa del coronavirus, rischia di sviluppare sintomi destabilizzanti (tristezza e disperazione; ansia e agitazione; senso di isolamento e disconnessione con il mondo esterno; repentini sbalzi umorali, irritabilità, rabbia, forte senso di vergogna, autoaccusa e colpa) che possono portare a forme di depressione (leggi come riconoscere se stai subendo un abuso narcisistico).
Come potenziare le difese in questo periodo
Di sicuro in casi come questi, la convivenza forzata diventa più difficile del solito. Per questo, quando senti di non farcela più, il suggerimento è quello di provare a chiedere aiuto ad uno psicologo psicoterapeuta.
Proprio per questi casi di emergenza sono stati attivati dei servizi di consulenza psicologica online, che è possibile ricevere anche da casa. Io personalmente fornisco consulenza psicologica e psicoterapia online o un servizio utile è quello attivato dal Servizio Italiano di Psicologia Online, mediante lo Sportello Psicologico Coronavirus.
Chi soffre di disturbi alimentari
Disturbi alimentari come anoressia, bulimia, binge-eating vivono il rapporto con la società in modo ambivalente.
Da una parte ricercano l’apprezzamento degli altri, dall’altro ne temono il giudizio perché va a toccare la loro insicurezza sul piano fisico e dell’autostima.
Per rimanere dentro un equilibrio, seppur precario, chi soffre di un disturbo alimentare si trova costretta a seguire regole che vanno dall’estrema rigidità nel cibo e nel movimento e alla completa perdita del controllo.
L’effetto coronavirus sui disturbi alimentari
Il coronavirus ha avuto un effetto negativo su gran parte di tali disturbi, in quanto, costrette a rimanere in casa, sono venute a mancare diverse abitudini pre esistenti, come il movimento, la palestra, aumentano le abbuffate, perché stando a casa aumentano le occasioni per cedere alle tentazioni del cibo e questo genera forti sensi di colpa.
Come potenziare le difese in questo periodo
Imparare a mangiare consapevolmente, in questo periodo di quarantena, può rappresentare un’occasione per imparare a gestire i principali disturbi alimentari. In questo senso la tecnica della Mindful Eating può facilitare il processo di consapevolezza legato al cibo, insegnando a chi ha problemi con il cibo, a prestare la massima attenzione, sia dentro di sé che all’esterno.
Ci si focalizza sui colori, sugli odori, le consistenze, i sapori, la temperatura ed anche i suoni del cibo e delle bibite che ci apprestiamo a gustare.
Con la Mindful Eating si presta attenzione anche all’esperienza del corpo: in quale parte del corpo sento appetito? Quando e in che modo ci sentiamo soddisfatti e sazi? Che cosa significa sentirsi mezzi pieni o sazi? (scopri come superare i problemi di cibo con la Mindful Eating Online).
Chi ha la paura di perdere i propri cari
In chi tende ad esasperare questo atteggiamento apprensivo nei confronti delle persone con cui entra in relazione, lo schema dominante è quello dell’abbandono affettivo.
Uno schema che genera nella persona che lo applica un’inadeguatezza relazionale fortemente limitante: il pensiero della potenziale situazione di pericolo, che può generare la morte dei propri cari e la paura di restare soli, senza legami affettivi e privo di qualcuno che si occupi di loro, può fare catapultare tale soggetto in un triste futuro in cui dovrà affrontare in solitudine tutte le diverse prove della vita.
L’effetto coronavirus su chi ha paura di perdere i cari
Il pensiero che chi amiamo possa contrarre il coronavirus, in questo particolare periodo può attraversare la mente di chiunque, in special modo di chi in genere soffre di questo problema, e riportare inevitabilmente alla luce la paura e il pensiero della propria morte o delle persone care.
Specialmente in chi ha parenti a rischio, aumenta l’ansia e la preoccupazione. Inevitabilmente le profezie catastrofiche si intensificano
Come potenziare le difese in questo periodo.
In questi casi è utile provare a ritagliarsi uno spazio giornaliero, ad esempio la mattina, per immaginare volontariamente le cose peggiori che potrebbero accadere.
Il suggerimento è quello di puntarsi una sveglia con un tempo di 30 minuti, finiti i quali, provare a concentrarsi sul resto e spostando a questo spazio, il pensiero quando arriva. Questo aiuterà a trovare la concentrazione per dedicarvi ad altro.

La bellezza
La bellezza è un esperienza assolutamente soggettiva che esprime una relazione tra un oggetto e un soggetto dotato di sensi e capacità di intelletto. Se la realtà oggettiva esiste anche senza un testimone umano, non altrettanto si può affermare della bellezza: senza una mente che la coglie non c’è bellezza.
Ci appare bello ciò che ci sembra in grado di poter soddisfare un nostro bisogno o scopo. In questo modo si spiega la diversità individuale, storica e culturale del giudizio di “bello”.
Se alcune cose appaiono belle quasi a tutti e ci fanno pensare all’esistenza di una bellezza oggettiva è semplicemente perché apparteniamo tutti alla specie umana e condividiamo un’ampia parte dei nostri scopi, primi fra tutti quelli inerenti la sopravvivenza.
Seguendo questa prospettiva di equilibrio tra universalità ed individualità si potrebbero elencare una serie di bisogni comuni degli esseri umani, fisici e psicologici, che si personalizzano in ogni individuo e per ciascuno di essi immaginare un certo tipo di bellezza, consistente nell’aspettativa che la relazione con quell’oggetto possa portare alla soddisfazione di quel bisogno.
Già secondo Freud, la bellezza ha il compito di tenere l’apparato psichico in uno stato di costante contenuta eccitazione. Prima che effettivamente lo faccia: la bellezza è l’anticipazione, la promessa, l’aspettativa di un soddisfacimento.
La bellezza, ci fa intuire la possibilità dell’appagamento di un desiderio o di un bisogno profondo senza che questo avvenga veramente.
Percepire una bellezza equivale ad avvertire una mancanza e la possibilità di colmarla.
I canoni di bellezza vantano una duplice origine biologico/ereditaria e culturale.
Questi ultimi sono certamente più universali e prioritari sopratutto per quanto riguarda la bellezza fisica e la connessa appetibilità sessuale a scopo riproduttivo.
Pur privilegiando in queste riflessioni un approccio soggettivistico e relazionale al tema del bello è doveroso darne una definizione quanto più possibile oggettiva.
E riferiamoci alla varietà del bello, opposta all’uguaglianza e alla monotonia e ciò forse in relazione al fatto che tutti i nostri organi di senso apprezzano sopratutto le differenze, i cambiamenti, le discontinuità.
O la regolarità, che mitiga la varietà stessa e trasmette il rassicurante senso di prevedibilità e familiarità, tanto caro soprattutto ai bambini. E la semplicità, che consente di afferrare tutto l’oggetto con un solo atto percettivo.
Fino alla grandezza, come quantità e abbondanza, che talvolta si immerge, in particolare per quanto riguarda la bellezza femminile nella tensione armonica tra gli opposti.
E proprio come come già sosteneva Eraclito: “se esistono nell’universo degli opposti, delle realtà che paiono non conciliarsi, come l’unità e la molteplicità, l’amore e l’odio, la pace e la guerra, la calma e il movimento, l’armonia tra questi opposti non si realizzerà annullando uno di essi, ma proprio lasciando vivere entrambi in una tensione continua. L’armonia non è assenza bensì equilibrio di contrasti”.
A noi come individui e come specie in fondo il senso della bellezza, consistendo in una valutazione spontanea immediata e complessiva della positività di qualcosa è la strada maestra verso la vita.
Ai giovani potremmo dire “seguite la bellezza” e vivrete a lungo felici…

La fluidità sessuale
LA FLUIDITÀ SESSUALE O SESSUALITÀ FLUIDA
Nel corso dell’ultimo decennio, il rapido e dinamico mutamento sociale che ha permesso di vivere più liberamente la propria identità, ha portato ad analizzare più attentamente quanto la rigidità dei confini previsti dalle categorie identitarie codificate dall’orientamento sessuale riuscisse ancora oggi a rappresentare adeguatamente il modo di percepire il nostro “essere sessuali”.
Da qui abbiamo iniziato a conoscere espressioni come fluidità sessuale o sessualità fluida, usate dai media per esprimere quasi un fenomeno nuovo, che invece in realtà rappresenta semplicemente un modo più flessibile e aperto di vivere ed esprimere la propria sessualità.
In realtà, la fluidità sessuale è un concetto che scientificamente ha un’altra definizione e che ci riguarda tutti in quanto essere umani.
La sessualità fluida non si limita unicamente ad un’espressione fluttuante dell’identità di orientamento sessuale di una persona nel corso della sua vita, ma viene estesa all’intero concetto di identità sessuale, composta da cinque diversi elementi: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere, orientamento sessuale e orientamento affettivo.
In particolare, soprattutto in questi ultimi tempi, in cui la sessualità si sta sempre più liberando dei tabù e delle limitazioni del passato, sono più frequenti i “cambi di orientamento sessuale”, soprattutto tra i giovani adolescenti.
Nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza, infatti, è innegabile la propensione verso l’esplorazione, anche dovuta a una sempre maggiore indipendenza.
Durante tale momento evolutivo, è importante per l’individuo poter esprimere le proprie preferenze, i propri gusti, entrando in conflitto con quelli dell’altro e riuscendo a integrare le differenze.
Gli adolescenti, nel passaggio dall’infanzia all’età adulta non si identificano ancora in una categoria, la loro identità è in formazione continua, quindi è plausibile che cerchino di sperimentare e fare esperienza di tutto ciò che possono, compresa anche la sessualità.
L’identità non è una proprietà data dalla nascita, ma è un processo in continuo divenire, il quale tende all’instaurarsi di una stabilità relativa alla coerenza tra la percezione di sé e le diverse componenti sopra elencate, capace di rendere una persona ciò che è.
Il fulcro della nostra idea di sessualità fluida si riferisce proprio alla possibilità che ognuno sperimenti la bellezza di trovarsi, in quanto essere unico, senza doversi riferire necessariamente alle prospettiche categorie pre-esistenti alle quali dover accedere per potersi definire.
La sessualità fluida potrebbe finalmente permettere di andare oltre a questa facilissima, ma limitante, visione categoriale dell’identità sessuale, consentendo a chiunque di esplorare se stesso coraggiosamente e costruire un’identità su misura, nella quale sentirsi a proprio agio, ed essere libero di potersi esprimere.
In sostanza, dal punto di vista scientifico, la fluidità è una caratteristica della sessualità umana in quanto tale. Non è detto però che tutti ne facciano esperienza: qualcuno potrà sperimentarla e concretizzarla, mentre qualcun altro non la vivrà mai.
La fluidità sessuale è qualcosa che si manifesta in presenza di situazioni contingenti e che è stata osservata e studiata in precisi contesti, dove verosimilmente era più facile appunto osservarla e circoscriverne le caratteristiche.
Alcuni di questi contesti sono ad esempio l’ambiente carcerario e quello militare: in questi casi si è osservato che persone eterosessuali sono in grado di provare attrazione nei confronti di persone del proprio stesso genere in quella specifica situazione.
E’ quindi possibile che, se quelle stesse persone non si fossero mai trovate in quella specifica situazione, forse non si sarebbero mai accorte di possedere questa capacità.
Ma non è necessario che la situazione contingente sia imposta o molto strutturata, come negli esempi appena fatti: è possibile infatti che una persona provi attrazione sessuale per un’altra anche semplicemente grazie ad un contesto particolarmente favorevole, ad esempio un incontro fortuito in un determinato luogo o circostanza o in un particolare momento della vita.
La fluidità sessuale non è un orientamento che si aggiunge agli altri: le persone non sono, ad esempio, etero, gay o “fluide”.
Il motivo è quello che abbiamo detto prima: la fluidità sessuale è una caratteristica trasversale e comune a tutti gli esseri umani, mentre l’orientamento è una componente che definisce la nostra identità, che è tendenzialmente stabile nel tempo ma non immutabile.
La fluidità, inoltre, non modifica l’identità sessuale: il nostro essere sessualmente flessibili, non modifica la nostra personale concezione di chi siamo e cosa ci rende noi stessi.
Essere “fluidi” non significa che la nostra identità cambi in continuazione oppure che non ne abbiamo una, significa semplicemente che abbiamo la naturale capacità di provare attrazione per tutti i generi, che questa attrazione si può manifestare in alcune circostanze della vita e che, se vogliamo, possiamo anche concretizzarla con comportamenti coerenti con quello che sentiamo.
Quindi la fluidità sessuale è determinata dalle esperienze che un individuo ha vissuto o che potrebbe vivere: una persona potrebbe non farne mai esperienza, come un’altra potrebbe sperimentarla molto precocemente o durante l’età adulta e così via.
Il fulcro del concetto di sessualità fluida si riferisce proprio alla possibilità che ognuno sperimenti la bellezza di trovarsi, in quanto essere unico, senza doversi riferire necessariamente alle categorie pre-esistenti alle quali dover accedere per potersi definire.
In quanto caratteristica della sessualità umana, possiamo ipotizzare che le persone siano sessualmente fluide da sempre: quello che è cambiato è l’attenzione verso la sessualità e le sue forme di espressione.

Le 7 emozioni primarie
LE 7 EMOZIONI PRIMARIE: guardarci in volto per sopravvivere insieme
Di Emanuele Botta
Quante volte vi è capitato di stupirvi del riuscire a capire come si sentiva una persona al primo sguardo? Quante volte vi è capitato che venisse fatto altrettanto con voi ad esempio, talvolta anche provando quella strana sensazione di sentirsi in qualche modo scoperti, messi a nudo, anche senza che ci fosse una conoscenza precedente o comunque intima con quella persona?
Avete mai girato lo sguardo altrove per la paura di ciò che avreste potuto vedere sul volto di chi avete davanti? O avete mai cercato lo sguardo di qualcuno nella speranza che cogliesse il vostro e reagisse di conseguenza capendovi al volo?
Tutti questi nostri comportamenti indicano che, oltre le parole, sul nostro viso e con il nostro viso trasmettiamo delle informazioni che sembrano avere davvero molto potere all’interno del nostro mondo relazionale. Ma di che informazioni si tratta? Soprattutto come mai siamo capaci di leggerle o generarle in modo spontaneo e naturale?
Era il 1967 quando un giovane ricercatore psicologo americano di nome Paul Ekman, nel tentativo di rispondere a queste domande, si recò per la prima volta sull’isola di Papua Nuova Guinea, nelle South East Highlands, per studiare una tribù indigena ferma ad uno stadio di sviluppo di livello paleolitico (circa 2 milioni e mezzo di anni fa): i Fore.
All’epoca e ancora oggi esistevano diversi modelli di lettura del linguaggio delle emozioni espresse nell’uomo, di cui due in particolare contrapposizione:
• un modello detto “evoluzionista”, creato originariamente da Charles Darwin a metà del 1800 e sostenuto all’epoca di Ekman da psicologi quali S.S. Tomkins, che afferma che il linguaggio non verbale delle emozioni è uniforme per la specie umana (e ha similarità anche con altre specie animali come scimmie, cani e gatti) poiché si è evoluto con noi e ci ha aiutato a sopravvivere;
• un modello detto “culturale”, come sosteneva ad esempio una famosa antropologa dell’epoca di nome Margaret Mead che afferma al contrario che il linguaggio non verbale è interamente acquisito dalla cultura di appartenenza in cui viviamo, e quindi sempre differente. L’obiettivo con cui Ekman si recò presso i Fore era il seguente: dimostrare che il modello culturale era quello corretto.
Per dimostrare questa tesi serviva osservare un gruppo di esseri umani che non fosse venuto in contatto con alcuna forma di cultura occidentalizzata, altrimenti alcuni gesti o modi di esprimersi potevano essere stati involontariamente acquisiti e poteva essere avvenuta una sorta di “contaminazione culturale”.
Partendo da questi presupposti, ci si aspettava dunque di trovare nei Fore una serie di comportamenti non verbali peculiari non riscontrabili in altre culture, o anche nessun “segno non verbale” simile o avente significato simile a quelli già riscontrati ad esempio nella cultura di provenienza di Ekman.
La scoperta con cui Ekman tornò a casa lo sconvolse profondamente poichè rimise in discussione l’intera ipotesi di partenza con cui aveva avviato la ricerca. Alcune espressioni facciali legate a situazioni che rievocavano precise emozioni, risultavano essere le stesse individuate in soggetti occidentali. Nel 1969 Ekman vi tornò con un team di ricercatori tra cui il compagno di molte scoperte Wally Friesen per definire e classificare ulteriormente quanto rilevato.
Ciò che ne emerse da successivi approfondimenti fu la seguente scoperta: esistono 7 emozioni primarie, anche dette “universali”, che vengono espresse con le medesime espressioni facciali in tutti i soggetti osservati nei molteplici studi coinvolgenti culture di tutto il mondo, inclusa la tribù primitiva dei Fore.
Queste 7 emozioni sono: felicità, rabbia, paura, tristezza, disprezzo, disgusto e sorpresa.
La ragione di questo fenomeno risiede nelle radici del DNA che tutti noi, in quanto appartenenti alla specie umana, condividiamo con il nostro prossimo di qualunque etnia o nazionalità egli sia.
Molte ricerche sull’epigenetica (branca della biologia molecolare che studia le mutazioni genetiche e la trasmissione di caratteri ereditari non riscontrati nel DNA “originale”) hanno dimostrato come determinati comportamenti, se ripetuti nel tempo molto a lungo (centinaia di anni se non migliaia) e funzionali alla sopravvivenza dell’individuo, si codifichino all’interno del nostro DNA arrivando a costituire una sorta di bagaglio di conoscenza innato che si possiede senza bisogno di apprenderlo nuovamente; questo ad un livello basilare naturalmente, poi coltivare e raffinare queste abilità spetta a noi.
Il fatto che questo sia avvenuto nell’uomo con le emozioni e le espressioni facciali cosa ci dice? Semplicemente che l’essere umano, per poter sopravvivere e divenire la specie dominante su questo pianeta, ha avuto bisogno di unirsi costantemente in “branchi”. Era fondamentale poter comunicare l’uno con l’altro attraverso segnali essenziali che permettessero di potersi relazionare a prescindere dal linguaggio verbale, ancora non codificato come lo conosciamo oggi, e primordialmente per lo più composto di suoni e versi.
Vedere e riconoscere che chi avevamo accanto era triste ci permetteva di capire che aveva bisogno di vicinanza, che c’era stata una perdita di qualcosa, forse un “cucciolo d’uomo” che andava cercato. Mostrare paura a chi avevamo accanto e vederla riconosciuta, ci permetteva di segnalare la presenza di un pericolo e ricevere aiuto. Riconoscere felicità nell’altro ci permetteva di comunicare che qualcosa che stava avvenendo era positivo, o che eravamo predisposti ad accogliere e avvicinarci riducendo il rischio di conflitti e consolidando le unioni tra i membri del gruppo e quindi la forza del gruppo stesso.
Senza queste emozioni primarie e questa capacità di esprimerle e riconoscerle universalmente l’uomo, isolato dai suoi simili e fisicamente inferiore agli altri animali, probabilmente oggi sarebbe estinto.
Questa scoperta non solo è stata rivoluzionaria per le scienze comportamentali per evidenti ragioni tecniche di lettura e comprensione dell’essere umano e della sua natura, ma anche perché ha portato tutti i membri della specie umana sullo stesso piano di esistenza, superando barriere razziali e culturali.
Questo effetto è analogo a quello di cui parlava Totò nella sua poesia “ ’A Livella ”, in cui la morte era quell’unico elemento che, quando arrivava, poneva ogni essere umano alla stessa altezza, ignorando lo stato sociale, la razza, la cultura o la ricchezza accumulata nel tempo.
Le emozioni universali rappresentano allo stesso modo una livella, ma una livella che è vita: pongono ogni essere umano al pari del suo prossimo e ci rendono essenziali l’uno all’altro ricordandoci ancora oggi questa necessità.
Questo legame unico e antico busserà alla nostra porta ogni qual volta sentiremo di dover voltare lo sguardo da un’altra parte per evitare di confrontarci con il vissuto di chi abbiamo davanti: dentro di noi sappiamo che, se ci guardassimo in volto, alcune informazioni non potrebbero fare a meno di entrare e colpirci. Queste informazioni si chiamano emozioni e, per quanto le stiamo conoscendo sempre di più, siamo purtroppo sempre meno capaci di gestirle e tollerarle.

Legame attaccamento e ripercussioni nella vita adulta
Il termine attaccamento in psicologia fa riferimento a tutti i legami che si sviluppano nell’infanzia con i genitori o con chi si prende cura del bambino.
Questo sistema comportamentale è presente per tutta la vita, è innato e regola la modalità con la quale, anche da adulti, saranno gestite le emozioni di paura e sofferenza.
Ogni individuo svilupperà pertanto il proprio e personale sistema di attaccamento modulato dalla relazione con la madre, diverso a seconda della tipologia di risposta della madre alle esigenze del figlio. Le differenti strategie sviluppate corrispondono ai diversi stili di attaccamento: sicuro; insicuro evitante; insicuro ansioso – ambivalente; disorientato/disorganizzato.
Un attaccamento sicuro implica un maggior adattamento all’ambiente mentre modelli disfunzionali dell’attaccamento (attaccamento insicuro-evitante, attaccamento insicuro-resistente, attaccamento disorganizzato) o, modelli atipici, rendono difficile l’adattamento psicosociale.
La qualità della relazione di attaccamento condiziona le modalità di regolazione delle emozioni e le capacità sociali.
Ciò permette di comprendere l’importanza che le relazioni di attaccamento hanno nella costruzione e nello sviluppo della nostra mente.
È così che, all’interno della dimensione relazionale, partendo dalle memorie che abbiamo sulle nostre relazioni reali con le figure di attaccamento, si costruiscono lo schema di sé e dell’altro, le rappresentazioni e le aspettative delle relazioni interpersonali in vari contesti.
Ognuno di noi mette in atto delle strategie nello stare con gli altri in base al contesto relazionale (bisogno di cura, contesto di sfida, ecc.), in base a come supponiamo che gli altri si relazioneranno con noi (disponibili, rifiutanti, leali, ecc.) e a come pensiamo di essere (autonomi, vulnerabili, non amabili, ecc.).
L’abilità di creare e mantenere relazioni emotivamente stabili è favorito da un attaccamento sicuro che implica una maggiore consapevolezza degli stati mentali degli altri.
Purtroppo, però, non tutti da bambini sperimentano un attaccamento sicuro, caratterizzato da amore, sicurezza e genitori che offrono protezione.
I bambini con una marcata compromissione nell’attaccamento spesso diventano impulsivi, oppositivi, mancano di coscienza ed empatia, sono incapaci di dare e ricevere affetto e amore, esprimendo, quindi, rabbia, aggressività e violenza.
Gli schemi interpersonali che si sono sviluppati da stili di attaccamento insicuro nella vita adulta limiteranno la vita relazionale.
Essi infatti renderanno più probabile la costruzione di un sistema cognitivo-affettivo povero e rigido, oppure talmente incoerente e non integrato da favorire la costruzione in età adulta di cicli interpersonali disfunzionali.
Quindi, anche se il disturbo dell’attaccamento si presenta durante l’età dello sviluppo, ha ripercussioni nella vita adulta dell’individuo. Per questo motivo è importante identificarlo e correggere i comportamenti disfunzionali.
L’anello che congiunge l’attaccamento in età infantile con l’adulto ed eventuali sue patologie riguarda i Modelli Operativi Interni (MOI). I MOI sono delle rappresentazioni che il bambino costruisce, sulla base della sua esperienza, su di sé, sull’altro e su come si gestisce una relazione.
Diventa chiaro quindi che ciò che viene sperimentato da bambini costituisce il punto di partenza per comportamenti futuri e per creare le proprie aspettative.
Chi è sicuro, chiederà conforto e modulerà la propria vicinanza all’altro in un rapporto sano. Coloro che hanno un attaccamento insicuro o ambivalente è possibile che evitino rapporti profondi per paura di essere delusi o di soffrire.

Narcisismo patologico e relazioni sentimentali
Narcisismo patologico e relazioni sentimentali
La scarsa empatia del narcisista patologico, diventa centrale nelle relazioni, soprattutto sentimentali. Dall’esterno la persona con elevati livelli di narcisismo sembra “la persona ideale”, quella che tutti sognano, inserita molto bene a livello sociale e professionale.
Solitamente è abile nell’apparire per quello che non è, prima forma di manipolazione che mette in atto. E’ spesso molto dotato a livello intellettuale e appare molto sicuro di sé, anche se ha bisogno di nutrire costantemente la propria autostima. In realtà, infatti, il mondo interiore del narcisista è caratterizzato da un grande vuoto, gli sono spesso mancate le gratificazioni da parte della madre.
Chi soffre di narcisismo patologico ha subito dei traumi nelle relazioni di attaccamento, non è stato protetto, né gli sono state fornite delle regole (è stato spesso un bambino che ha dovuto diventare adulto molto velocemente, almeno nel contesto familiare).
Una volta divenuto adulto, deve tenere sotto controllo gli altri, il mondo che lo circonda. Quando predomina il narcisismo patologico l’altro non esiste, e tutti i tentativi che il partner farà per cercare di cambiare la persona saranno inutili. Il narcisista è infatti insensibile alla sofferenza altrui, non è empatico e non sa provare sentimenti, anche se fa di tutto per apparire una persona sensibile ed empatica.
Le fasi della relazione con i narcisisti
In particolare, si possono identificare tre fasi nella relazione con il partner:
Fase 1 – Seduzione
Colui che presenta alti livelli di narcisismo mostra il meglio di sé. In questo momento, presta molta attenzione a mostrare un falso sé, mentendo, recitando una specie di ruolo. L’obiettivo è che l’altro si innamori e si occupi di lui.
All’inizio, pertanto, mostra un lato vulnerabile di sé, provando ad attivare il senso di accudimento nel partner. Raccontando spesso un’infanzia infelice, evoca nell’altro il desiderio di farlo felice a tutti i costi, cambiandosi, modificandosi per andare incontro alle sue aspettative, entrando così nel circuito della sfida. Il partner è convinto di riuscire a soddisfarlo e di poterlo cambiare.
Fase 2 – Intromissione
I due partner formano una coppia e le loro vite si incrociano a vari livelli: sentimentale, economico, sociale.
Il soggetto con narcisismo patologico agisce per isolare l’altro dalla propria famiglia, dai suoi amici, dal lavoro. A livello individuale agisce facendolo sentire sempre più fragile attraverso l’uso della critica, che dapprima usa in modo sottile, poi sempre più pesante. Socialmente il narcisista è molto apprezzato, pertanto se il partner si lamenta con la sua famiglia o con le persone che ha come punto di riferimento, queste tenderanno a sminuire le sue osservazioni.
Fase 3 – Distruzione dell’altro
Il narcisismo patologico emerge con tutta la sua forza e il soggetto diventa più esigente, violento, geloso e distante.
A questo punto della relazione, è già riuscito a far sentire l’altro una nullità, insicuro di sé, spesso privo di valore. Non è insolito che il narcisista utilizzi violenza verbale e/o fisica.
A livello verbale alterna momenti di dolcezza a momenti di aggressività e sono proprio queste oscillazioni a rendere ancora più dipendente il partner, che si destabilizza e non sa più come comportarsi. Esita a perdonarlo e poi lo perdona pensando che cambierà. Attraverso i maltrattamenti (psicologici, emotivi e molto più raramente fisici) il partner si paralizza, perdendo così le proprie capacità.

Narcisismo patologico
Narcisismo patologico
Il concetto di eccessivo amor proprio è stato da sempre riconosciuto e preso in esame nel corso della storia, ma solo in tempi recenti è stato definito in termini psicologici.
La parola “narcisismo” proviene dal mito greco di Narciso. Quest’ultimo, era un bel giovane che rifiutò l’amore della ninfa Eco. Come punizione, fu destinato a innamorarsi della propria immagine riflessa nell’acqua. Incapace di vivere e consumare il suo amore, Narciso “rivolse lo sguardo rapito nello specchio d’acqua, ora dopo ora”. E così venne mutato in un fiore che, ancora oggi, porta il suo nome, appunto il narciso.
Il narcisismo è un disturbo della personalità molto complesso, in cui il soggetto che ne soffre sviluppa una vera ossessione per la propria immagine.
Le caratteristiche cliniche e sintomatologiche sono variabili, ma è sempre possibile riconoscere la tendenza alla considerazione di sé in termini di superiorità e grandiosità nel comportamento, con un costante bisogno di ammirazione. Inoltre, tratto peculiare è la mancanza di empatia, ossia la capacità di riconoscere negli altri la presenza di desideri, bisogni, sentimenti, necessità. A cui si associa la conseguente incapacità di lettura della mente dell’altro.
Il narcisista tende a sfruttare il prossimo per raggiungere i propri scopi, così come a disprezzare il valore dell’operato altrui.
Il narcisismo è però, allo stesso tempo, un tratto della personalità che può essere considerato, entro certi limiti, uno stato assolutamente fisiologico. Per certi aspetti è anche funzionale in alcuni contesti della vita quotidiana. Tuttavia, se quest’atteggiamento psicologico interferisce con i rapporti interpersonali, gli impegni quotidiani e la qualità della vita, può assumere proporzioni tipiche del narcisismo patologico.
Come abbiamo evidenziato, la caratteristica peculiare del narcisismo patologico è proprio la mancanza di empatia. Da questa deriva la convinzione che le proprie esigenze vengano prima di ogni altra cosa. I narcisisti sostengono, inoltre, che il loro modo di vedere le cose sia l’unico giusto universalmente.
Dietro questa maschera, però, il narcisista patologico presenta solitamente una fragile autostima che lo rende vulnerabile a quelle che lui percepisce come critiche.
Spesso, i narcisisti credono, infatti, che gli altri li invidino, e sono ipersensibili alle critiche, ai fallimenti o alle sconfitte. Alla dimensione rappresentata dalla tendenza alla grandiosità, unicità e superiorità, si contrappongono, quindi, sentimenti di inferiorità, fragilità, vulnerabilità e paura del confronto.
Quando si trovano di fronte all’incapacità di soddisfare l’elevata opinione che essi hanno di sé, i narcisisti possono arrabbiarsi. Talvolta sviluppano attacchi di panico, episodi depressivi o, addirittura, possono tentare azioni autolesive.
Le cause del narcisismo non sono ancora ben comprese, ma è condivisa l’opinione che questo disturbo di personalità possa rappresentare il risultato della complessa combinazione di più fattori sociali, psicologici e biologici.
Questi elementi interverrebbero nel corso dello sviluppo dell’individuo, influenzandone il comportamento e il pensiero.
In particolare, il quadro clinico può essere favorito da genitori che credono nella superiorità del futuro narcisista ed attribuiscono grande importanza al successo, criticando eccessivamente le paure e i fallimenti.
Il disturbo narcisistico di personalità può risultare anche dalla crescita in un ambiente familiare incapace di fornire al bambino le necessarie attenzioni. E così, in risposta a tale atteggiamento, il soggetto per riparare la continua minaccia alla propria autostima, svilupperebbe un senso di superiorità e un comportamento con la necessità di costante ammirazione.
Di solito, il disturbo narcisistico di personalità compare negli anni dell’adolescenza o entro la prima età adulta.
Già durante l’infanzia i bambini possono manifestare un atteggiamento narcisista, ma questo può rappresentare semplicemente un carattere transitorio della loro età e non significa che andranno a sviluppare un quadro patologico vero e proprio.
Il trattamento di questo disturbo è centrato sulla terapia cognitivo-comportamentale, con un grande impegno, soprattutto da parte del terapeuta.
Questi deve costantemente automonitorarsi e monitorare la relazione e i vari cicli interpersonali che si possono attivare con il paziente narcisista.
Il trattamento di questo disturbo è particolarmente complesso, in quanto il paziente non sempre è consapevole della propria problematica e dell’effetto negativo che questa provoca nei confronti delle altre persone.
Inoltre, i tratti del narcisismo patologico si sviluppano nell’arco di molti anni, quindi l’approccio terapeutico richiede tempi prolungati.
La partecipazione dei membri della famiglia al trattamento è spesso utile in quanto questi ultimi, pur inconsapevolmente, potrebbero favorire comportamenti tali da rinforzare pensieri e comportamenti problematici del paziente.

Narcisismo e lavoro
Come si comporta un narcisista sul lavoro
Il narcisista non muta nemmeno sul posto di lavoro, qualunque sia la sua mansione e professione.
Ambizione, prestigio, ispirare invidia negli altri, superarli in tutti i modi possibili questi sono i pensieri costanti del narcisista.
I narcisisti sono particolarmente predisposti ad errori di eccesso di sicurezza perché ritengono di essere unici e speciali, tanto da avere il diritto ad ottenere risultati migliori nella vita rispetto agli altri, e di essere più intelligenti e fisicamente attraenti rispetto a quanto essi effettivamente siano.
Per un narcisista l’immagine è tutto, userà qualunque mezzo per elevarla, per portare il suo prestigio, sociale e lavorativo, sempre più in alto.
Per tastare la validità del suo operato ha bisogno di un pubblico assecondante, non semplici persone, ma veri e propri ammiratori, adulatori ed estimatori che sono incantati dalle sue parole e dai suoi racconti, dalle sue gesta e dalle sue svariate esperienze, capacità e attitudini, che poi non corrispondono al vero.
Egli è un personaggio costruito sulla falsa rappresentazione di sé, che sfrutta in ogni ambito, perché in realtà si sente un debole. Il suo senso di sé è grandioso, con desiderio costante di ammirazione, mentre si mostra manipolatore e poco empatico, pur godendo di molto fascino.
Generalmente, infatti, i narcisisti sono i più apprezzati dagli altri e considerati molto attraenti e seducenti, anche da un punto di vista estetico.
Tendenzialmente, infatti, sono persone molto curate, con un look molte volte ricercato ed eccentrico.
Anche il loro comportamento verbale gioca un ruolo: i movimenti, le espressioni del viso, il tono della voce. I narcisisti, infatti, sono molto abili nei contesti sociali, addirittura divertenti!
La loro spiccata tendenza ad essere autoritari, li rende ottimi leader e per questo ammirati, anche come “esempio da seguire”.
Il narcisista è tendenzialmente vendicativo; difficilmente dimentica e non è incline al perdono perché non trova benefici nel farlo. Risolvere i conflitti per lui è quasi impossibile.
Nel caso in cu il narcisista sia il proprio partner si può tentare di escluderlo dalla propria vita, anche se ciò costituisce fatica.
Più complesso è quando si è costretti a conviverci; quando il narcisista è il proprio datore di lavoro o un collega di lavoro, ad esempio.
A quel punto, partendo dal presupposto che i narcisisti si sentono appagati solo quando acclamati e lodati, occorre scendere a compromessi ed esaudire il loro desiderio di ammirazione.
Pur sembrando questo un atteggiamento poco autentico da adottare, talvolta non si hanno alternative, se non questa necessaria condotta comportamentale al loro cospetto, che poi paradossalmente rimane l’unica opzione per assecondare il loro sconfinato ego.
Dietro la maschera di sicurezza e di egocentrismo, nel narcisista si nasconde in realtà una persona fragile e vulnerabile, che non riesce a vivere senza l’approvazione e il riconoscimento degli altri. E che ha dentro di sé una ferita narcisistica.
“È un buco nel cuore del narcisista, una ferita aperta e antica, una voragine prodotta alle origini da un genitore che non ha visto, che ha manipolato e che non ha amato”.
Questa ferita narcisistica provocata dai genitori ha creato un grande vuoto interiore. Durante l’infanzia abbiamo tutti bisogno di conferme, di sentirci considerati e di conseguenza amati.
Spesso questa riprova non c’è, anzi arrivano risposte invalidanti e questo crea una ferita narcisistica. Tuttavia questa ferita narcisistica sarebbe necessaria per lo sviluppo del bambino, ma come tutte le fasi è destinata a passare. Rimanere legati alla fase narcisistica porta necessariamente dei problemi.
Se sono centrato su me stesso e sui miei bisogni, tanto da non vedere l’altro, difficilmente potrò avere relazioni stabili e durature.
Quindi, la ferita, che lavora a livello inconscio, riguarda soprattutto un mancato riconoscimento, di tipo affettivo. I genitori di questi bambini feriti hanno messo in primo piano solo sé stessi, provocando un disconoscimento dei propri bisogni, dell’affettività e in generale al proprio esserci.
Quando le aspettative idealizzate al proprio interno, non trovano riscontro nella realtà, il narcisista si sente ferito, rivive la delusione derivata dal mancato riconoscimento in età infantile e si genera una rabbia che non gli permette di sviluppare la capacità di capire il punto di vista altrui e di attivare comportamenti costruttivi e funzionali per superare la ferita.
Si assiste quindi alla ricerca incessante di ciò che manca, come se il soggetto riproponesse di continuo la delusione infantile, auto sabotando ogni tipo di cambiamento.
Le emozioni predominanti, oltre alla rabbia verso chi non ha soddisfatto un bisogno, sono in genere di vergogna ma anche, per compensazione, di grandiosità e onnipotenza.
Per cui nel contesto di lavoro per sopravvivere ad un narcisista è importante prima di tutto evitare lo scontro. Il narcisista interpreta le relazioni interpersonali come uno scambio, basate sul “dare e avere”.
Riuscire a far collimare i propri obiettivi con i suoi potrebbe essere un ottimo modo per creare un’alleanza. Una strategia vincente.
Inoltre, dal momento che il narcisista ha una costante necessità di generare ottima impressione sull’altro, potrebbe rivelarsi un ottimo collaboratore in un team lavorativo, per facilitare e raggiungere gli obiettivi prefissati.
Quando si incontra quindi un narcisista soprattutto nel contesto di lavoro è cosa buona allearsi alle parti più produttive di lui e assecondarlo per facilitargli questa espressione finalizzata agli obiettivi preposti.
La mediazione, la tolleranza, la considerazione e l’apprezzamento del suo operato sono le uniche espressioni comportamentali che possono facilitare il relazionarsi con lui.

Pandemia e adoloscenti
Pandemia e adolescenti, le nuove emozioni da gestire Paura, tristezza e rabbia per la ridotta socialità, in un tempo di formazione. Opportuna una giusta distanza dagli eventi. Limitare il flusso di informazioni.
La pandemia da Covid-19 ha costretto le popolazioni ad adeguarsi a nuove norme di comportamento, una tra tutte il distanziamento sociale che ci fa guardare all’altro con sospetto e timore.
È il caso di adulti che hanno paura di uscire di casa perché percepiscono gli estranei come una minaccia ma altrettanto sono stati condizionati i bambini, specie i frequentatori del nido, che hanno mostrato nuovamente risposte ansiose alla separazione dai propri genitori, superate da tempo.
Alcuni studiosi parlano di “trauma collettivo” che avrà delle ricadute sulla salute mentale di adulti e bambini.
In questo triste scenario, non si può evitare che il pensiero vada ai giovani e al loro futuro. Privati di sport e attività aggreganti, con lezioni scolastiche virtuali, hanno visto restringersi il proprio spazio vitale e di socialità così necessario specie nel periodo adolescenziale.
Anche le famiglie, impreparate a queste nuove modalità, hanno dovuto reinventarsi equilibri e organizzazioni del tempo, sovente con disagio e aumento di fattori stressanti. Una delle possibili conseguenze è l’accumulo di emozioni negative che impedisce e/o interferisce con una gestione adeguata della vita sociale, facilitando perdita di interesse ed isolamento, frustrazione ed aggressività.
Esposti precocemente alla paura della morte e della malattia, i più giovani hanno vissuto in un costante stato di allarme che ha scatenato o peggiorato sintomatologie ansiose e/o depressive, modificando il loro modo di approcciarsi alla vita.
La quarantena ha comportato l’impossibilità di socializzare se non attraverso i canali tecnologici. Un’altra difficoltà ha riguardato gli spazi, nel senso che ci si è trovati in una convivenza forzata e in case spesso prive di spazi adeguati a garantire la privacy.
I ragazzi si stanno confrontando con una situazione inaspettata in un tempo di formazione personale e se, all’inizio, il tutto era associato alla stranezza, al gioco, ora sembrano più obiettivi e disillusi.
E allora, come intervenire?
La nostra esperienza ci mostra come lamentarci non porti alla soluzione e non predisponga all’azione. Sarebbe opportuno trovare una giusta distanza emotiva con gli eventi della realtà, che ce la facciano vivere senza fonderci o, al contrario, disconnetterci con essa.
Un atteggiamento (spesso inconsapevole) da evitare è camuffare la paura con la rassegnazione; questa porta frustrazione e può sfociare nella depressione. In realtà la paura è una emozione che ci mette in allerta quando ci troviamo di fronte a un pericolo e quindi risulterebbe un errore non riconoscerla e non ascoltarla.
Quindi, dopo averla riconosciuta, la paura si affronta con una maggiore conoscenza del problema per poterne trarre le giuste rassicurazioni e attuare comportamenti adeguati alla situazione.
La gestione di questo periodo si sta rivelando molto difficile sia per i giovani, i genitori, gli insegnanti e gli adulti in generale.
Ne è stata colpita e influenzata ogni fascia d’età con tutte le ripercussioni del caso. Bambini e adolescenti, meno strutturati e per questo più fragili, sembrano al momento essere la fascia più penalizzata.
Con la chiusura di alcune scuole, delle discoteche e di tutti i luoghi di aggregazione, gli adolescenti hanno dovuto fare i conti con una realtà potenzialmente destabilizzante e in grado di suscitare sentimenti ed emozioni contrastanti: dalla paura all’indifferenza, dalla tristezza alla rabbia.
In generale, ancor più in questo equilibrio da ritrovare, bisogna imparare ad aver cura di sé e della propria salute mentale. Il primo passo è “normalizzare” l’ansia e tutte le emozioni contrastanti sperimentate, tramutando il loro significato negativo in opportunità per permettere di conoscersi meglio e comunicare a noi stessi e agli altri come ci sentiamo e di cosa abbiamo bisogno.
Dobbiamo imparare a riconoscere e accettare le nostre emozioni così da poterle gestire e usare come risorse.
La confusione e l’impotenza sono vissuti che possono aumentare la sensazione di paura e ansia e quando, come in questo periodo storico, siamo esposti a una serie di informazioni allarmanti, non sempre siamo in grado di riconoscere le notizie attendibili da quelle fuorvianti.
Da qui la necessità di limitare il flusso di informazioni, di affidarsi a fonti ufficiali e attenersi alle regole sanitarie.
Il disagio vissuto dagli adolescenti è stato potenziato da questa seconda ondata di forti restrizioni in un momento in cui, piano e con fatica, si stava cercando di tornare alla “normalità”.
Ogni momento di crisi ha bisogno di un cambiamento e dobbiamo incoraggiare la disponibilità individuale a mettere in discussione le vecchie strategie di gestione delle difficoltà, con azioni maggiormente appropriate al caso.
Ogni soggetto sviluppa la sofferenza a modo proprio, ma è importante non perdere di vista il futuro: per quanto sicuramente diverso da come ce lo eravamo immaginato, il nostro futuro ci sarà. (Lucia Calabrese, psicoterapeuta e sessuologa)

Paura vaccini
La pandemia COVID-19 ha generato stati di ansia e turbamento in ampie fasce della popolazione, paura che si riflette anche nel discorso sulla campagna vaccinale in corso.
Le ragioni principali per le quali le persone non intendono vaccinarsi includono i possibili effetti collaterali e la preoccupazione che gli studi clinici siano stati condotti troppo in fretta.
In un momento come questo dovrebbe emergere una sensazione di fiducia nei confronti di figure autorevoli, quali scienziati, medici o ricercatori, ma sembra che a prendere il sopravvento, in questi ultimi mesi, sia stata la diffidenza.
Tra tensione e incertezza sono entrati in gioco diversi fattori volti a minare un senso di fiducia invece indispensabile. In particolare, ad esempio, dall’inizio della pandemia, ci siamo abituati a un bombardamento mediatico di realtà di volta in volta presentate come ‘assolute’, ‘scientifiche’ e che, nonostante siano espresse da professionisti autorevoli, spesso si contraddicono. Uno stile comunicativo insomma, che ha contribuito a creare diffidenza, legato alle modalità di disinformazione o mis-informazione,con cui oggi tante volte si diffondono le notizie.
In particolare, i social media hanno democratizzato la possibilità di dire la propria opinione, ponendo tutti i giudizi sullo stesso piano, e contribuendo a una diffusione molto veloce delle fake news.
Tutto questo in un momento di cambiamento, di crisi e di instabilità, tutti aspetti che attivano il nostro sistema emotivo, che è portato all’allerta, all’allarme, alla percezione della minaccia.
Da questo punto di vista, dunque, le persone sono più portate a cogliere le informazioni che riguardano pericoli e minacce, rispetto a quelle rassicuranti. Un mix di fattori che ha come risultato una crescente diffidenza.
Eppure i vaccini sono una delle conquiste più importanti della medicina e uno strumento fondamentale di tutela della salute pubblica. Purtroppo però, nonostante le evidenze scientifiche, i vaccini continuano ad avere detrattori e molte persone ne hanno paura.
E’ una questione questa che non riguarda solamente COVID-19, ma le vaccinazioni in generale. Sono moltissime le voci e le leggende in tema di vaccinazioni e l’argomento è, recentemente, tornato di grande attualità.
Nonostante gli innegabili benefici che le vaccinazioni hanno portato e portano tuttora all’umanità, non pochi sono gli oppositori.
In questa esitazione nell’approcciarsi ai vaccini ci sono vari fattori determinanti. Uno è sicuramente rappresentato dalla paura di eventi avversi, per quanto siano molto rari.
Questo perché la sensazione di paura dipende molto dalla percezione di avere o meno controllo su una determinata cosa: sottoporsi a un vaccino espone alla percezione di non avere il controllo su quello che succede.
Il primo ostacolo “psicologico” è che, con la vaccinazione, sto facendo un atto medico volontario e attivo a una persona sana.
La percezione dei rischi viene ingigantita dal fatto che ci stiamo dando la possibilità anche remota, di avere effetti collaterali per una minaccia (la malattia contro cui ci vacciniamo) che al momento della vaccinazione non abbiamo, perché siamo sani, e che percepiamo come lontanissima e, quindi, di fatto, impossibile da contrarre.
Si tratta di una comune distorsione cognitiva: noi non vediamo più i danni di moltissime malattie infettive nella nostra vita quotidiana, proprio perché la coperture vaccinali di massa le hanno eliminate, mentre percepiamo ben più concreti e probabili i rischi degli effetti collaterali.
Può capitare addirittura che a esprimere incertezza sulle vaccinazioni sia una persona che lavora con la sanità, a dimostrazione che questo tipo di paura nasce davvero da una parte irrazionale ed emotiva dell’essere umano.
Le motivazioni del rifiuto fanno capo a meccanismi psicologici e cognitivi inscritti nella natura umana, in parte legittimi e comprensibili.
Anche se bisogna considerare altri fattori che concorrono a questa preoccupazione: la paura delle vaccinazioni, infatti, è anche correlata alla fiducia o alla sfiducia nelle Istituzioni.
In alcuni casi si tratta di un rifiuto costruito sulla base di informazioni errate, e qui la corretta informazione scientifica può dare una grossa mano.
E, insieme ad essa sarebbe importante impostare dialogo e partecipazione consapevole tra medici, istituzioni e cittadini. Ci vuole tempo, fatica e duro lavoro di mediazione, ma questa via appare come l’unica che, alla lunga, può dare i suoi frutti.

Relazioni tossiche
Relazioni tossiche: un amore che può far male
Le relazioni, in particolare quelle sentimentali, dovrebbero essere per l’individuo fonte di benessere!
Molte volte, invece, non è così, anzi, queste relazioni invece di stimolare un confronto di crescita tra i partner, provocano solo senso di insicurezza, inadeguatezza, malessere, fino ad arrivare a vere e proprie vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate da uno dei due partner a discapito dell’altro.
Si entra in questo tipo di relazioni spinti dal bisogno di colmare un vuoto. Quel bisogno che l’altra persona possa colmare quel senso di vuoto che quasi sempre ha radici altrove, nella propria storia, nell’infanzia.
Generalmente le persone che tendono ad avere una relazione tossica hanno una profonda incapacità di vivere la solitudine, infatti, non la considerano un’opportunità, ma una condizione da cui fuggire in modo fobico.
Questo ha un’origine specifica nelle carenze che le persone dipendenti hanno vissuto con chi si è preso cura di loro durante l’infanzia.
Si tratta di un vissuto che ha a che fare con l’abbandono, con il non riconoscimento e con il rifiuto, e pur di non riviverlo, il dipendente affettivo è disposto ad accettare le condizioni più umilianti e mantenere il rapporto.
Chiaramente il primo segnale è proprio la relazione di dipendenza.
La persona affettivo-dipendente che si trova in questa relazione generalmente tende ad affidare al proprio partner tutte quelle funzioni di autoregolazione che dovrebbe poter assolvere anche da sola.
In questo modo l’altro diventa indispensabile, ad esempio per la regolazione e il mantenimento dell’autostima o per il contenimento degli stati di ansia. L’altro diventa indispensabile anche per un senso di coesione e integrità personale e quindi il suo allontanamento infatti viene vissuto come se si andasse in pezzi.
Le relazioni tossiche non si verificano solo nelle relazioni di coppia. Possono di fatto nascere anche tra membri della stessa famiglia, tra amici o colleghi di lavoro e il legame insito in esse rende molto difficile la rottura con loro.
Non esiste un profilo chiaro o marcato che possiamo scorgere nel dettaglio sul tipo di persona che capita in questo tipo di relazione, ma troviamo alcuni tipi di relazioni tossiche che sono le più comuni e in cui possiamo cadere.
Quando una relazione è tossica?
La tossicità inizia a formarsi quando la relazione diventa disfunzionale e può manifestarsi in molti modi diversi.
Il primo passo per prendere coscienza di una relazione tossica è quello di porsi alcune domande:
• Come posso riconoscere una relazione tossica?
• Come poterne uscire?
• Perché ci si ritrova sempre in relazioni tossiche?
È proprio in questi momenti che la prima, e più importante, risposta è la domanda.
Se vivere sentimenti di sofferenza può diventare l’occasione per interrogare il rapporto tra sé e la propria relazione, le domande sono lo strumento che può generare una possibilità di cambiamento.
E così, ascoltare le proprie risposte mette in condizione di avere un’altra prospettiva in cui la relazione può liberarsi da questa immobilità che tanto influenza presente e futuro.
Porsi queste domande permette di passare da una “fotografia statica” della relazione, dove le uniche possibilità di azione rimangono quelle di “disintossicarsi”, a un “video dinamico” in cui diventa possibile riconoscere il ruolo e le responsabilità di tutte le persone coinvolte.
Nell’immaginare un’altra storia, si creano le condizioni per ampliare le proprie possibilità di scelta considerate come cristallizzate dalla “tossicità” della relazione. “Girare il video” della propria storia rende possibile creare una storia “generativa” di possibilità, dove anche il rendersi attore attivo della propria vita può diventare un’ipotesi non solo desiderabile ma anche da perseguire.
Le relazioni tossiche possono essere gestite con sani confini, cura di sé e consapevolezza.
Intanto è fondamentale mettere in atto una serie di comportamenti che non facciano ricadere nella relazione.
La prima cosa da fare è valutare di interrompere ogni comunicazione, il cosiddetto metodo del contatto zero. Per farlo, è necessario cessare tutti i tipi di comunicazione con l’altra persona.
Imparare ad auto gratificarsi è poi fondamentale; circondarsi delle persone giuste anche.
Dimenticare un amore tossico è faticoso. Spesso dopo aver lasciato qualcuno, si inizia a sentirne la mancanza.
È facile ricordare i momenti belli e dimenticare le parti logoranti di una relazione. Può sembrare allettante che la persona, ma è importante mantenere la propria decisione che è stata presa per migliorare la propria vita.
E, principalmente,guarire da una relazione tossica significa anche perdonarsi e non diventare vittima di quello che ci è successo.

Resilienza e covid
STRESS E RESILIENZA IN TEMPI DI PANDEMIA…una voce dalla letteratura
L’attuale condizione che stiamo vivendo legata alla pandemia da coronavirus si sta delineando come un evento ad alto impatto emotivo, che, proprio per aver investito la collettività in modalità senza precedenti, sta andando molto spesso a generare reazioni tipiche da stress.
Gli elementi che da un punto di vista psicologico rendono questa situazione un evento molto stressante sono molteplici.
L’aspetto centrale è quello della potenziale minaccia per la propria ed altrui salute: il peso della scarsa prevedibilità associata al contagio, la scarsa conoscenza del virus e le conseguenti inevitabili informazioni talvolta contraddittorie, soprattutto nella fase iniziale, hanno aumentato il senso di smarrimento di fronte ad un nemico “non controllabile”.
Inoltre, le modalità adottate per la prevenzione e la protezione dei cittadini, essenzialmente basate sul distanziamento sociale e l’interruzione delle normali attività di vita, hanno inevitabilmente prodotto un aumento della paura, rafforzata anche dall’esposizione telematica a immagini o notizie altamente stressanti.
La riduzione della progettualità individuale e l’isolamento sociale, hanno reso le misure di tutela della propria salute potenzialmente generatrici di vissuti opposti. Da una parte sicurezza e controllo, ma dall’altra rabbia e frustrazione.
Da un punto di vista psicologico, le classiche fasi di risposta ad un evento stressante sono caratterizzate da una prima risposta acuta , ossia la fase della presa di coscienza della vulnerabilità.
Successivamente, da una fase di risposta (fase dell’azione) in cui l’individuo sposta l’attenzione dalla vulnerabilità su di sé alla fonte di pericolo esterno. Infine da una fase di sopravvivenza (fase del controllo) in cui la persona mette in gioco le proprie risorse per far fronte al problema.
In questo caso infatti si parla di ‘stress acuto’, al cospetto di un evento stressante singolo e di durata limitata.
Quando invece la fonte di stress permane nel tempo si parla di “stress cronico”.
Dobbiamo constatare, purtroppo, che l’attuale situazione pandemica da coronavirus è tutt’altro limitata e singola.
Ci stiamo convivendo e ne siamo esposti ormai da mesi. L’emergenza sta ancora continuando, in parte nella forma epidemica, in parte attraverso le sue conseguenze.
Siamo ancora ben lontani dal poter ipotizzare e considerare una completa smobilitazione dall’emergenza: nell’emergenza siamo ancora immersi. Di conseguenza, siamo anche ben lontani dal poterci pensare di nuovo al sicuro e protetti.
La risposta, o meglio, una delle risposte più idonea e adeguata a fronteggiare l’emergenza, è rappresentata dalla capacità di resilienza.
In psicologia la resilienza viene vista come la capacità di affrontare i traumi della vita, di superarli e di uscirne rinforzati e addirittura trasformati positivamente.
Le caratteristiche essenziali della resilienza sono la competenza ed il controllo durante la condizione di stress causato dal trauma (capacità di far fronte o coping).
Un processo dinamico dove le persone mostrano un adattamento comportamentale positivo quando si trovano a dover fronteggiare un’avversità significativa o un trauma .
Una volta definito che cos’è la resilienza è utile capire come è possibile potenziarla.
Infatti, anche se la resilienza sembra essere naturalmente insita negli esseri umani, essa può essere ulteriormente appresa e migliorata nel corso dell’esistenza di ciascuno.
Nessuno può fornirci una buona dose di resilienza, siamo noi a doverla trovare imparando a coltivarla.
Ognuno di noi ha delle reazioni emotive e fisiche agli eventi, condizionate dalla nostra interpretazione dell’evento stesso. Nel momento in cui siamo in grado di intervenire nella reazione automatica e irrazionale entra in gioco la resilienza.
Allenare la nostra resilienza è un invito a fermarsi e riflettere per chiedersi che cosa ci sta accadendo in quel momento e provare a trovare un significato all’evento.
Può trattarsi di un’attitudine, di un talento, di una risorsa positiva, di una qualità che ci appartiene. Una volta scoperta, possiamo perfezionare quella qualità e pensare all’ambito della nostra vita in cui la utilizziamo naturalmente per estenderla anche alla situazione problematica che stiamo vivendo. In questo modo è possibile un cambiamento.
La natura può aiutarci a capire ancora meglio cos’è la resilienza, soprattutto quando incontriamo poeti che, cantando le bellezze naturali ci fanno notare ciò che potrebbe sfuggire ad un nostro sguardo.
Giacomo Leopardi nella poesia “La Ginestra o il fiore del deserto” ha posto la sua attenzione su una pianta che riesce a crescere anche negli ecosistemi più impervi. Cresce sulle pendici dei vulcani e nonostante la lava che brucia e desertifica, rinasce con i suoi fiori gialli dal profumo intenso. Una metafora della lotta per sopravvivere e affermare la vita, pur trovandosi in una condizione ostile.
La ginestra è il simbolo della condizione umana. E, come la pianta si piega per riuscire a sopravvivere, allo stesso modo l’uomo deve essere flessibile per adattarsi al cambiamento.
Nell’attuale stato di emergenza da coronavirus viviamo una condizione unica e sappiamo che le cose non torneranno come prima, almeno non nell’immediato. Ne deriva che tutti noi oggi dobbiamo essere flessibili per adattarci a circostanze che cambiano velocemente, tollerando un certo grado di incertezza.
Leopardi nella stessa poesia invita gli uomini ad unirsi per affrontare le difficoltà che l’esistenza umana riserva e anche in questo caso è possibile ricavarne uno spunto per potenziare la resilienza.
Si tratta di un invito alla solidarietà umana, a potenziare la capacità di cooperazione poiché il sostegno di una rete sociale è fondamentale nelle situazioni di difficoltà.
L’atteggiamento da promuovere è quello di “un giorno alla volta” in cui le esperienze positive possono essere programmate nel breve termine, con un focus attento e consapevole rispetto a ciò che proviamo qui ed ora.
Tutto ciò insieme ad un altro potente antidoto al senso di vulnerabilità, attraverso l’ingaggio sociale, che si traduce nella ricerca di ascolto e condivisione con persone a noi fidate.
L’uomo infatti è programmato biologicamente per cercare conforto sociale quando è sotto stress.
Il COVID-19, e tutto ciò che ne è conseguito, è stata un’esperienza straordinaria, che non dimenticheremo e che, come tutte le esperienze non comuni, ci ha permesso di vivere la vita e le relazioni in modo nuovo: non si è quindi trattato solo di un trauma, che può essere o meno superato a seconda che si abbia più o meno resilienza, ma di un processo di conoscenza di se stessi, degli altri e della relazione tra noi e gli altri che avrà tanto più valore quanto più non verrà dimenticato.

Revenge porno
REVENGE PORN
La tecnologia (internet, social media) ha rivoluzionato la nostra capacità di comunicare, di scambiare informazioni, di costruire relazioni.
Allo stesso modo ha apportato enormi vantaggi: pensiamo all’importanza che ha per ognuno di noi,ed in particolare attualmente, in un periodo storico come quello che stiamo attraversando.
Infatti, mentre una pandemia ci ha costretto a limitare potentemente i nostri contatti sociali, poter disporre di strumenti tecnologici ci ha fatto sentire meno soli e ci ha offerto la possibilità di continuare a vivere relazioni sia in ambito lavorativo che personale.
L’uso diffuso dei social ha cambiato potentemente la comunicazione gli uni con gli altri e la scelta del tipo di informazione da condividere.
Purtroppo però ci sono anche degli svantaggi e così, sfortunatamente, la tecnologia ha anche favorito la diffusione di informazioni in modi negativi e dannosi contribuendo a influenzare il panorama della violenza.
Una forma crescente di violenza indotta dalla tecnologia è il cosiddetto abuso sessuale basato sulle immagini, termine generico utilizzato per descrivere qualsiasi immagine o video sessualmente esplicito creato e/o distribuito senza il consenso della persona ritratta.
Tale macrocategoria include la pornografia non consensuale, all’interno della quale rientra il revenge porn.
Il termine inglese indica la cosiddetta “vendetta pornografica”, Infatti, il revenge porn ha spesso origine come forma di vendetta.
Le ragioni che muovono quest’azione possono essere il vendicarsi di un torto subito, quale ad esempio l’infedeltà reale o immaginaria o l’interruzione della relazione, assurgendo così l’atto di revenge porn a una forma legittima di vendetta interpersonale che implica una forma di punizione e controllo.
Il materiale oggetto del revenge porn può essere anche stato realizzato dalla vittima: infatti, se nell’ambito di una relazione si invia un video intimo, e, se questo stesso contenuto viene diffuso senza il nostro consenso, si parla di revenge porn.
Allo stesso modo se è materiale realizzato all’insaputa della persona (es. con una telecamera nascosta) o se è frutto di un gioco/piacere che però è stato approvato solo nella sfera intima della coppia.
Tuttavia,nonostante la definizione faccia riferimento ad un atto di vendetta, la diffusione di contenuti sessualmente espliciti può avvenire per motivi differenti.
Inoltre, il termine “vendetta” tende a spostare l’attenzione su un comportamento sbagliato da parte della vittima e quindi a colpevolizzarla. In un qualsiasi tipo di violenza però, è bene ricordare, che una vittima è e rimane tale e non ha mai alcuna responsabilità per ciò che subisce.
Il revenge porn può essere definito a tutti gli effetti una forma di violenza che è diventata un reato solo pochi anni fa.
Entrambi i sessi sono colpiti dalla vendetta pornografica ma, generalmente più dell’80% delle vittime sono donne spesso perseguitate da ex fidanzati o ex mariti. Coloro che compiono il reato lo fanno sapendo bene che il gesto avrà come conseguenza la gogna mediatica e la distruzione non solo della reputazione, ma spesso anche della vita.
Le vittime vengono infatti dilaniate dal senso di vergogna causato da un’intimità violata. Per quanto riguarda le donne, le conseguenze sono spesso peggiori perché l’imbarazzo è accresciuto dal pregiudizio comune che non possano vivere liberamente la propria sessualità.
Indipendentemente dalle motivazioni sottostanti è importante sottolineare, come già accennato, che si tratta di un reato che esiste da qualche anno.
La norma parla di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate e tale reato è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Due sono gli elementi di offesa: il non consenso della vittima e il fatto che il contenuto sia di natura intima o sessualmente esplicito.
È però necessario precisare che i dati non possono essere considerati mai del tutto reali perché spesso chi subisce umiliazioni di questo genere ha paura di denunciare, teme un’ulteriore violenza e preferisce proteggersi dall’imbarazzo tacendo.
Il revenge porn può avere un forte impatto emotivo sulle persone coinvolte.
Parte dell’impatto è sicuramente legato all’emozione di colpa: lo scenario che possa venir detto loro che avrebbero dovuto conoscere i rischi quando hanno inviato quelle foto corroborerebbe l’idea di aver in qualche contribuito alla violenza.
Come con altre forme di abuso sessuale, le vittime di pornografia non consensuale e revenge porn possono avere conseguenze a livello fisico e mentale. Sebbene la pornografia non consensuale sia sempre più riconosciuta come una forma di abuso sessuale il fatto che sia perpetrata non usando la forza fisica può rendere le vittime meno inclini a etichettarla come violenza sessuale.
Si tratta di un danno continuo e di lunga durata in cui le vittime vivono costantemente la paura di essere riconosciute, il non sapere chi e quanti possano aver visto le loro foto e tutto questo può andare potentemente a interferire negativamente nel proprio funzionamento quotidiano.
Aumentare la consapevolezza del fenomeno del revenge porn permette di promuovere un crescente riconoscimento di quanto la tecnologia sia uno strumento sempre più utilizzato per molestare, intimidire, umiliare gli altri. Solo così le vittime possono essere pienamente supportate, a livello psicologico e legale, e incoraggiate a farsi avanti.
Sebbene il revenge porn è sempre più all’attenzione dei media, anche in seguito a vicende di cronaca, potrebbero esserci persone che non sono consapevoli che si tratti di un reato. Di conseguenza non saranno a conoscenza delle procedure in atto per proteggersi nel caso in cui diventassero vittima.
La criminalizzazione di ogni forma di diffusione di materiale sessuale senza il consenso della vittima è essenziale visto che le conseguenze psicologiche e fisiche sulle vittime sono analoghe a ogni altra forma di violenza e abuso sessuale.

Sessualità e coronavirus
L’amore e il sesso al tempo del coronavirus
Sappiamo quanto in periodi di paura, di forte tensione, la sessualità sia una forma di conforto, di rassicurazione.
Purtroppo però in questo lungo periodo che stiamo vivendo, anche questa espressione ci deve vedere cauti e rivolti ad utilizzare ancora più di prima comportamenti consapevoli quando ci avviciniamo all’altro e all’incontro sessuale.
L’esperienza erotico-sessuale è libertà di movimento, espressione di emozioni che non possono essere bloccate, chiuse e soffocate. In questo momento storico che stiamo vivendo a causa del Covid 19, la fase del desiderio sembra una delle più colpite.
In questo momento dove tutti siamo tenuti a forti restrizioni preventivo-sanitarie, le coppie e i single stanno affrontando la dimensione sessuale in modo disagevole e comunque lontana dalle piacevoli esperienze della quotidianità che abbiamo sempre conosciuto.
Questo momento, insieme al lockdown, ha prevalentemente acuito vissuti depressivi e ansiosi, inibendo proprio la componente appetitiva della sfera sessuale e affettiva.
Allo stesso tempo però possiamo tentare di fare una serie di considerazioni che ci conducono ad altri scenari fortunatamente possibili: proviamo, infatti, anche a pensare che, il tempo dedicato alla intimità sessuale, pur quando inibito per timore, possa essere stato impiegato per sviluppare un altro tipo di intimità, quella emotiva, data dal parlarsi, dal parlare di sé, di come stiamo, di come stiamo vivendo questo momento e di cosa ci piacerà fare quando tutto sarà finito.
Saranno queste considerazioni a farci riflettere quindi, che non sarà un tempo inutile e ci aiuterà a mantenere un filo rosso con l’altro.
Nella fase del lockdown ad esempio, molti hanno registrato un incremento del desiderio sessuale: in questo caso, è possibile che la sessualità sia stata utilizzata dalle coppie e dagli individui per gestire e modulare l’intensità delle emozioni legate alla pandemia.
E’ importante allo stesso tempo sottolineare che l’aumento del desiderio e della frequenza dei rapporti, comunque, non corrisponde necessariamente ad una maggiore soddisfazione sessuale.
Per alcuni individui, questa condizione ha costituito terreno fertile per l’intensificarsi di disagi preesistenti.
Per cui, la vita sessuale è stata influenzata a seconda delle condizioni psicologiche e degli stili di personalità, del contesto relazionale (ad es. essere single, in una relazione di convivenza o meno, con la presenza di conflittualità nella coppia o la possibilità di mantenere un proprio spazio di privacy) e di fattori socio-economici.
Sicuramente ansia e paura avranno rappresentato un ostacolo al benessere generale della persona fino ad avere delle ricadute sulla sfera sessuo-affettiva.
Sperimentare un certo disagio emotivo però, può costituire una reazione “sana” al periodo critico che stiamo vivendo, soprattutto se il disagio ci spinge ad adottare comportamenti di prevenzione efficaci per gestire una determinata problematica.

Solitudine e isolamento sociale ai tempi del Covid
La pandemia da Covid-19 ci ha portati a rendere protagonista il concetto di distanziamento “sociale”, a fronte di quello più appropriato di distanziamento “fisico”.
E così, parlare di distanziamento “sociale” ha inciso negativamente sull’esperienza soggettiva e psicologica delle persone, in quanto questo termine suggerisce l’idea dell’isolamento relazionale dagli altri, e quindi di solitudine.
Da sempre le relazioni hanno costituito dei fattori protettivi per il benessere e dei predittori di resilienza e adattamento a seguito di eventi disastrosi di varia natura.
Ed è proprio l’ambito delle relazioni che in questo momento concentra su di sé gran parte delle attenzioni: tra le conseguenze più evidenti della diffusione del virus e delle misure messe in atto per il suo contenimento, emerge che siamo stati e siamo tuttora costretti a modificare il nostro modo di vivere e gli scambi con gli altri, mentre tutto questo ha un impatto notevole sulla nostra vita interiore.
Questa condizione ha imposto in ognuno un cambiamento di cui non si conoscono ancora le conseguenze, ma del quale si avverte notevolmente la portata.
L’essere umano nasce in relazione: senza una relazione, non è possibile non solo la nostra sopravvivenza fisica, ma anche quella mentale.
Questa consapevolezza istintiva rimane con noi per tutta la vita, e si declina in modi personalissimi e irripetibili a seconda della storia di ognuno di noi. Allo stesso modo, però, portiamo dentro l’istinto di sopravvivenza che invece in questo momento ci dice che dobbiamo rinunciare al contatto ravvicinato e a tutto ciò che con esso ha a che fare.
Ciò che ne viene fuori è un conflitto molto concreto, duro e quotidianamente presente, acuito dall’incertezza riguardo il futuro e dalla paura.
Per tutti, si tratta di affrontare qualcosa di ignoto, e di costruire un nuovo modo di essere che sia sufficientemente confortevole.
Allo scopo di normalizzare questo evento, allontanandolo dal trauma e avvicinandolo alle esperienze umane, è importante prima di tutto che ognuno possa avere accesso a una percezione di sé libera e possa accogliere i propri vissuti soggettivi senza temere che siano sbagliati o fuori luogo.
Non soltanto le categorie condivisibili possono esserci utili contro lo smarrimento, ma anche le nostre personali, quelle che abbiamo costruito nel corso della vita, poiché sono compagne che ci aiutano a riconoscerci e a sentirci stabili.
Gli effetti negativi di questo cambiamento forzato sono molteplici: può aumentare la sensazione di solitudine; si può avvertire la perdita di sostegno emotivo, l’impossibilità di far vivere alcune parti di sé che prima potevano esprimersi all’esterno, con conseguenze importanti sul proprio senso di identità.
Può accadere allora che alcune persone si sentano sopraffatte dall’angoscia, non solo perché esiste un pericolo di contagio fuori, ma anche perché avvertono il pericolo di disintegrazione dentro e hanno paura di non reggere psicologicamente.
Alcune persone si sentono maggiormente disturbate e magari fanno emergere il bisogno di credere di avere un controllo sugli eventi, orientandosi verso la ricerca spasmodica di spiegazioni di qualunque tipo.
Allo stesso modo, questa situazione può anche restituire tranquillità soprattutto se, dopo l’iniziale disorientamento, si riesce ad adattarsi alla nuova situazione iniziando a scegliere e cadenzare routines e abitudini spesso nuove: questa nuova possibilità può fornire sicurezza, sostenendo una solida e ben strutturata rappresentazione di sé, e dando forza alla percezione di un sano senso di competenza.
La rappresentazione mentale positiva di sé e degli altri permette di fare a meno, entro certi limiti, della vicinanza fisica proprio perché l’altro resta accessibile attraverso un Sé più autentico.
La relazione, in questi casi, è dettata dal desiderio e non dal bisogno.
E così, quando l’isolamento non si traduce in un patologico ritiro sociale e in un rifiuto a investire sul mondo, la distanza alleggerisce il timore di venire esclusi, ridimensiona la paura del confronto con gli altri e aiuta a cercare un senso allo stare “da soli” che restituisce, o che permette per la prima volta, l’opportunità di scoprire qualcosa di straordinariamente semplice: la possibilità di occuparsi di sé, in modi e con tempi più flessibili, scegliendo di utilizzare un efficiente sistema di comunicazione a distanza, restando isolati ma senza essere soli.
I vissuti ansiosi e depressivi possono dunque essere modulati dalla scoperta che lo spazio occupato dai propri pensieri è uno spazio di esplorazione di sé, di scoperta di nuovi interessi e passioni, e di apprezzamento di modi nuovi e creativi di partecipazione personale alla propria soggettività.
È importante, ora più che mai, dare spazio a ogni singolo modo di vivere questa difficile situazione.
Riconoscere i propri vissuti, non negarli, permette di accedere a una profondità ricca di risposte inaspettate. Potervi attingere, poter contare su una “soggettività alleata”, ci pone in modo meno spaventato di fronte al nuovo.
Se sapremo andare incontro a questo nuovo il più possibile con apertura e genuina curiosità, riusciremo a creare quel silenzio pronto ad accogliere sì nuove sofferenze, ma anche l’emergere di nuove risorse.
CONTATTI
mail: info@paololandipsicologo.it
Vuoi ricevere maggiori informazioni?
Compila il modulo qui sotto e saremo lieti di risponderti entro 24 ore.